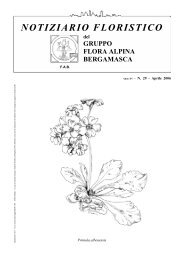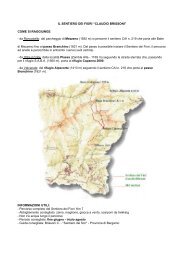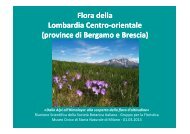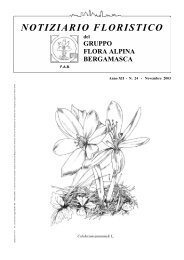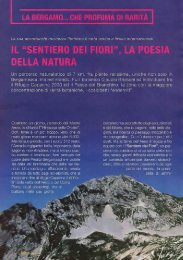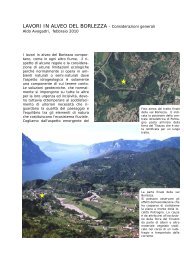IBI 40 Supplemento 1 (2008) - Gruppo Flora Alpina Bergamasca
IBI 40 Supplemento 1 (2008) - Gruppo Flora Alpina Bergamasca
IBI 40 Supplemento 1 (2008) - Gruppo Flora Alpina Bergamasca
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
112 INFORMATORE BOTANICO ITALIANO, <strong>40</strong> SUPPL. 1, <strong>2008</strong><br />
<strong>Flora</strong> da conservare: implementazione delle categorie e dei criteri IUCN (2001) per la redazione di nuove Liste Rosse<br />
Sarcopoterium spinosum (L.) Spach<br />
D. GARGANO, G. FENU, P. MEDAGLI, S. SCIANDRELLO e L. BERNARDO<br />
Nomenclatura:<br />
Specie: Sarcopoterium spinosum (L.) Spach<br />
Sinonimi: Poterium spinosum L.<br />
Famiglia: Rosaceae<br />
Nome comune: Spinaporci<br />
Descrizione. Arbusto nano con giovani getti tomentosi,<br />
rami laterali afilli e spinescenti; foglie imparipennate<br />
con 9-15 segmenti ovati; fiori unisessuati, i<br />
femminili disposti nella porzione superiore ed i<br />
maschili (con 10-30 stami) in quella inferiore di<br />
capolini lunghi fino a 3 cm; calici caduchi, verdastri<br />
con 4 denti (PROCTOR, 1968; PIGNATTI, 1982).<br />
Biologia. Si tratta di una nanofanerofita che in<br />
Italia fiorisce nel periodo marzo-maggio<br />
(PIGNATTI, 1982). La produzione annuale di semi<br />
è normalmente assai elevata così come i tassi di germinazione<br />
(TORNADORE MARCHIORI et al., 1978;<br />
HENKIN, 1994). Comunque la mortalità tra le<br />
plantule è estremamente alta e ben poche di esse<br />
sopravvivono alla seconda estate (HENKIN et al.,<br />
1999). Perciò, si può ritenere che le possibilità di<br />
colonizzazione e persistenza siano essenzialmente<br />
legate alle capacità clonali della pianta (SELIGMAN,<br />
HENKIN, 2002).<br />
Ecologia. Nella porzione orientale del proprio areale<br />
distributivo, S. spinosum domina un ampio spettro di<br />
habitat (EIG, 1946; ZOHARY, 1973), ben sopportando<br />
regimi di elevato disturbo (LITAV, ORSHAN,<br />
1971). In Italia, al contrario, la specie appare generalmente<br />
confinata a formazioni di gariga o macchiagariga<br />
che rappresentano residui di vegetazione<br />
costiera, anche in zone peristagnali o di sedimenti di<br />
fiumara fissati (GEHU et al., 1984; BARTOLO et al.,<br />
1986; BIONDI, MOSSA, 1992; BIONDI et al., 1994;<br />
BRULLO et al., 1997). In Sicilia la pianta colonizza<br />
anche aree collinari più interne, come codominante<br />
in formazioni tipo “frigana” (BARBAGALLO et al.,<br />
1979), la cui espansione è favorita da incendi ed<br />
abbandono dei pascoli.<br />
Distribuzione in Italia.<br />
Regione biogeografica: seguendo PEDROTTI (1996), le<br />
stazioni di S. spinosum rientrano nella regione biogeografica<br />
Mediterranea, ad esclusione della stazione<br />
storica di Tivoli (PIGNATTI, 1982) che, probabilmente,<br />
ricade nella provincia dell’Appennino della regione<br />
Eurosiberiana.<br />
Regioni amministrative: in base a CONTI et al. (2005)<br />
l’areale italiano include Lazio, Puglia, Basilicata,<br />
Calabria, Sicilia e Sardegna.<br />
Numero di stazioni: nel Lazio risulta una sola stazione<br />
dove, comunque, la specie non è più rinvenuta da<br />
tempo (PIGNATTI, 1982). Per la Puglia sono note 4<br />
stazioni, ma in 3 di esse la pianta risulta scomparsa<br />
(CANIGLIA et al., 1974). Lungo la costa ionica settentrionale<br />
della Calabria la pianta è presente in maniera<br />
assai discontinua con ridotti popolamenti (a volte<br />
un unico cuscino), tra Rocca Imperiale e Villapiana<br />
Scalo, mentre da tempo non è più rinvenuta nell’area<br />
del crotonese indicata da CANIGLIA et al. (1974). In<br />
Sardegna sono note 2 stazioni, in una delle quali S.<br />
spinosum risulta ormai scomparso. Nella Sicilia sudorientale<br />
la specie è invece presente in maniera tutto<br />
sommato continua, in una fascia che include Capo<br />
Passero, i Monti Climiti e i Monti Iblei. Infine, le<br />
recenti ricerche di campo non condotto al rinvenimento<br />
di alcun sito attuale di S. spinosum in<br />
Basilicata, rendendo necessarie ulteriori indagini in<br />
tale regione.<br />
Tipo corologico e areale globale. S. spinosum può<br />
essere considerata specie a corologia SE-Mediterranea<br />
(PIGNATTI, 1982). Probabilmente ha avuto come<br />
centro d’origine l’area di confine tra regione<br />
Mediterranea ed Irano-Turanica, per poi diffondere<br />
verso occidente (LITAV, ORSHAN, 1971; ZOHARY,<br />
1973). Oggi, oltre che nelle aree medio-orientali<br />
(Siria, Libano, Israele) ed in Italia, la specie è presente<br />
in Turchia, Creta, Grecia, Albania e Dalmazia<br />
(PROCTOR, 1968), mentre in Nord Africa è segnalata<br />
per la Tunisia (MARTINOLI, 1969).<br />
Minacce. In alcuni casi (per esempio la stazione<br />
pugliese presso la Palude del Capitano) esistono problemi<br />
relativi alla dinamica vegetazionale (Minaccia<br />
8.1: “Changes in native species dynamics-Competitors”),<br />
che pare favorire l’espansione delle specie della mac-