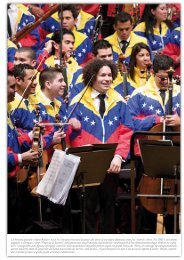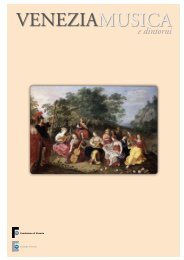VeneziaMusicaedintorni 48 - RIVISTA COMPLETA - Euterpe Venezia
VeneziaMusicaedintorni 48 - RIVISTA COMPLETA - Euterpe Venezia
VeneziaMusicaedintorni 48 - RIVISTA COMPLETA - Euterpe Venezia
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
si provocatoriamente proprio alla vigilia del rovente Sessantotto<br />
o, nell’84, di un colorito e ipernaturalistico adattamento<br />
della Carmen di Bizet, con Julia Migenes-Johnson, Placido<br />
Domingo e Ruggero Raimondi.<br />
Si evincono bene da questi dati la complessità e la ricchezza<br />
della personalità di Francesco Rosi e il valore, la potenza<br />
rappresentativa del suo cinema e del suo modo di incidere<br />
nella realtà e nelle sue varie raffigurazioni, anche spettacolari.<br />
Non va infatti mai dimenticato che Rosi è anche, forse<br />
soprattutto, un formidabile uomo di spettacolo in senso il<br />
più ampio possibile: dal teatro di prosa all’opera lirica, dalla<br />
fiction al documentario, ogni forma di messinscena lo attrae<br />
e lo stimola. Pertanto, l’efficacia documentale, sociale e<br />
ideale del suo cinema non prescinde – al contrario – dall’impianto<br />
narrativo ma vi si integra, utilizzando stilemi di vari<br />
generi (gangster movie, melodramma, commedia, noir, film<br />
di guerra, film-opera) alla ricerca persistente di un contatto<br />
quanto più possibile immediato con il pubblico.<br />
Francesco Rosi è infatti un cineasta «popolare», quando<br />
la parola non equivaleva ancora ad un insulto, ed è nello<br />
stesso tempo un cineasta di élite, selettivo, dal linguaggio,<br />
dal lessico non sempre facilmente accessibili, e dallo sguardo<br />
spesso profetico. Quasi mezzo secolo prima di Gomorra,<br />
scende con il suo esordio da regista in proprio La sfida (1958)<br />
nei vicoli della nativa Napoli per raccontare con durezza e<br />
asciuttezza ma anche con immensa umanità, grazie alla penna<br />
della grande e spesso a lui vicina (così come Tonino Guerra)<br />
Suso Cecchi d’Amico, una storia di camorra, di amicizia<br />
e di famiglia. E l’anno dopo, con I magliari, aspra tragicommedia<br />
su malavita e immigrazione, è tra i pochissimi a cercare<br />
con successo di sfruttare al massimo le (esilissime) doti di<br />
Alberto Sordi come attore drammatico. Ma è con Salvatore<br />
Giuliano e Le mani sulla città (1962 e ’63) che Rosi declina<br />
perentoriamente le generalità del proprio cinema di denuncia<br />
e di ricerca, iniziando a chiamare con nome e cognome<br />
alcune delle più inquietanti zone d’ombra della nostra storia<br />
recente: il primo, con una geniale struttura a flashback, rievoca<br />
la vicenda del bandito separatista siciliano autore della<br />
strage di lavoratori di Portella della Ginestra, della sua morte<br />
violenta nel 1950 e delle collusioni già vivissime fra mafia<br />
e ambienti reazionari; il secondo, forte di una drammaturgia<br />
ferrigna, squadrata, semidocumentaristica, affonda il bisturi<br />
nello scandalo della speculazione edilizia e nell’abbraccio<br />
mortale tra malaffare, apparati dello Stato e malavita. Le<br />
apparenti digressioni di Il momento della verità (1965), girato<br />
in Spagna e storia di un contadino che per sfuggire alla<br />
miseria affronta il destino dell’arena, e del già citato C’era<br />
una volta, prelude al trittico-Volonté<br />
Uomini contro,<br />
Il caso Mattei (Palma d’oro<br />
a Cannes nel ’72) e Lucky<br />
Luciano: sorta di Orizzonti<br />
di gloria italiano il primo,<br />
da Un anno sull’Altipiano di<br />
Emilio Lussu, straziante ancorché<br />
un po’ enfatico anatema<br />
pacifista, ritratti in piedi<br />
gli altri due di un antieroe<br />
dell’imprenditoria italiana e<br />
di un gangster sui generis, entrambi<br />
con fortissimo spirito<br />
d’indagine sui retroscena,<br />
i misteri e le aree oscure dei<br />
rapporti fra potere, finanza e<br />
politica. Se Cadaveri eccellenti<br />
cala ancora una volta l’argomento<br />
mafioso in una tipica<br />
atmosfera sciasciana da incubo<br />
insolubile e kafkiano, Cristo<br />
si è fermato a Eboli e il successivo<br />
Tre fratelli (1981) dimostrano<br />
una nuova fase creativa<br />
del regista, più intima e<br />
personale, memorialistica e<br />
lirica, letteraria e pacata ma,<br />
come attesta la già ricordata<br />
trasposizione marqueziana<br />
dell’87, non meno intransigente.<br />
Dimenticare Palermo,<br />
del ’90, robusto film di mafia<br />
aggiornato ai tempi, con Jim<br />
Belushi, Vittorio Gassman, è<br />
una nuova imperiosa dimostrazione<br />
di vitalità così come, dopo Diario napoletano, amaro<br />
e disilluso ritorno documentaristico nella realtà napoletana<br />
a trent’anni da Le mani sulla città, lo è ancor di più La tregua<br />
(1997), in cui le pagine implacabili di Primo Levi si decantano<br />
in un racconto intriso di sfumature e sottigliezze,<br />
dove l’atrocità dell’argomento non conosce né la retorica né<br />
gli stereotipi di tanto coevo cinema sulla Shoah.<br />
In tutto questo percorso, coerente e di straordinaria compattezza<br />
pur nella diversità dei risultati, il faro ispiratore di<br />
Rosi è sempre rimasto quello dell’approfondimento, della<br />
perlustrazione, dell’indagine pubblica e privata. Un maestro<br />
di cinema e di coscienza civile, in sintesi, per il quale «il<br />
momento della verità» non è mai sterile esercizio memorialistico<br />
o passato da archiviare, ma irrinunciabile viatico per<br />
un futuro migliore. ◼<br />
cinema 57