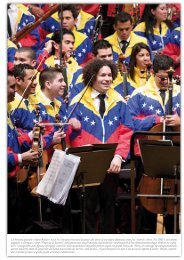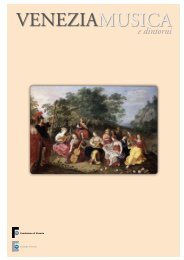VeneziaMusicaedintorni 48 - RIVISTA COMPLETA - Euterpe Venezia
VeneziaMusicaedintorni 48 - RIVISTA COMPLETA - Euterpe Venezia
VeneziaMusicaedintorni 48 - RIVISTA COMPLETA - Euterpe Venezia
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
po spazio nella generale economia» (p. 278). Ma questa peculiarità<br />
dei temi wagneriani, elementi di un cosmo in divenire<br />
(e non albero genealogico), di quella melodia infinita<br />
che lungi dall’essere isolata e ridefinita come forma chiusa –<br />
secondo una consuetudine pratica cui aderì per convenienza<br />
lo stesso Wagner – trova una sua ragion d’essere proprio<br />
nel suo vivere nel tempo, e quindi nel suo continuo trasformarsi,<br />
in quel suo cangiare quasi biologico che dalla nascita<br />
giunge all’estinzione, questa peculiarità dei temi, dicevo, è<br />
un tratto che, come suggerisce Bortolotto, può ritrovarsi anche<br />
«nella genesi della Comédie humaine e, in scala minore,<br />
nei Rougon-Macquart o, fra gli scrittori moderni, nelle complesse<br />
parentele diramantesi nella saga di Yoknapatawpha,<br />
in Faulkner» (p. 41).<br />
E proprio il parametro della «inattualità», nel rendere più<br />
segnatamente sensibile il rapporto di Liszt con Wagner, si allarga<br />
in maniera oltremodo significativa nel reclamare una<br />
più incidente considerazione del musicista ungherese. Lo si<br />
coglie nella sicura evidenza impressa al profilo del musicista<br />
magiaro-franco-tedesco nel bellissimo saggio Liszt o la coscienza<br />
romantica 7 , dal quale la visione si allarga verso orizzonti<br />
inattesi. Indubbio, dice Bortolotto, il riconoscere la<br />
grandezza di Liszt per la complessità ch’egli è andato diramando<br />
su vari fronti, dalla tecnica alla concezione formale,<br />
al gusto, ma ciò che più «allarma» è lo sperimentalismo<br />
e l’eterofonia, quest’ultima in particolare, «un modo di modernità<br />
schiacciante, un’espressione radicale di décadence».<br />
E proprio nel grembo indistinto in cui tali elementi si muovono,<br />
sovrapponendosi talora a più rassicuranti linee guida,<br />
si cela il senso più occulto, più istigante anche, dell’eredità<br />
lisztiana; fino a pensare che si stia «riscoprendo in lui la profezia<br />
di lontani approdi informali» 8 .<br />
Anche per Liszt, come per Wagner, il cammino di Bortolotto<br />
si muove sempre seguendo le ragioni della musica,<br />
esplorate nelle possibili declinazioni delle tante virtualità, a<br />
garantire un’autenticità dai rischi di ogni possibile contaminazione<br />
letteraria o agiografica. In altre parole, egli si sottrae<br />
ben consapevolmente alle insidie del wagnerismo, pur da lui<br />
osservato con quella lunghezza di sguardo, non poco cinica<br />
anche, che lo protegge da ogni «infezione». Una voce per<br />
questo ben sbalzata sul fondale di una tradizione come la nostra,<br />
in cui il wagnerismo si è innervato come termine di confronto<br />
in un ben diversificato tessuto di cultura. Un quadro<br />
che Adriana Guarnieri ha ampiamente ricomposto nel già citato<br />
Tristano, mio Tristano, prezioso gioco d’intarsi, ricchissimo<br />
variegato mosaico tra le cui tessere il «caso Wagner»<br />
si insinua come sottile provocazione, specchio riflettente anche<br />
di più segreti disagi.<br />
Wagner l’oscuro nasce da un confronto inesausto di Bortolotto<br />
con l’opera wagneriana, benché talora scandito in maniera<br />
occasionale: alcuni capitoli sono infatti ripresi da saggi<br />
apparsi in varie occasioni, programmi di sala, presentazioni;<br />
contingenze poi ricomposte attraverso la naturale progressione<br />
cronologica. Ma è soprattutto il filo che va snodandosi<br />
da questo viaggio gremito e avventuroso ad assicurare l’organicità<br />
del percorso, un filo che affiora sempre più significativamente<br />
da un cammino a senso unico, indirizzato all’affermazione<br />
della musica; dopo aver preso le mosse dall’imperioso<br />
statuto teorico del Wort-Ton-Drama, Bortolotto mostra<br />
come le «azioni della musica» vadano facendosi sempre<br />
più «visibili». La vistosa parentesi aperta da Wagner durante<br />
l’Atto II del Sigfrido, con la composizione del Tristan e<br />
dei Meistersinger, segna un trapasso sensibile. Tanti i segnali<br />
di questa presa di coscienza; sintomatica un’annotazione<br />
di Cosima nel suo diario, l’11 febbraio 1872, in cui viene ri-<br />
A destra: Franz Liszt.<br />
ferito un pensiero di Wagner, in quel periodo intento a correggere<br />
le bozze di Oper und Drama: «So quello che là dentro<br />
non conviene a Nietzsche, è ciò che è spiaciuto a Kossak,<br />
e che solleva Schopenhauer contro di me: è quanto dico del<br />
Verbo: in quel tempo non ero ancora capace di dire che era la<br />
musica ad aver dato origine al dramma, e tuttavia, interiormente,<br />
lo sapevo». Ancora Cosima, sei anni dopo, nel 1878,<br />
riferisce di un Wagner irato per una questione di «costumi<br />
e trucco», che si sfogava dicendo, dopo «aver creato l’orchestra<br />
invisibile», di voler «inventare il teatro invisibile». La<br />
questione, come ben si sa, è complessa e tanti sono gli aspetti<br />
contradditori su cui gli studiosi hanno dibattuto. Bortolotto<br />
la gestisce con la consueta sottigliezza; il che non gli<br />
impedisce di far l’occhiolino all’amato Stravinskij: «Là dove<br />
può sembrare che l’assunto ideologico vacilli – scrive, –<br />
interviene il “golfo mistico”: che mai come ora avanza pretese<br />
legittime per la tronfia designazione» (p. 282). Pretese<br />
che il nostro amico, altrettanto puntiglioso nel frugare entro<br />
gli angoli più riposti del disordinato magazzino<br />
da cui Wagner attinge i materiali per le sue ricreazioni<br />
poetiche, individua con acutezza<br />
fulminante, osservando attraverso la lente<br />
del suo penetrante microscopio ogni<br />
minimo passaggio, quasi che, nel chiudere<br />
quel cerchio da cui sono partite le<br />
diramazioni più imprevedibili, si sentisse<br />
sospinto dalle parole del musicista<br />
ormai vecchio, che sentiva Bach<br />
«come la radice delle parole. I rapporti<br />
di quest’opera con ogni altra musica<br />
sono quelli del sanscrito con le altre<br />
lingue». E quindi dar l’impressione<br />
di accondiscendere all’idea che Wagner,<br />
terminato il Parsifal, sognasse<br />
di lasciare il teatro, «dimostrarsi<br />
un musicista vero, fuori dalle lusinghe<br />
dell’azione scenica». Ma subito<br />
se ne ritrae, consapevole che in questo<br />
modo si uscirebbe «dal continente<br />
Wagner» per addentrarsi «nello<br />
scialbo territorio delle supposizioni»<br />
(p. 36). Ossia per entrare in<br />
un’altra dimensione di oscurità. ◼<br />
note<br />
1. Significativo il pensiero di Enrico De Angelis espresso nel saggio I<br />
maestri cantori. Lettura di un’«opera» pubblicato nel Numero unico del<br />
49° Maggio musicale fiorentino 1986, a cura di Mauro Conti, Alberto<br />
Paloscia, Annalena Aranguren, Ente autonomo del Teatro Comunale di<br />
Firenze, Firenze 1986, pp. 129-41, e così riassunto da Adriana Guarnieri<br />
Corazzol in Tristano, mio Tristano. Gli scrittori italiani e il caso Wagner,<br />
il Mulino, Bologna 1988 («Saggi», 347), p. 361: «ha […] suggerito quale<br />
dimensione wagneriana più autentica (più moderna, novecentista appunto)<br />
quella comico-“moderata” (liberatoria ma non eversiva) dei Maestri<br />
Cantori; proponendo quale cifra privilegiata di questo “dramma satiresco”<br />
la parodia dell’opera tradizionale e sottolineandone quindi significativamente<br />
i caratteri ‘neoclassici’ (prestiti, citazioni, inversioni di<br />
senso, autocitazioni ironiche, effetti a sorpresa, ecc.)».<br />
2. Mario Bortolotto, Prefazione (1966), in Theodor Wiesengrund<br />
Adorno, Wagner (1952), prefazione e cura di Mario Bortolotto, Einaudi,<br />
Torino 2008 («Piccola biblioteca Einaudi», 414); prima ed. it. in Id.,<br />
Wagner – Mahler. Due studi, Einaudi, Torino 1966 («Saggi», 376).<br />
3. Ivi, p. XXIII.<br />
4. Fedele d’Amico, Il dio Wagner (1983), in Id., Tutte le cronache musicali.<br />
«L’Espresso» 1967-1989, 3 voll., a cura di Luigi Bellingardi, con la<br />
collaborazione di Suso Cecchi d’Amico e Caterina d’Amico de Carvalho,<br />
prefazione di Giorgio Pestelli, Bulzoni, Roma 2000, III (1979-1989),<br />
pp. 1989-1993: 1993.<br />
5. Bortolotto, Prefazione, in Adorno, Wagner cit., pp. XXIII-XXIV.<br />
6. Ivi, pp. XXII-XXIII.<br />
7. Scritto nel 1970, è ora confluito in Bortolotto, Corrispondenze,<br />
Adelphi, Milano 2010 («Saggi. Nuova serie», 65), pp. 88-101.<br />
8. Le due citazioni si leggono ivi, rispettivamente alle pp. 100 e 101.<br />
Il provetto stregone 71