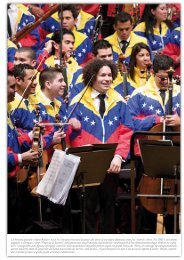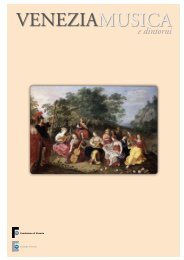VeneziaMusicaedintorni 48 - RIVISTA COMPLETA - Euterpe Venezia
VeneziaMusicaedintorni 48 - RIVISTA COMPLETA - Euterpe Venezia
VeneziaMusicaedintorni 48 - RIVISTA COMPLETA - Euterpe Venezia
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
74<br />
Mario Bortolotto e le vie della musicologia<br />
cipano una nutrita serie di studi di musicologia comparata<br />
da parte di più giovani leve della critica (pensiamo al saggio<br />
schubertiano di Giuseppina La Face Bianconi) 4 . Ma di esse<br />
non si può non citare quella che, se non ne è affatto la conclusione<br />
(in quanto invece di chiudere strade ne apre di nuove),<br />
ne è, in certo modo, il paradigma critico:<br />
Il confronto fra le quattro versioni del Lied, favorito dall’identità del<br />
testo, conclude a una verificazione fondamentale: la tendenza al comportamento<br />
organico, unitario: alla canzone durchkomponierte. [...] Ove la<br />
dissoluzione dello schema, della forma presupposta risulti impossibile,<br />
come nel nostro caso, il compositore riforma dall’interno le strutture<br />
accettate, arrivandosi con Wolf a mutarle integralmente: la variazione<br />
annulla la ripetizione; e niente rimane dell’antica strofe unitaria, sotto la<br />
quale si arrivò a segnare fino a sei testi sovrapposti 5 . Dopo questa rinnovata<br />
vocalità, affiancata dalle affini elaborazioni di Mahler, il Lied non<br />
può che eliminare gli ultimi elementi della sussunzione popolare, e quella<br />
sorta di musica al quadrato ante litteram rovesciarsi nelle depressioni morali<br />
e nelle assorte veggenze della Wienerschule. (pp. 59-60)<br />
E qui, di nuovo, come non vedere un apoftegma patrum nella<br />
definizione che segue: «Le sillabazioni iniziatiche di Webern<br />
portano il Lied a schivare ogni ricerca di salvezza per<br />
ascoltare la verità del suono-simbolo, nel silenzio dell’uomo<br />
interiore». Questa volta è Hölderlin e con lui i suoi migliori<br />
interpreti novecenteschi, da George a Heidegger. Ma eccolo<br />
citato, Hölderlin, quarantasette pagine più avanti (p. 107),<br />
con i Götter Griechenlands, insieme al Leopardi dell’Inno ai<br />
Patriarchi, incomprensibile a chi non ne ricordi il sottotitolo<br />
(De’ principii del genere umano).<br />
Le settantacinque pagine (pp. 35-109) dedicate a Schubert<br />
(che hanno per accompagnatori Mozart, Tomášek, Beethoven,<br />
Zelter, ma anche Schiller, Goethe, Lessing, Winckelmann,<br />
Novalis, Schlegel, Kierkegaard, e, quali paratesti,<br />
tra gli altri Nietzsche, Marx, Lukács) si concludono con un<br />
tramonto del compositore viennese dalle omeriche «dita<br />
di rosa», che prelude all’alba di Schumann, forse mai così a<br />
fondo, e così «germanicamente» compreso, se non da John<br />
Daverio 6 :<br />
Il pensiero idealista, fermamente radicato sui temi dell’umanesimo,<br />
chiarendo la responsabilità tutta umana della storia, parve determinare<br />
in quegli anni, come è stato notato, una seconda perdita del Paradiso. Da<br />
ogni parte d’Europa, Foscolo, Leopardi, Hölderlin, Blake, Keats, Coleridge,<br />
Platen, Nerval, e finanche, in termini di esulcerata ironia, l’amato<br />
Heine, sembrano insegnare agli uomini, nella consolazione del canto, a<br />
dischiudere nuove attualità edeniche. Il candidissimo Schubert, uomo di<br />
poca filosofia, poco dovette saperne: ma intuì quella necessità di ritorno,<br />
che riporta la favola umana a condizioni di primordio. (p. 108)<br />
Chi ha letto lo Schumann delle prime pagine dei Tagebücher<br />
7 lo sente già palpitare in queste parole. Bastano<br />
infatti meno pagine (solo ventotto, contro le settantacinque<br />
dedicate a Schubert) per giungere a un epilogo più da Eusebio<br />
che da Magister Rarus: «La conclusione di Schumann è<br />
[...] uno stupito accecato fissare le ragioni che la ragione non<br />
conosce: proprio attraverso il contatto immediato con la materiale<br />
tangibilità degli oggetti». Gli stessi echi schumanniani<br />
dell’infanzia sono qui accostati alla bella definizione di<br />
Adorno riguardo al «sempre vano tentativo degli uomini di<br />
nominare le cose stesse» (p. 136).<br />
Il terzo capitolo, dedicato a Mendelssohn e a Löwe, consta<br />
di sole sei pagine (pp. 137-142), divertentissime, dove la<br />
materia passa «dalla natura trascendentale del Gesang der<br />
Geister schubertiano alle canzoni da Touring Club, per le<br />
escursioni educative della media borghesia (la “malvagia”<br />
borghesia di Adorno), tra la religiosità sublime o la tenerezza<br />
della lirica amorosa, e le zuppe, le gelatine di tante graziose<br />
raccolte tutt’oggi pubblicate» (p. 142).<br />
Quasi nessuno – neppure conoscendo intimamente il<br />
Brahms dell’opus 33, le quindici romanze composte tra il<br />
1861 e il 1868 a Münster am Stein, dove il compositore aveva<br />
steso i primi abbozzi, poi abbandonati, della Prima Sinfonia,<br />
e dove si trovava in compagnia di Clara Schumann e dei figli<br />
di lei: quell’opus 33 i cui testi erano stati tratti dal romanzo<br />
della bella Magelone, in Italia quasi ignoto: Liebesgeschichte<br />
der schönen Magelone und des Grafen Peter von Provence,<br />
– quasi nessuno, dicevo, penserebbe di paragonare la prosa<br />
brahmsiana a quella di Tieck (p. 1<strong>48</strong>). E varrebbe la pena di<br />
discutere con Mario Bortolotto se, oltre beninteso al celebre<br />
articolo di Schönberg (nel 1962 non ancora così celebre)<br />
da lui citato, Brahms the Progressive 8 , avesse ragione anche<br />
quel critico contemporaneo di Brahms oggi ingiustamente<br />
dimenticato, che titolava all’inizio del Novecento uno dei<br />
capitoli conclusivi della sua bella epitome sulla storia musicale<br />
(allora) contemporanea «Der Klassizismus. Johannes<br />
Brahms» 9 . Come non pensare, oggi, alla rilettura «classica»<br />
che ne ha dato di recente l’ormai celebre raccolta saggistica<br />
di Giorgio Pestelli, che ridiscute, tra le altre, anche<br />
le tesi contraddittorie di Walter Niemann? 10 Nemmeno al<br />
caustico Ladislao Mittner – che definiva la Rapsodia per<br />
contralto, coro e orchestra di Brahms anziché il suo «Canto<br />
di Fidanzamento», come il compositore aveva scritto a Clara<br />
Schumann, «il canto della sua incapacità di fidanzarsi», 11 –<br />
sarebbe venuto in mente di stabilire un’equivalenza tra il preteso<br />
paganesimo di Brahms e quello di Chesterton (le celebri<br />
pagine sull’ateismo del Manalive vestito di verde). E a pochi,<br />
prima di leggere Bortolotto (mentre a posteriori appare<br />
chiarissimo), risulta chiaro come questo preteso paganesimo<br />
sia da identificare piuttosto con una religiosità à la Schleiermacher:<br />
quel «senso e gusto dell’infinito» (il celebre passo<br />
del teologo di Breslavia citato da Thomas Mann nel Doktor<br />
Faustus: «Sinn und Geschmack für das Unendliche»), che<br />
è l’«essenza del fenomeno religioso» (p. 152).<br />
Su Wagner, tre pristine rose: tante sono le pagine (154-<br />
Robert Schumann.