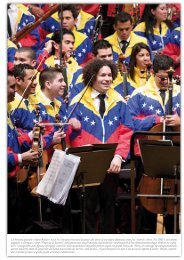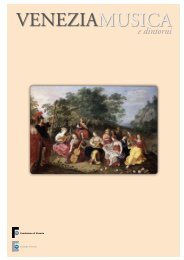VeneziaMusicaedintorni 48 - RIVISTA COMPLETA - Euterpe Venezia
VeneziaMusicaedintorni 48 - RIVISTA COMPLETA - Euterpe Venezia
VeneziaMusicaedintorni 48 - RIVISTA COMPLETA - Euterpe Venezia
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
70<br />
Mario Bortolotto e le vie della musicologia<br />
quale, nel rimarcare l’«unità di stile», scorge in questa vicinanza<br />
un momento nodale di quella stretta tra stile e linguaggio<br />
che prefigura le strade della modernità: fino a quel<br />
«punto di bruciante identità» realizzato da Anton von Webern<br />
(pp. 334-335).<br />
Il mio approccio al libro, partendo dai Meistersinger, è stato<br />
un repentino precipitare in medias res, cosicché ancor<br />
più sollecitante è risultato poi il risalire alle origini di questo<br />
straordinario viaggio entro l’«oscuro». Con una guida<br />
tanto avvincente quanto impegnativa: scherzosamente,<br />
si potrebbe parafrasare: «Bortolotto l’oscuro». Ma nel<br />
senso ch’egli ci consente di entrare nell’oscurità wagneriana,<br />
svelandocene i tratti che da quelle tenebre vanno via via<br />
definendosi, superando le contraddizioni più apparenti per<br />
stabilire una nuova complicità. La stessa cosa, insomma,<br />
che Bortolotto aveva fatto in Dopo una battaglia, ricreando<br />
una prospettiva inattesa della Francia dopo Sédan, o in Est<br />
dell’Oriente, dove ci aveva introdotto nei più riposti scenari<br />
della musica russa. Con Wagner Bortolotto ci rende partecipi<br />
di quel mondo fatto, com’egli dice, di «quasi inafferrabili<br />
fugacità, nebule intangibili, fibrillazioni tessutarie, collisioni<br />
cromatiche, microcosmi sfumanti in un magmatico habitat<br />
sinfonico» (pp. 183-184). Terreno oltremodo<br />
provocante per il Nostro, nel<br />
contrasto tra questo avventuroso universo<br />
linguistico e immaginario e la<br />
statura umana del mistificatore. Un<br />
contrasto irrisolvibile: «Impossibile<br />
affatto sarebbe procedere a districare<br />
nell’amalgama psichico, e verbale, di<br />
sincerità, mendacio, estetismo, egoismo,<br />
posa, generosità sconfinata» (p.<br />
22). E tuttavia il gioco è avvincente, e<br />
infiniti sono i labirinti attraverso cui<br />
Bortolotto ci guida, con le sue imprevedibili<br />
vividezze, le scorciatoie inaspettate<br />
quanto rivelatrici.<br />
Un viaggio, del resto, lungo il quale<br />
Bortolotto aveva già accompagnato<br />
il lettore nella prefazione<br />
all’edizione italiana del saggio di<br />
Adorno 2 , laddove sospingeva lo<br />
sguardo verso regioni più arcane,<br />
inesplorate – «il discorso su<br />
Schönberg si deve di necessità inserire<br />
nella prospettiva del Versuch» 3 , – sul<br />
filo di quella ambivalenza che troverà pure riverbero nel pensiero<br />
di Fedele d’Amico per giustificare come «tutto, dopo<br />
Wagner, diventa problema» in quanto «eterna resta l’ambiguità<br />
fra la tensione nichilista dell’inestirpabile eresiarca<br />
e la bronzea concretezza delle figure che ne son messe in moto»<br />
4 . Bortolotto sembra andare ancora oltre nel creare aspettative<br />
di lunghissima gittata, conseguenza del «negativo»,<br />
pur non celando la disillusione nella scettica chiusa: «Gli<br />
orologi della musica senza aggettivazione, arrestatisi simpateticamente<br />
nel febbraio 1883, il giorno 13 (in obbedienza<br />
al numero vitale del musicista) sul frammento Liebe-Tragik<br />
di Palazzo Vendramin, segnano adesso, meccanici ossimori,<br />
l’ora delle serenate» 5 .<br />
Un Wagner diverso, appunto, non riportabile entro linee<br />
definite, neppure rassicuranti, a considerare l’enorme sfrido<br />
che dall’imponente impresa è andato determinandosi. Anche<br />
questo fa parte dell’effetto Wagner, di quel gorgo avvitato<br />
dalla sua concezione musicale e, più ancora, dal suo linguaggio<br />
votato alla dissoluzione: la musica, come intuito da<br />
Schopenhauer e da Nietzsche, quale «arte del tramonto»,<br />
a disegnare l’arcata discendente in fondo alla quale, «ulti-<br />
ma tappa del sublime romantico» – scriveva Bortolotto nella<br />
prefazione al saggio di Adorno su Wagner – è «il Kitsch» 6 .<br />
Aloni fumosi quelli emanati da questo termine; quel fumo<br />
che costituiva la ragion d’essere degli adepti («Il wagnerismo<br />
[…] un rituale asiatico, baudelairianamente “impregné<br />
d’odeurs”»: p. 16), i Wagnerianer e, nella diramata idolatria<br />
francese, i Wagnerites, fino all’eccitazione di un Catulle<br />
Mendès il quale esclamava «Christ, Berlioz et Wagner, divins!»<br />
(p. 15). Un terreno in cui Bortolotto brucia tutta la<br />
sua sagacia, con una circolarità di movenze capace di mettere<br />
a frutto la banalità del gossip attraverso iperboli accecanti,<br />
che partendo dalle situazioni del divenire quotidiano ci pongono<br />
di fronte a snodi essenziali, facendoci intendere il senso<br />
ineludibile di un lascito. Lascito che va depurato, comprensibilmente,<br />
dalle incrostazioni sedimentate sul personaggio<br />
Wagner, pur esse però significative, come pure dalle infinite<br />
complicazioni innescate dal suo rapporto coi contemporanei,<br />
e con Liszt in particolare. Al quale non esitava a confessare<br />
«come musicista mi sento tale da far pietà» – pendant<br />
al giudizio impregnato di sufficienza sul futuro suocero:<br />
«non è che un musicista!».<br />
Una presenza, quella dell’ungherese, che nelle pagine di<br />
Bortolotto rivive non tanto in termini<br />
di rivendicazione quanto<br />
piuttosto innestata nel<br />
comune parametro dell’«inattualità».Molte,<br />
infatti, sono le situazionimusicali<br />
di Liszt che possono<br />
considerarsi incunaboli<br />
di Wagner; la più<br />
nota, la melodia dalle Campane<br />
del duomo di Strasburgo,<br />
che ritroviamo nel Parsifal<br />
quale motivo che accompagna<br />
il corteo funebre di Titurel<br />
(e che poi, simbolicamente, Liszt<br />
riprenderà nel tardo Am Grabe<br />
Richard Wagners per pianoforte).<br />
Bortolotto è chiarissimo nello<br />
sfatare la nebbia: «La distanza da<br />
Liszt è radicale, nonostante l’affinità<br />
apparente: l’atteggiamento di Wagner<br />
punta sull’estensione del principio<br />
tonale, laddove Liszt indaga plaghe<br />
ignote con attenzione meramente acustica, sperimentale<br />
nettamente» (p. 428). Più che il bilancio dei crediti, in parte<br />
riconosciuti da Wagner, in particolare quelli verso i poemi<br />
sinfonici, nonostante la sua iniziale sfiducia nella musica a<br />
programma (mentre risulterà insensibile, se non disgustato,<br />
dalle estreme pagine sperimentali, a tal punto ritenute frutto<br />
di uno squilibrio da chiamarne l’autore «re Lear»), emerge<br />
la comunanza di una particolare tensione formale nel gestire<br />
il rapporto con la parola. Tensione che per Wagner vede<br />
la sua naturale proiezione nel modo di concepire il tempo,<br />
miticamente, come uno scorrere circolare entro cui affiorano<br />
e agiscono, quali presenze riconoscibili, i temi, non organismi<br />
compiuti in sé, nella loro fisionomia grafica, avverte<br />
Bortolotto, bensì puro dato temporale, proprio come l’intermittence<br />
proustiana. Puntualissimo il rimbalzo attraverso<br />
la figura del «barone di Charlus, perno della Recherche; ove<br />
svolge insieme pratica di delucidazione e d’arbitraggio, e soffre<br />
passione sacrificale. Al pari di Wotan, non occupa trop-<br />
A sinistra: Friedrich Wilhelm Nietzsche.<br />
A destra: Arthur Schopenhauer.