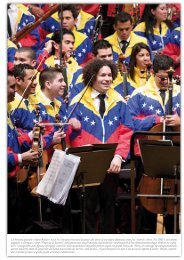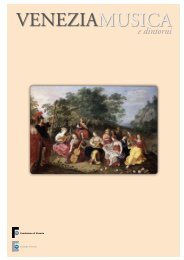VeneziaMusicaedintorni 48 - RIVISTA COMPLETA - Euterpe Venezia
VeneziaMusicaedintorni 48 - RIVISTA COMPLETA - Euterpe Venezia
VeneziaMusicaedintorni 48 - RIVISTA COMPLETA - Euterpe Venezia
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
64<br />
in vetrina<br />
«Musiche<br />
Culture Identità»<br />
Il congresso<br />
della Società Internazionale<br />
di Musicologia a Roma<br />
di Emanuele Senici<br />
La diciannovesima edizione del congresso della<br />
Società Internazionale di Musicologia, che si<br />
svolge ogni cinque anni, ha avuto luogo dall’1 al 7<br />
luglio all’Auditorium Parco della Musica di Roma.<br />
Organizzata dall’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in<br />
collaborazione con le tre università romane La Sapienza, Tor<br />
Vergata e Roma Tre, ha visto la presenza di più di seicento relatori,<br />
che, oltre alle sedute del convegno, hanno preso parte<br />
a varie altre attività, come concerti e visite guidate ai luoghi<br />
musicalmente più rilevanti di Roma e dintorni.<br />
La maggior parte dei congressi della sim svoltisi negli ultimi<br />
decenni ha avuto un tema generale: quello proposto dal<br />
comitato scientifico dell’edizione romana, presieduto da Fabrizio<br />
Della Seta, è stato «Musiche Culture Identità» (come<br />
utile termine di confronto si pensi che il congresso precedente,<br />
svoltosi a Zurigo nel 2007, era stato intitolato «Passaggi»).<br />
Si tratta più che altro di un punto d’orientamento<br />
utile a chi propone tavole rotonde e study sessions (ogni congresso<br />
ne prevede diverse di entrambe le tipologie), mentre<br />
le sedute di relazioni libere, assemblate dal comitato scientifico<br />
stesso dopo la selezione delle proposte ricevute, sono<br />
meno vincolate al tema generale. Al termine dei lavori l’impressione<br />
è stata però che l’identità sia una delle questioni al<br />
contempo più interessanti e più calde tra quelle che animano<br />
il dibattito musicologico oggi (è bene chiarire che in questo<br />
contesto «musicologia» è termine che serve da ombrello<br />
per tutte le attività di ricerca sulla musica, dalla musicologia<br />
storica all’etnomusicologia, dalla filosofia della musica<br />
all’organologia, dall’iconografia musicale<br />
alla psicologia della musica, e così<br />
via). In un certo senso sarebbe strano<br />
il contrario, dal momento che<br />
la musicologia, come ogni attività<br />
intellettuale, riflette la cultura<br />
in cui essa si trova immersa,<br />
seppur spesso in modo indiretto;<br />
e mi pare fuor di dubbio<br />
che l’identità sia una delle<br />
categorie fondanti della cultura,<br />
nonché della società, della<br />
politica e dell’ideologia del mondo<br />
contemporaneo – una delle ragioni,<br />
immagino, per cui il comitato<br />
scientifico l’ha proposta come<br />
tema del congresso –.<br />
Igor Stravinsky<br />
n un disegno<br />
di Pablo Picasso<br />
(31 dicembre 1920).<br />
Un’altra benemerita tradizione di questi convegni vuole<br />
che al centro della giornata inaugurale si collochino due relazioni<br />
plenarie presentate da non-musicologi, che riflettono<br />
sul tema generale da punti di vista esterni alla disciplina.<br />
Non sempre queste occasioni funzionano: ricordo per esempio<br />
una lezioncina superficiale del matematico Roger Penrose<br />
a Londra nel 1997, che sembrò ancora più striminzita per<br />
essere appaiata a una profonda riflessione filosofica su opera<br />
ed esecuzione del compianto Bernard Williams. A Roma,<br />
invece, le conferenze della filosofa statunitense Martha<br />
C. Nussbaum e dell’antropologo italiano Francesco Remotti<br />
hanno offerto spunti di riflessione molto stimolanti sulla<br />
questione dell’identità. Nussbaum ha indagato il ruolo della<br />
musica e della danza nel progetto filosofico ed educativo<br />
di Rabindranath Tagore, sottolineando la portata sovversiva<br />
di queste attività all’interno di una «religione dell’umanità»<br />
costituzionalmente anti-identitaria. Remotti ha invece<br />
offerto una critica articolata ed eloquentissima del concetto<br />
stesso di identità, seguita da un appassionato plaidoyer per<br />
la categoria della somiglianza, secondo lui molto più adatta a<br />
navigare il difficilissimo contesto sociale, politico e ideologico<br />
in cui ci troviamo a vivere.<br />
Le parole di Nussbaum e Remotti hanno risuonato per tutta<br />
la settimana seguente, offrendo prospettive generali assai<br />
stimolanti da cui contemplare sedute dedicate a temi apparentemente<br />
così diversi come le tavole rotonde su «Costruzione<br />
e decostruzione dell’identità nella musica dell’Asia<br />
orientale dagli anni sessanta», «Sguardi dal di fuori sull’identità<br />
musicale italiana», «Modelli cognitivi nelle attività<br />
musicali», «Musica e visualità», «Identità europea e condizione<br />
periferica nella musica iberica antica» e «Identità<br />
musicale e cultura dell’identità in Italia nel Quattro-Cinquecento»,<br />
oppure le study session su «Papi, cardinali e musica,<br />
1450-1630», «La trasmissione della conoscenza musicale:<br />
costruire una cittadinanza europea», «Prospettive interdiciplinari<br />
sulla musica, la cultura e l’identità brasiliane»,<br />
«Immagine-suono-struttura e l’esperienza audiovisiva»,<br />
«Com’era veneziana l’opera veneziana nel Seicento?»<br />
e «Questioni di identità stilistica e di disseminazione europea<br />
nella Scuola delle Nazioni di Tartini», per citare solo<br />
Gioacchino Rossini<br />
(dipinto anonimo<br />
prima metà Ottocento).