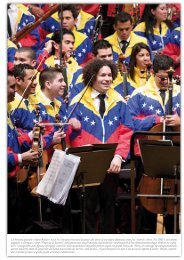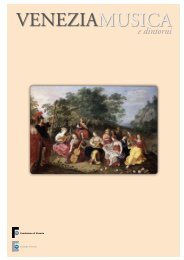VeneziaMusicaedintorni 48 - RIVISTA COMPLETA - Euterpe Venezia
VeneziaMusicaedintorni 48 - RIVISTA COMPLETA - Euterpe Venezia
VeneziaMusicaedintorni 48 - RIVISTA COMPLETA - Euterpe Venezia
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
68<br />
Mario Bortolotto e le vie della musicologia<br />
stosi negli anni settanta e ottanta: l’«affermazione della musica»<br />
su cui insiste molto anche Minardi.<br />
Ma questo indirizzo<br />
non è caratteristico del<br />
solo scenario italiano,<br />
lo si ritrova anche nella<br />
musicologia mitteleuropea,<br />
in particolare<br />
nei contributi epocali<br />
di Carl Dahlhaus. È degno<br />
di nota il fatto che i<br />
due, il tedesco e l’italiano,<br />
si accostino a Wagner<br />
quasi in contemporanea,<br />
questo con la traduzione<br />
e la cura del saggio<br />
di Adorno (uscito nel<br />
1966 per i tipi di Einaudi),<br />
quello con le indagini<br />
che condurranno, nel<br />
1971, alla fioritura pressoché<br />
simultanea della<br />
Wagners Konzeption des<br />
musikalischen Dramas<br />
e dei Richard Wagners<br />
Musikdramen 2 : entrambi<br />
partono da un retroterrafilosofico-ideologico<br />
molto solido e specifico<br />
(l’interesse per la<br />
Nuova musica che si riverbera<br />
anche in scelte<br />
lessicali riconoscibili;<br />
il riferimento costante<br />
ad Adorno, specie in<br />
funzione antagonistica)<br />
3 , entrambi nutrono<br />
un certo qual sospetto<br />
intorno alla solidità<br />
dell’impalcatura teorica<br />
wagneriana, entrambi<br />
rimarcano che nel<br />
Wort-Ton-Drama «il testo,<br />
il poema, non diversamente<br />
dalla musica,<br />
è inteso da Wagner come<br />
un mezzo del dramma,<br />
non come la sua essenza»<br />
(Dahlhaus, Wagners<br />
Konzeption des<br />
musikalischen Dramas,<br />
p. 15: anche Bortolotto<br />
affronta l’argomento nel<br />
capitolo iniziale di Wagner<br />
l’oscuro, «Temperamento<br />
e teoresi», pp.<br />
13-58), ma poi – come si<br />
diceva – si concentrano<br />
sulla dimensione musicale,<br />
privilegiando la microforma,<br />
singole componenti<br />
del discorso o<br />
momenti delimitati, rispetto<br />
alla lunga gittata,<br />
all’impianto globale di un atto o di un Drama 4 .<br />
Ora, si potrebbe pensare, date alla mano, che Bortolotto<br />
sia in debito con Dahlhaus (il cui nome in Wagner l’oscu-<br />
ro compare tre volte, a pari merito con Diether de la Motte<br />
ed Ernest Newman, una in meno di Robert Donington,<br />
mentre Egon Voss e Jean-Jacques Nattiez 5 si fermano a quota<br />
uno: più frequenti le citazioni degli ammirati Boulez,<br />
Confalonieri e Lévi-Strauss); in realtà, la loro quête wagneriana<br />
procede parallela e indipendente. L’immagine di Wagner,<br />
essenzialmente desunta da Nietzsche, quale dissoluzione<br />
della Romantik e scaturigine del «negativo» novecentesco,<br />
in Bortolotto è già del tutto definita quando le monografie<br />
di Dahlhaus vedono la luce in italiano; anzi, è proprio in<br />
quell’immagine ch’è dato distinguere il timbro inconfondibile<br />
della sua voce tra le mille e mille che formano il coro della<br />
critica wagneriana. (j.p.) ◼<br />
1. Per ricorrere a un titolo ben noto di Beniamino Dal Fabbro (1954):<br />
non a caso la Guarnieri per la letteratura degli anni sessanta parla di<br />
«ritorni» antiwagneriani, giacché essi si ritrovano «a fianco della<br />
tradizione letteraria antiwagneriana neoclassica tuttora operante» (il<br />
rondismo di Montale), laddove le origini di questa ripulsa rimontano<br />
indietro sino a D’Annunzio, al suo progetto di «mito mediterraneo»<br />
alternativo a quello «nordico» di Wagner (Il fuoco, 1900).<br />
2. Tradotti anche in italiano, l’uno da Maria Cristina Donnini Maccio<br />
per Discanto, Fiesole (FI) 1983 («Contrappunti», 17), l’altro da Lo-<br />
renzo Bianconi (anche curatore) per Marsilio, <strong>Venezia</strong> 1984 («Musica<br />
critica»).<br />
3. A partire dagli anni settanta, Bortolotto gli affiancherà il prediletto<br />
Nietzsche: «Ben pochi casi conosce la storia della musica in cui un<br />
manuale di estetica , o anzi una formulazione di poetica, sia di tanto<br />
più brillante di quelle che già erano […] le composizioni da esso ispirate,<br />
o con esso simbiotiche. Pensiamo soltanto al Caso Wagner»: Mario<br />
Bortolotto, Cocteau e il marinaio, in Id., Corrispondenze, Adelphi, Milano<br />
2010 («Saggi. Nuova serie», 65), pp. 263-68: 263. Si veda anche<br />
Friedrich Nietzsche, Scritti su Wagner, trad. it. di Sossio Giametta e<br />
Ferruccio Masini, con un saggio di Mario Bortolotto, Adelphi, Milano<br />
1979 («Piccola biblioteca», 80), la cui introduzione, Altra aurora,<br />
graziosamente resa più accessibile ai comuni mortali da pochi ma capitali<br />
interventi, è poi confluita in Bortolotto, Wagner l’oscuro, Adelphi,<br />
Milano 2003 («Saggi. Nuova serie», 42), pp. 140-196. Tutta sua anche<br />
la propensione per il mito e il sapere iniziatico, verificabile nella parte<br />
introduttiva dei capitoli sul Ring, su Tristan, e, in modo speciale, su<br />
Parsifal.<br />
4. Tema a cui ha invece prestato particolare attenzione la scuola angloamericana,<br />
da Anthony Newcomb e Carolyn Abbate in avanti. Per<br />
Dahlhaus e Bortolotto la questione viene forse data per risolta (termine<br />
da intendersi anche e soprattutto in senso etimologico) nel flusso<br />
continuo e onnicomprensivo della rete leitmotivica.<br />
5. Con le ricerche del quale non mancano punti di tangenza, con ogni<br />
probabilità del tutto casuali, ma non per questo meno sintomatici.<br />
Sopra: Carl Dahlhaus.