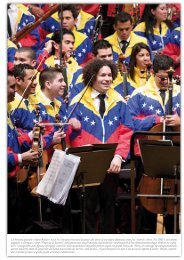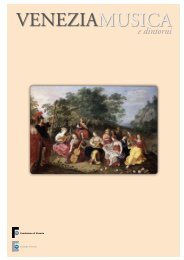VeneziaMusicaedintorni 48 - RIVISTA COMPLETA - Euterpe Venezia
VeneziaMusicaedintorni 48 - RIVISTA COMPLETA - Euterpe Venezia
VeneziaMusicaedintorni 48 - RIVISTA COMPLETA - Euterpe Venezia
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Bortolotto l’oscuro<br />
Il mio primo incontro con Wagner l’oscuro<br />
(Adelphi, Milano 2003) è avvenuto quasi in concomitanza<br />
con una bella proposta dei Meistersinger al Maggio<br />
musicale fiorentino 2004, il che mi ha naturalmente<br />
guidato a iniziare la lettura dal capitolo dedicato a quest’opera:<br />
a incorniciarlo, un titolo sottilmente allusivo, «La città,<br />
il profumo». Ed è stata subito coinvolgente occasione<br />
per ritarare lo strumento<br />
che convenzionalmente,<br />
e non poco<br />
passivamente, viene<br />
spesso applicato<br />
a quest’opera, nata a<br />
fianco del Tristan, durante<br />
l’ampia interruzione<br />
apertasi lungo il<br />
defatigante cammino<br />
creativo del Ring<br />
– «un’opera tra parentesi»,<br />
come scriveva<br />
l’autore a Cosima;<br />
per modificare, dunque,<br />
quelle misure che<br />
sembrano sovente costringerla<br />
entro una<br />
proiezione retrospettiva,<br />
quella di un Wagner<br />
che si rifugia nel<br />
passato, nel contrappunto,<br />
nella positività<br />
operosa di personaggi<br />
riconoscibili 1 , piuttosto che avventurarsi in altre ben più avvolgenti,<br />
non poco sibilline, spire.<br />
Aggiustare il tiro rispetto alla semplificazione è per Bortolotto<br />
fin troppo scontato; gli basta ricordare (p. 347) il chiarimento<br />
di Nietzsche: «Chi rimane sorpreso dalla vicinanza<br />
del Tristan coi Meistersinger, non ha capito, in un punto<br />
importantissimo, la vita e la natura di tutti i Tedeschi veramente<br />
grandi: non sa su quale terreno soltanto può crescere<br />
quella gaiezza propriamente ed unicamente tedesca di Lutero,<br />
Beethoven e di Wagner». Per poi innescare tutte le sue<br />
qualità introspettive nello sciogliere i nodi insiti nello stesso<br />
stacco del soggetto, non più innervato nel mitico o nel leggendario,<br />
ma arroccato alla storia ancora palpitante di una<br />
città: ecco quindi rinsaldata l’unità che ricomprende l’intera<br />
vicenda wagneriana. Di questa, infatti, i Meistersinger sono<br />
solo un altro aspetto, avvinti da una segreta continuità,<br />
oltre che dalla contiguità cronologica, con il Tristan, come a<br />
ribadire la profonda unità di questa «paradossale dilogia»<br />
(p. 353), dove la chiarezza dell’una, anche quella lunare della<br />
notte di San Giovanni, sembra fugare i più inquieti spiriti<br />
della notte che attraversano la partitura gemella. L’acutezza<br />
di Bortolotto è oltremodo penetrante nel leggere in filigrana<br />
i sottili intrichi di questo nodo: se, com’egli dice, i Meistersinger<br />
«enunciano la regola» (p. 341), nondimeno affiora<br />
insinuante «la volontà del nuovo», espressione che sembra<br />
attivare le segrete consonanze baudelairiane, e con esse<br />
lo spettro della «distruzione della lingua», spettro che fin<br />
dai suoi inizi critici ha accompagnato la sensibilità del Nostro.<br />
Centrale, in tale intreccio di tensioni opposte, è la figu-<br />
A destra: Richard Wagner.<br />
di Gian Paolo Minardi<br />
ra di Sachs, il cui profilo l’autore disegna con quella ricchezza<br />
e, pure, con quell’ambiguità di tocchi che smussa, confondendone<br />
le tensioni, certi tratti troppo netti, così da coglierne<br />
la complessità: «Lo sguardo di Sachs, – scrive Bortolotto<br />
– di lui solo, ha doppio orizzonte, l’eccezione e la regola, il<br />
nuovo e il bello» (p. 343). Può sembrare quasi un autoritratto<br />
di Wagner, trascinato da quel «demone dalla vertiginosa<br />
energia trascinatrice» (p. 344) che è il Wahn, il senso illusorio,<br />
sottile follia, che nella sua mobilità insinuante si apre alle<br />
più insospettate riverberazioni musicali: fino alla decantazione<br />
suprema del Quintetto, «musica assoluta: o almeno,<br />
[…] quanto in Wagner più le si accosta» (p. 352).<br />
Il Wahn come traccia sotterranea che delimita e insieme<br />
unisce le due opere, Tristan e Meistersinger; irradiato attraverso<br />
vari poli, esso trasmette il senso più recondito di un<br />
pensiero che nutre la musica, quasi sollecitando inafferrabili<br />
presentimenti. Bortolotto, con la sua sensibilità da rabdomante,<br />
sorretta dal dominio di letture sconfinate e dalla capacità<br />
di riattivarle entro prospettive attuali, segnala alcuni<br />
indizi preziosi, luci penetranti, utili a orientarci, seppur come<br />
sprazzi fugaci dell’inconscio, entro la fascinosa, non di<br />
rado disarmante, oscurità. È quanto, appunto,<br />
va attraversando l’animo di Sachs, quel suo<br />
modo di praticare il ruolo di «maestro»,<br />
consapevole che il rispetto della regola<br />
non può non divenire proiezione<br />
di nuove situazioni, di nuovi sentimenti.<br />
Motivo centrale dell’opera,<br />
questo, attestato dalla diversità<br />
delle reazioni: «Hanslick<br />
perse il controllo: “se i Meistersinger<br />
diventassero regola, sarebbe<br />
la fine di tutta la musica”;<br />
Nietzsche non si entusiasmò. Ma<br />
Brahms li predilesse, avendo vissuto<br />
quel dilemma come una spina<br />
nella carne» (p. 346).<br />
Allo stesso modo, proprio attraverso<br />
questo percorso sotterraneo, Bortolotto<br />
rivolge altrettanta attenzione<br />
a Beckmesser, liberandolo dalle insistite<br />
ristrettezze di certi tratti grotteschi<br />
appartenenti a un consunto<br />
oleografismo, al quale pure sottrae<br />
gli altri Maestri, per ritrovare<br />
più profonde radici di quell’inclinazione comica<br />
che, non va dimenticato, aveva rappresentato l’originario,<br />
benché tutto da decodificare, obiettivo di Wagner; di là dalla<br />
superficie, dunque, è l’humus diversamente fermentante<br />
che opera, quella «gaiezza propriamente ed unicamente tedesca»<br />
colta da Nietzsche, il quale, pur non entusiasta, aveva<br />
compreso il tessuto più segreto entro cui le varie tematiche,<br />
come in un contrappunto arioso eppur necessario, vanno<br />
intersecandosi. Persino il tema, più perigliosamente esposto,<br />
dello spirito patrio: «queste cose – aveva detto il filosofo<br />
– debbono venir intese artisticamente, non dogmaticamente.<br />
Anche il nazionalismo tedesco fa parte di ciò».<br />
Il Wahn, dunque, come chiave per penetrare l’oscuro, nella<br />
sofferta consapevolezza di Sachs (in questo davvero un doppio<br />
di Wagner) che carattere dominante della poesia è la dimensione<br />
onirica. Quella che, infine, troverà nell’estremo cimento<br />
poetico di Walter la forza fecondante dell’amore: non<br />
più il «malvagio spettro della notte», chiarisce Bortolotto a<br />
riscontro di Tristan, «ma illuminazione benigna» (p. 351).<br />
«Illuminazione benigna» e «follia d’amore» sono i termini<br />
per rilevare le differenze tra le due opere contigue: diverse<br />
ma non contrastanti, sembra pensare Bortolotto, il<br />
Il provetto stregone 69