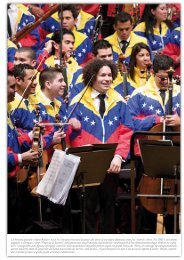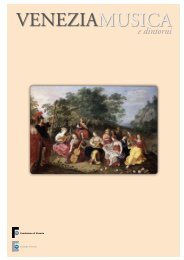VeneziaMusicaedintorni 48 - RIVISTA COMPLETA - Euterpe Venezia
VeneziaMusicaedintorni 48 - RIVISTA COMPLETA - Euterpe Venezia
VeneziaMusicaedintorni 48 - RIVISTA COMPLETA - Euterpe Venezia
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
72<br />
Mario Bortolotto e le vie della musicologia<br />
L’anima del Lied<br />
di Alberto Caprioli<br />
I<br />
libri di Mario Bortolotto non sono soltanto libri<br />
da leggere, sono anche libri da ascoltare, perché parlano.<br />
Come nel caso del magistrale trattato sul Lied romantico<br />
apparso in due edizioni e in varie ristampe tra<br />
il 1962 e oggi, che il suo autore intitola con falsa modestia Introduzione,<br />
e che, al momento della sua riedizione nel 1984,<br />
giudica, addirittura, «impolverato profilo»: Sternenstaub,<br />
diremmo noi piuttosto, quella polvere di stelle che per gli<br />
astrofisici indica il prodotto di novae e supernovae, che il Nostro<br />
ritrasforma da sostantivi di nuovo in aggettivi.<br />
Essendo musicisti, ci si accorge che sono libri scritti da una<br />
mente in continuo dialogo con il proprio orecchio di musicista;<br />
libri che parlano una lingua che alterna ai continui riferimenti<br />
filosofici, artistici, letterari, finanche antropologici,<br />
una verifica incessante sul campo, sul tavolo talora spoglio,<br />
talora straordinariamente adorno di un’anatomia dei pensieri<br />
e dei sentimenti oltre che delle forme, delle attitudini<br />
superficiali e delle strutture profonde.<br />
Chi fosse abituato a confrontarsi con i saggi della maggior<br />
parte dei musicologi, dopo aver letto le prime due pagine di<br />
Introduzione al Lied romantico, comincerebbe a sfogliare<br />
questo, come tanti altri libri di Bortolotto, ricercandone i<br />
capitoli, i paragrafi, l’indice dei nomi; dimenticando che<br />
un’«introduzione» è appunto come un’ouverture, dove i<br />
temi o i Leitmotive dei personaggi si presentano a raccontarli,<br />
a difenderli, talvolta a rimpiangerli, ancor prima dei personaggi<br />
stessi. Ma in questo caso non si tratta di un’ouverture<br />
o di una sinfonia in stile italiano, bensì di una pièce sinfonica<br />
per grande orchestra, una Symphonische Dichtung generatrice<br />
di idee, così come la potrebbe concepire in musica un<br />
Richard Strauss (una lunga frase poematico-sinfonica accompagnata<br />
da una miriade iridescente e incessante di contrappunti<br />
intellettuali, di fermate reali, che fungono da perno<br />
per digressioni continue, ma segretamente e astutamente<br />
organizzate), dove l’ossimoro<br />
con il camerismo del Lied<br />
è artificio volontario<br />
e rende ragione della<br />
inimmaginabile<br />
portata di quella<br />
che si potrebbe<br />
chiamare una<br />
paginetta di<br />
Schubert, di<br />
Schumann<br />
o di Wolf.<br />
Di questa<br />
apparentemente<br />
infinita<br />
Erlösung<br />
d e l l a<br />
forma rimane<br />
la<br />
lucidità<br />
Novalis.<br />
dei timbri, la riconoscibilità degli accenti, la pregnanza delle<br />
dramatis personae, chiamate in causa nella loro chiara contestualità<br />
da manuale di alta geografia delle idee; la distillata<br />
sapienza della citazione appropriata, che non è mai, neppure<br />
nei casi e nei generi più intricati e sibillini, jeu de mots fine a se<br />
stesso, ma diviene viva carne e sangue pulsante del corpo del<br />
testo e dei suoi tessuti:<br />
con trame e orditi talvolta<br />
paralleli o trasversali<br />
che, se non esistono in<br />
natura, vengono creati<br />
da Bortolotto in preziosi<br />
artifici di autentica ars<br />
retorica: un invito al lettore<br />
a divenire l’interlocutore<br />
e l’artefice di uno<br />
scambio continuo.<br />
Bortolotto, da viennese<br />
(oltre che francese) di<br />
origine, prima ancora<br />
che di adozione, esordisce,<br />
inaspettatamente,<br />
con una disamina degli<br />
aspetti contraddittori di<br />
quello che chiama «il<br />
fondamento proibito»<br />
della storiografia tedesca<br />
del Lied, partendo<br />
dalle origini linguistiche<br />
e musicali del termine,<br />
dalla sua pretesa derivazione<br />
antica, germanica e<br />
popolare, con le conseguenti interpretazioni storiografiche,<br />
che oggi gli storici definirebbero sous surveillance.<br />
E in questa introduzione all’introduzione, che si salda al<br />
resto del trattato con l’accelerando proprio delle Einleitungen<br />
delle sinfonie schumanniane, già compaiono scaglie cristalline<br />
di metalli rari, di quelli che erano ancora da scoprire<br />
al tempo dell’alchimia, nel quale certa musicologia italiana<br />
giaceva allora wie eingeschlummert. Un esempio per tutti<br />
(non credevo ai miei occhi quando ho visto, nell’edizione<br />
del 1962, esattamente le stesse parole dell’edizione 1984: in<br />
quel caso nulla era stato aggiunto): quando nella prima pagina<br />
l’autore parla di Stilkritik, in un contesto che, se all’inizio<br />
degli anni sessanta poteva apparire connesso alle discipline<br />
artistiche e all’archeologia, è oggi invece inderogabilmente<br />
legato al suo côté storico-antropologico, non fa altro che<br />
anticipare di quarant’anni, con una fulminante intuizione,<br />
uno dei temi à la page dell’odierna semiotica, tanto da essere<br />
inserito tra i fili conduttori dell’XI Convegno internazionale<br />
della Deutsche Gesellschaft für Semiotik del 2005, intitolato<br />
per l’appunto Stil als Zeichen. Funktionen – Brüche<br />
– Inszenierungen (Stile come segno. Funzioni – trasgressioni –<br />
messinscene), ove un’intera sezione presenta una ricerca della<br />
cattedra di letteratura comparata e comunicazioni (Lehrstuhl<br />
für Vergleichende Literaturwissenschaft und Medienforschung)<br />
dell’Università europea Viadrina di Francoforte<br />
sull’Oder, intitolata per l’appunto Critica stilistica storica e<br />
antropologia. E la sensazione che si tratti di un presagio, di<br />
un’«illuminazione», si concretizza una trentina di pagine<br />
più avanti (per l’esattezza alla p. 32 dell’edizione Piccola<br />
biblioteca Adelphi, p. 31 della prima edizione nella Piccola<br />
biblioteca Ricordi), dove tra gli autori menzionati, al seguito<br />
di Theodor Wiesengrund Adorno, compare Claude Lévi-<br />
Strauss, sette anni prima che Luciano Berio ne utilizzasse i<br />
testi in Sinfonia (1968-1969). Di Lévi-Strauss, oltre ai Tristes<br />
tropiques del 1955 e all’Anthropologie structurale del ’58, si