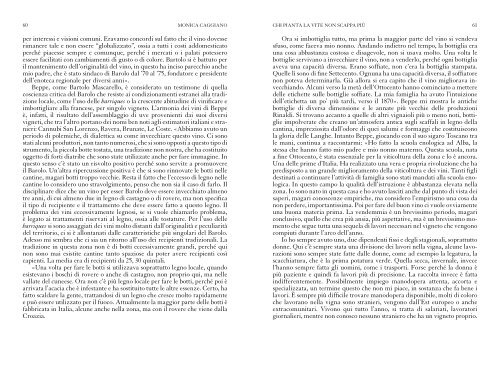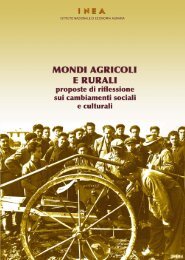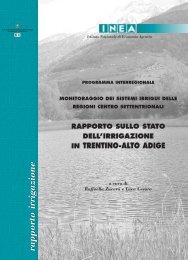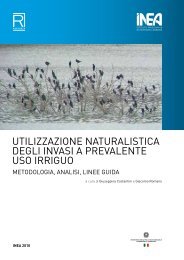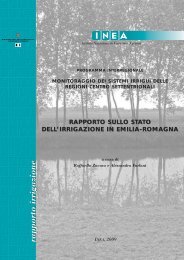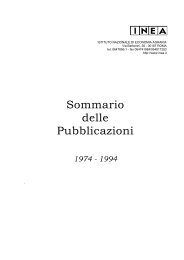Vite contadine - Inea
Vite contadine - Inea
Vite contadine - Inea
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
60 MONICA CAGGIANO<br />
per interessi e visioni comuni. Eravamo concordi sul fatto che il vino dovesse<br />
rimanere tale e non essere “globalizzato”, ossia a tutti i costi addomesticato<br />
perché piacesse sempre e comunque, perché i mercati o i palati potessero<br />
essere facilitati con cambiamenti di gusto o di colore. Bartolo si è battuto per<br />
il mantenimento dell’originalità del vino, in questo ha inciso parecchio anche<br />
mio padre, che è stato sindaco di Barolo dal ’70 al ’75, fondatore e presidente<br />
dell’enoteca regionale per diversi anni».<br />
Beppe, come Bartolo Mascarello, è considerato un testimone di quella<br />
coscienza critica del Barolo che resiste ai condizionamenti estranei alla tradizione<br />
locale, come l’uso delle barriques o la crescente abitudine di vinificare e<br />
imbottigliare alla francese, per singolo vigneto. L’armonia dei vini di Beppe<br />
è, infatti, il risultato dell’assemblaggio di uve provenienti dai suoi diversi<br />
vigneti, che tra l’altro portano dei nomi ben noti agli estimatori italiani e stranieri:<br />
Cannubi San Lorenzo, Ravera, Brunate, Le Coste. «Abbiamo avuto un<br />
periodo di polemiche, di dialettica su come invecchiare questo vino. Ci sono<br />
stati alcuni produttori, non tanto numerosi, che si sono opposti a questo tipo di<br />
strumento, la piccola botte tostata, una tradizione non nostra, che ha costituito<br />
oggetto di forti diatribe che sono state utilizzate anche per fare immagine. In<br />
questo senso c’è stato un risvolto positivo perché sono servite a promuovere<br />
il Barolo. Un’altra ripercussione positiva è che si sono rinnovate le botti nelle<br />
cantine, magari botti troppo vecchie. Resta il fatto che l’eccesso di legno nelle<br />
cantine lo considero uno stravolgimento, penso che non sia il caso di farlo. Il<br />
disciplinare dice che un vino per esser Barolo deve essere invecchiato almeno<br />
tre anni, di cui almeno due in legno di castagno o di rovere, ma non specifica<br />
il tipo di recipiente e il trattamento che deve essere fatto a questo legno. Il<br />
problema dei vini eccessivamente legnosi, se si vuole chiamarlo problema,<br />
è legato ai trattamenti riservati al legno, ossia alle tostature. Per l’uso delle<br />
barriques si sono assaggiati dei vini molto distanti dall’originalità e peculiarità<br />
del territorio, ci si è allontanati dalle caratteristiche più singolari del Barolo.<br />
Adesso mi sembra che ci sia un ritorno all’uso dei recipienti tradizionali. La<br />
tradizione in questa zona non è di botti eccessivamente grandi, perché qui<br />
non sono mai esistite cantine tanto spaziose da poter avere recipienti così<br />
capienti. La media era di recipienti da 25, 30 quintali.<br />
«Una volta per fare le botti si utilizzava soprattutto legno locale, quando<br />
esistevano i boschi di rovere o anche di castagno, non proprio qui, ma nelle<br />
vallate del cuneese. Ora non c’è più legno locale per fare le botti, perché poi è<br />
arrivata l’acacia che è infestante e ha sostituito tutte le altre essenze. Certo, ha<br />
fatto scaldare la gente, trattandosi di un legno che cresce molto rapidamente<br />
e può essere utilizzato per il fuoco. Attualmente la maggior parte delle botti è<br />
fabbricata in Italia, alcune anche nella zona, ma con il rovere che viene dalla<br />
Croazia.<br />
CHI PIANTA LA VITE NON SCAPPA PIù<br />
Ora si imbottiglia tutto, ma prima la maggior parte del vino si vendeva<br />
sfuso, come faceva mio nonno. Andando indietro nel tempo, la bottiglia era<br />
una cosa abbastanza costosa e disagevole, non si usava molto. Una volta le<br />
bottiglie servivano a invecchiare il vino, non a venderlo, perché ogni bottiglia<br />
aveva una capacità diversa. Erano soffiate, non c’era la bottiglia stampata.<br />
Quelle lì sono di fine Settecento. Ognuna ha una capacità diversa, il soffiatore<br />
non poteva determinarla. Già allora si era capito che il vino migliorava invecchiando.<br />
Alcuni verso la metà dell’Ottocento hanno cominciato a mettere<br />
delle etichette sulle bottiglie soffiate. La mia famiglia ha avuto l’intuizione<br />
dell’etichetta un po’ più tardi, verso il 1870». Beppe mi mostra le antiche<br />
bottiglie di diversa dimensione e le annate più vecchie delle produzioni<br />
Rinaldi. Si trovano accanto a quelle di altri vignaioli più o meno noti, bottiglie<br />
impolverate che creano un’atmosfera antica sugli scaffali in legno della<br />
cantina, impreziosita dall’odore di quei salumi e formaggi che costituiscono<br />
la gloria delle Langhe. Intanto Beppe, giocando con il suo sigaro Toscano tra<br />
le mani, continua a raccontarmi: «Ho fatto la scuola enologica ad Alba, la<br />
stessa che hanno fatto mio padre e mio nonno materno. Questa scuola, nata<br />
a fine Ottocento, è stata essenziale per la viticoltura della zona e lo è ancora.<br />
Una delle prime d’Italia. Ha realizzato una vera e propria rivoluzione che ha<br />
predisposto a un grande miglioramento della viticoltura e dei vini. Tanti figli<br />
destinati a continuare l’attività di famiglia sono stati mandati alla scuola enologica.<br />
In questo campo la qualità dell’istruzione è abbastanza elevata nella<br />
zona. Io sono nato in questa casa e ho avuto lasciti anche dal punto di vista dei<br />
saperi, magari conoscenze empiriche, ma considero l’empirismo una cosa da<br />
non perdere, importantissima. Poi per fare del buon vino ci vuole ovviamente<br />
una buona materia prima. La vendemmia è un brevissimo periodo, magari<br />
conclusivo, quello che crea più ansia, più aspettative, ma è un brevissimo momento<br />
che segue tutta una sequela di lavori necessari nel vigneto che vengono<br />
compiuti durante l’arco dell’anno.<br />
Io ho sempre avuto uno, due dipendenti fissi e degli stagionali, soprattutto<br />
donne. Qui c’è sempre stata una divisione dei lavori nella vigna, alcune lavorazioni<br />
sono sempre state fatte dalle donne, come ad esempio la legatura, la<br />
scacchiatura, che è la prima potatura verde. Quella secca, invernale, invece<br />
l’hanno sempre fatta gli uomini, come i trasporti. Forse perché la donna è<br />
più paziente e quindi fa lavori più di precisione. La raccolta invece è fatta<br />
indifferentemente. Possibilmente impiego manodopera attenta, accorta e<br />
specializzata, un termine questo che non mi piace, in sostanza che fa bene i<br />
lavori. È sempre più difficile trovare manodopera disponibile, molti di coloro<br />
che lavorano nella vigna sono stranieri, vengono dall’Est europeo o anche<br />
extracomunitari. Vivono qui tutto l’anno, si tratta di salariati, lavoratori<br />
giornalieri, mentre non conosco nessuno straniero che ha un vigneto proprio.<br />
61