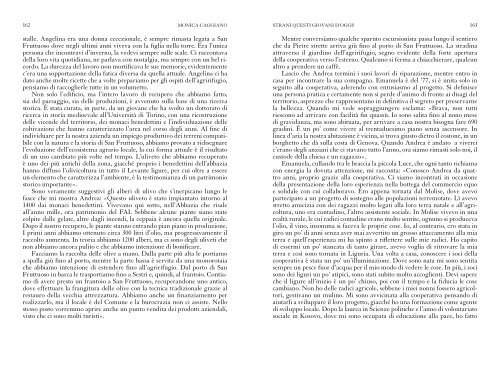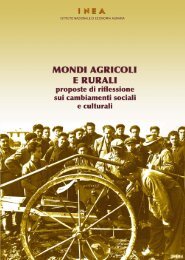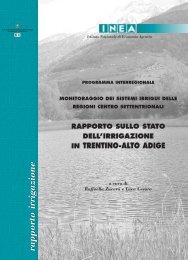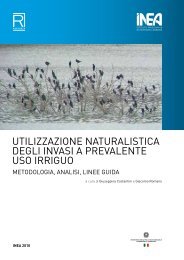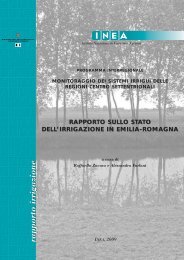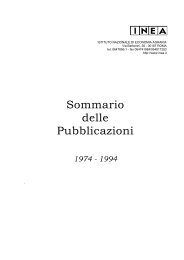Vite contadine - Inea
Vite contadine - Inea
Vite contadine - Inea
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
162 MONICA CAGGIANO<br />
STRANI QUESTI GIOVANI D’OGGI!<br />
163<br />
stalle. Angelina era una donna eccezionale, è sempre rimasta legata a San<br />
Fruttuoso dove negli ultimi anni viveva con la figlia nella torre. Era l’unica<br />
persona che incontravi d’inverno, la vedevi sempre sulle scale. Ci raccontava<br />
della loro vita quotidiana, ne parlava con nostalgia, ma sempre con un bel ricordo.<br />
La durezza del lavoro non mortificava le sue memorie, evidentemente<br />
c’era una sopportazione della fatica diversa da quella attuale. Angelina ci ha<br />
dato anche molte ricette che a volte prepariamo per gli ospiti dell’agririfugio,<br />
pensiamo di raccoglierle tutte in un volumetto.<br />
Non solo l’edificio, ma l’intero lavoro di recupero che abbiamo fatto,<br />
sia del paesaggio, sia delle produzioni, è avvenuto sulla base di una ricerca<br />
storica. È stata curata, in parte, da un giovane che ha svolto un dottorato di<br />
ricerca in storia medioevale all’Università di Torino, con una ricostruzione<br />
delle vicende del territorio, dei monaci benedettini e l’individuazione delle<br />
coltivazioni che hanno caratterizzato l’area nel corso degli anni. Al fine di<br />
individuare per la nostra azienda un impiego produttivo dei terreni compatibile<br />
con la natura e la storia di San Fruttuoso, abbiamo provato a ridisegnare<br />
l’evoluzione dell’ecosistema agrario locale, la cui forma attuale è il risultato<br />
di un uso cambiato più volte nel tempo. L’uliveto che abbiamo recuperato<br />
è uno dei più antichi della zona, giacché proprio i benedettini dell’abbazia<br />
hanno diffuso l’olivicoltura in tutto il Levante ligure, per cui oltre a essere<br />
un elemento che caratterizza l’ambiente, è la testimonianza di un patrimonio<br />
storico importante».<br />
Sono veramente suggestivi gli alberi di ulivo che s’inerpicano lungo le<br />
fasce che mi mostra Andrea: «Questo uliveto è stato impiantato intorno al<br />
1400 dai monaci benedettini. Vivevano qui sotto, nell’Abbazia che risale<br />
all’anno mille, ora patrimonio del FAI. Sebbene alcune piante siano state<br />
colpite dalle gelate, altre dagli incendi, la ceppaia è ancora quella originale.<br />
Dopo il nostro recupero, le piante stanno entrando pian piano in produzione.<br />
I primi anni abbiamo ottenuto circa 300 litri d’olio, ma progressivamente il<br />
raccolto aumenta. In teoria abbiamo 1200 alberi, ma ci sono degli uliveti che<br />
non abbiamo ancora pulito e che abbiamo intenzione di bonificare.<br />
Facciamo la raccolta delle olive a mano. Dalla parte più alta le portiamo<br />
a spalla giù fino al porto, mentre la parte bassa è servita da una monorotaia<br />
che abbiamo intenzione di estendere fino all’agririfugio. Dal porto di San<br />
Fruttuoso in barca le trasportiamo fino a Sestri e, quindi, al frantoio. Contiamo<br />
di avere presto un frantoio a San Fruttuoso, recuperandone uno antico,<br />
dove effettuare la frangitura delle olive con la tecnica tradizionale grazie al<br />
restauro della vecchia attrezzatura. Abbiamo anche un finanziamento per<br />
realizzarlo, ma il locale è del Comune e la burocrazia non ci assiste. Nello<br />
stesso posto vorremmo aprire anche un punto vendita dei prodotti aziendali,<br />
visto che ci sono molti turisti».<br />
Mentre conversiamo qualche sparuto escursionista passa lungo il sentiero<br />
che da Pietre strette arriva giù fino al porto di San Fruttuoso. La stradina<br />
attraversa il giardino dell’agririfugio, segno evidente della forte apertura<br />
della cooperativa verso l’esterno. Qualcuno si ferma a chiacchierare, qualcun<br />
altro a prendere un caffè.<br />
Lascio che Andrea termini i suoi lavori di riparazione, mentre entro in<br />
casa per incontrare la sua compagna. Emanuela è del ’77, si è unita solo in<br />
seguito alla cooperativa, aderendo con entusiasmo al progetto. Si definisce<br />
una persona pratica e certamente non si perde d’animo di fronte ai disagi del<br />
territorio, asprezze che rappresentano in definitiva il segreto per preservarne<br />
la bellezza. Quando mi vede sopraggiungere esclama: «Brava, non tutti<br />
riescono ad arrivare con facilità fin quassù. Io sono salita fino al nono mese<br />
di gravidanza, ma sono abituata, per arrivare a casa nostra bisogna fare 690<br />
gradini. È un po’ come vivere al trentaduesimo piano senza ascensore. In<br />
linea d’aria la nostra abitazione è vicina, si trova giusto dietro il costone, in un<br />
borghetto che dà sulla costa di Genova. Quando Andrea è andato a viverci<br />
c’erano degli anziani che ci stavano tutto l’anno, ora siamo rimasti solo noi, il<br />
custode della chiesa e un ragazzo».<br />
Emanuela, cullando tra le braccia la piccola Luce, che ogni tanto richiama<br />
con energia la dovuta attenzione, mi racconta: «Conosco Andrea da quattro<br />
anni, proprio grazie alla cooperativa. Ci siamo incontrati in occasione<br />
della presentazione della loro esperienza nella bottega del commercio equo<br />
e solidale con cui collaboravo. Ero appena tornata dal Molise, dove avevo<br />
partecipato a un progetto di sostegno alle popolazioni terremotate. Lì avevo<br />
stretto amicizia con dei ragazzi molto legati alla loro terra natale e all’agricoltura,<br />
uno era contadino, l’altro assistente sociale. In Molise vivevo in una<br />
realtà rurale, le cui radici <strong>contadine</strong> erano molto sentite, ognuno si produceva<br />
l’olio, il vino, insomma si faceva le proprie cose. Io, al contrario, ero stata in<br />
giro un po’ di anni senza aver mai avvertito un grosso attaccamento alla mia<br />
terra e quell’esperienza mi ha spinto a riflettere sulle mie radici. Ho capito<br />
di essermi un po’ stancata di tanto girare, avevo voglia di ritrovare la mia<br />
terra e così sono tornata in Liguria. Una volta a casa, conoscere i soci della<br />
cooperativa è stata un po’ un’illuminazione. Dove sono nata mi sono sentita<br />
sempre un pesce fuor d’acqua per il mio modo di vedere le cose. In più, i soci<br />
sono dei liguri un po’ atipici, sono stati subito molto accoglienti. Devi sapere<br />
che il ligure all’inizio è un po’ chiuso, poi con il tempo e la fiducia le cose<br />
cambiano. Non ho delle radici agricole, sebbene i miei nonni fossero agricoltori,<br />
gestivano un mulino. Mi sono avvicinata alla cooperativa pensando di<br />
aiutarli a sviluppare il loro progetto, giacché ho una formazione come agente<br />
di sviluppo locale. Dopo la laurea in Scienze politiche e l’anno di volontariato<br />
sociale in Kosovo, dove mi sono occupata di educazione alla pace, ho fatto