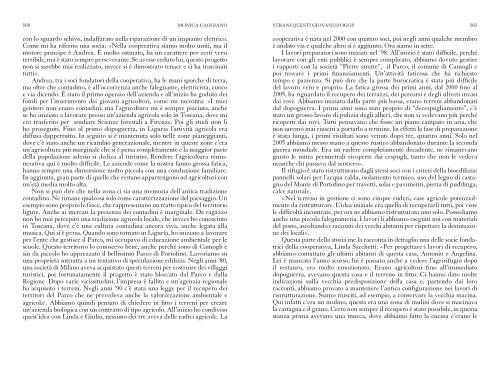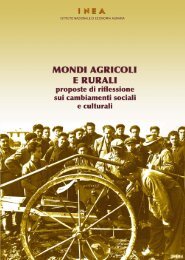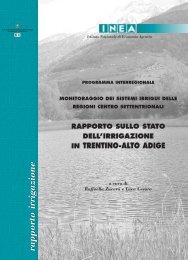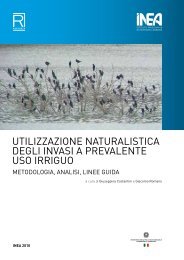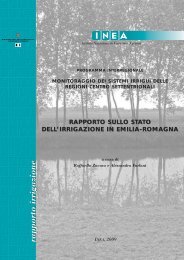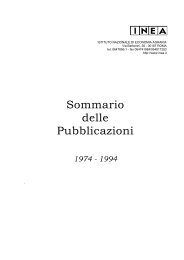Vite contadine - Inea
Vite contadine - Inea
Vite contadine - Inea
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
160 MONICA CAGGIANO<br />
STRANI QUESTI GIOVANI D’OGGI!<br />
161<br />
con lo sguardo schivo, indaffarato nella riparazione di un impianto elettrico.<br />
Come mi ha riferito una socia: «Nella cooperativa siamo molto uniti, ma il<br />
motore principe è Andrea. È molto ostinato, ha un carattere per certi versi<br />
terribile, ma è stato sempre perseverante. Se avesse ceduto lui, questo progetto<br />
non si sarebbe mai realizzato, invece si è dimostrato tenace e ci ha trascinati<br />
tutti».<br />
Andrea, tra i soci fondatori della cooperativa, ha le mani sporche di terra,<br />
ma oltre che contadino, è all’occorrenza anche falegname, elettricista, cuoco<br />
e via dicendo. È stato il primo operaio dell’azienda e all’inizio ha goduto dei<br />
fondi per l’inserimento dei giovani agricoltori, come mi racconta: «I miei<br />
genitori non erano contadini, ma l’agricoltura mi è sempre piaciuta, anche<br />
se ho iniziato a lavorare presso un’azienda agricola solo in Toscana, dove mi<br />
ero trasferito per studiare Scienze forestali a Firenze. Poi gli studi non li<br />
ho proseguiti. Fino al primo dopoguerra, in Liguria l’attività agricola era<br />
diffusa dappertutto. In seguito si è mantenuta solo nelle zone pianeggianti,<br />
dove c’è stato anche un ricambio generazionale, mentre in queste zone c’era<br />
un’agricoltura più marginale che si è persa completamente e la maggior parte<br />
della popolazione adesso si dedica al turismo. Rendere l’agricoltura remunerativa<br />
qui è molto difficile. Le aziende come la nostra fanno grossa fatica,<br />
hanno sempre una dimensione molto piccola con una conduzione familiare.<br />
In aggiunta, gran parte di quelle che restano appartengono ad agricoltori con<br />
un’età media molto alta.<br />
Non si può dire che nella zona ci sia una memoria dell’antica tradizione<br />
contadina. Ne rimane qualcosa solo come caratterizzazione del paesaggio. Un<br />
esempio sono proprio le fasce, che rappresentano un tratto tipico del territorio<br />
ligure. Anche ai mercati la presenza dei contadini è marginale. Da ragazzo<br />
non ho mai percepito una tradizione agricola locale, che invece ho conosciuto<br />
in Toscana, dove c’è una cultura contadina ancora viva, anche legata alla<br />
musica. Qui si è persa. Quando sono tornato in Liguria, ho iniziato a lavorare<br />
per l’ente che gestisce il Parco, mi occupavo di educazione ambientale per le<br />
scuole. Questo territorio lo conoscevo bene, anche perché sono di Camogli e<br />
sin da piccolo ho apprezzato il bellissimo Parco di Portofino. Lavoriamo su<br />
una proprietà sottratta a un tentativo di speculazione edilizia. Negli anni ’80,<br />
una società di Milano aveva acquistato questi terreni per costruire dei villaggi<br />
turistici, poi fortunatamente il progetto è stato bloccato dal Parco e dalla<br />
Regione. Dopo varie vicissitudini, l’impresa è fallita e un’agenzia regionale<br />
ha acquisito i terreni. Negli anni ’90 c’è stata una legge per il recupero dei<br />
territori del Parco che ne prevedeva anche la valorizzazione ambientale e<br />
agricola 1 . Abbiamo quindi pensato di chiedere in fitto i terreni per creare<br />
un’azienda biologica con un contratto di tipo agricolo. All’inizio ho condiviso<br />
quest’idea con Linda e Giulio, nessuno dei tre aveva delle radici agricole. La<br />
cooperativa è nata nel 2000 con quattro soci, poi negli anni qualche membro<br />
è andato via e qualche altro si è aggiunto. Ora siamo in sette.<br />
I lavori preparatori sono iniziati nel ’98. All’inizio è stato difficile, perché<br />
lavorare con gli enti pubblici è sempre complicato, abbiamo dovuto gestire<br />
i rapporti con la società “Pietre strette”, il Parco, il comune di Camogli e<br />
poi trovare i primi finanziamenti. Un’attività faticosa che ha richiesto<br />
tempo e pazienza. Si può dire che la parte burocratica è stata più difficile<br />
del lavoro vero e proprio. La fatica grossa dei primi anni, dal 2000 fino al<br />
2005, ha riguardato il recupero dei terrazzi, dei percorsi e degli uliveti invasi<br />
dai rovi. Abbiamo iniziato dalla parte più bassa, erano terreni abbandonati<br />
dal dopoguerra. I primi anni sono stati proprio di “decespugliamento”, c’è<br />
stato un grosso lavoro di pulizia degli alberi, che non si vedevano più perché<br />
ricoperti dai rovi. Tutti pensavano che fosse un piano campato in aria, che<br />
non saremo mai riusciti a portarlo a termine. In effetti la fase di preparazione<br />
è stata lunga, i primi risultati sono venuti dopo tre, quattro anni. Solo nel<br />
2005 abbiamo messo mano a questo rustico abbandonato durante la seconda<br />
guerra mondiale. Era un rudere completamente decadente, ne rimanevano<br />
giusto le mura perimetrali ricoperte dai cespugli, tanto che non le vedeva<br />
neanche chi passava dal sentiero».<br />
Il rifugio è stato ristrutturato dagli stessi soci con i criteri della bioedilizia:<br />
pannelli solari per l’acqua calda, isolamento termico, uso del legno di castagno<br />
del Monte di Portofino per travetti, solai e pavimenti, pietra di puddinga,<br />
calce naturale.<br />
«Nel terreno in gestione ci sono cinque ruderi, case agricole potenzialmente<br />
da ristrutturare. L’idea iniziale era quella di recuperarli tutti, poi viste<br />
le difficoltà incontrate, per ora ne abbiamo ristrutturato uno solo. Possediamo<br />
anche una piccola falegnameria. I lavori li abbiamo eseguiti noi con materiali<br />
del posto, ascoltando i racconti dei vecchi abitanti per rispettare la destinazione<br />
dei locali».<br />
Questa parte della storia me la racconta in dettaglio una delle socie fondatrici<br />
della cooperativa, Linda Sacchetti: «Per progettare i lavori di recupero,<br />
abbiamo contattato gli ultimi abitanti di questa casa, Antonio e Angelina.<br />
Lei è mancata l’anno scorso, lui è passato anche a vedere l’agririfugio dopo<br />
il restauro, era molto emozionato. Erano agricoltori fino all’immediato<br />
dopoguerra, avevano questa casa e il terreno in fitto. Ci hanno dato molte<br />
indicazioni sulla vecchia predisposizione della casa e, partendo dai loro<br />
racconti, abbiamo provato a mantenere l’antica configurazione nei lavori di<br />
ristrutturazione. Siamo riusciti, ad esempio, a conservare la vecchia macina.<br />
Qui infatti c’era un mulino, questa era una zona di mulini dove si macinava<br />
la castagna e il grano. Certo non sempre il recupero è stato possibile, in questa<br />
stanza prima avevano una mucca, dove abbiamo fatto la cucina c’erano le