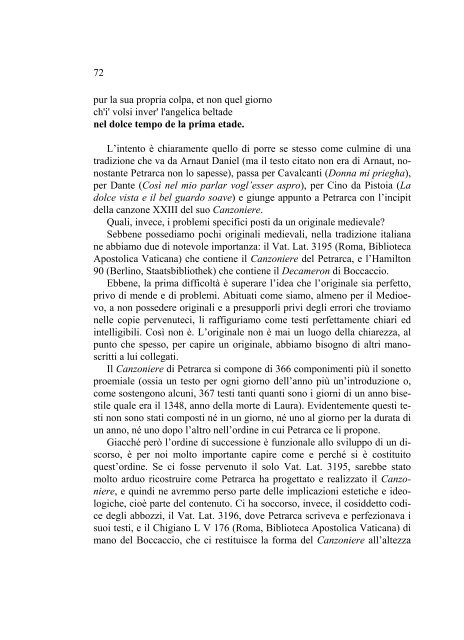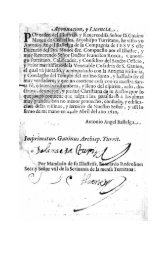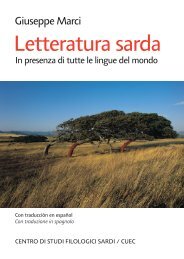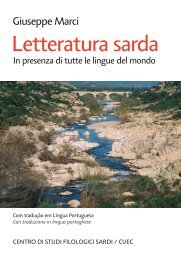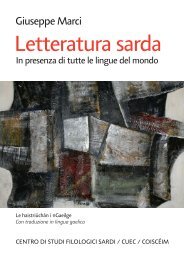1. La tradizione - Centro di studi Filologici Sardi
1. La tradizione - Centro di studi Filologici Sardi
1. La tradizione - Centro di studi Filologici Sardi
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
72<br />
pur la sua propria colpa, et non quel giorno<br />
ch'i' volsi inver' l'angelica beltade<br />
nel dolce tempo de la prima etade.<br />
L’intento è chiaramente quello <strong>di</strong> porre se stesso come culmine <strong>di</strong> una<br />
<strong>tra<strong>di</strong>zione</strong> che va da Arnaut Daniel (ma il testo citato non era <strong>di</strong> Arnaut, nonostante<br />
Petrarca non lo sapesse), passa per Cavalcanti (Donna mi priegha),<br />
per Dante (Così nel mio parlar vogl’esser aspro), per Cino da Pistoia (<strong>La</strong><br />
dolce vista e il bel guardo soave) e giunge appunto a Petrarca con l’incipit<br />
della canzone XXIII del suo Canzoniere.<br />
Quali, invece, i problemi specifici posti da un originale me<strong>di</strong>evale?<br />
Sebbene posse<strong>di</strong>amo pochi originali me<strong>di</strong>evali, nella <strong>tra<strong>di</strong>zione</strong> italiana<br />
ne abbiamo due <strong>di</strong> notevole importanza: il Vat. <strong>La</strong>t. 3195 (Roma, Biblioteca<br />
Apostolica Vaticana) che contiene il Canzoniere del Petrarca, e l’Hamilton<br />
90 (Berlino, Staatsbibliothek) che contiene il Decameron <strong>di</strong> Boccaccio.<br />
Ebbene, la prima <strong>di</strong>fficoltà è superare l’idea che l’originale sia perfetto,<br />
privo <strong>di</strong> mende e <strong>di</strong> problemi. Abituati come siamo, almeno per il Me<strong>di</strong>oevo,<br />
a non possedere originali e a presupporli privi degli errori che troviamo<br />
nelle copie pervenuteci, li raffiguriamo come testi perfettamente chiari ed<br />
intelligibili. Così non è. L’originale non è mai un luogo della chiarezza, al<br />
punto che spesso, per capire un originale, abbiamo bisogno <strong>di</strong> altri manoscritti<br />
a lui collegati.<br />
Il Canzoniere <strong>di</strong> Petrarca si compone <strong>di</strong> 366 componimenti più il sonetto<br />
proemiale (ossia un testo per ogni giorno dell’anno più un’introduzione o,<br />
come sostengono alcuni, 367 testi tanti quanti sono i giorni <strong>di</strong> un anno bisestile<br />
quale era il 1348, anno della morte <strong>di</strong> <strong>La</strong>ura). Evidentemente questi testi<br />
non sono stati composti né in un giorno, né uno al giorno per la durata <strong>di</strong><br />
un anno, né uno dopo l’altro nell’or<strong>di</strong>ne in cui Petrarca ce li propone.<br />
Giacché però l’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> successione è funzionale allo sviluppo <strong>di</strong> un <strong>di</strong>scorso,<br />
è per noi molto importante capire come e perché si è costituito<br />
quest’or<strong>di</strong>ne. Se ci fosse pervenuto il solo Vat. <strong>La</strong>t. 3195, sarebbe stato<br />
molto arduo ricostruire come Petrarca ha progettato e realizzato il Canzoniere,<br />
e quin<strong>di</strong> ne avremmo perso parte delle implicazioni estetiche e ideologiche,<br />
cioè parte del contenuto. Ci ha soccorso, invece, il cosiddetto co<strong>di</strong>ce<br />
degli abbozzi, il Vat. <strong>La</strong>t. 3196, dove Petrarca scriveva e perfezionava i<br />
suoi testi, e il Chigiano L V 176 (Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana) <strong>di</strong><br />
mano del Boccaccio, che ci restituisce la forma del Canzoniere all’altezza