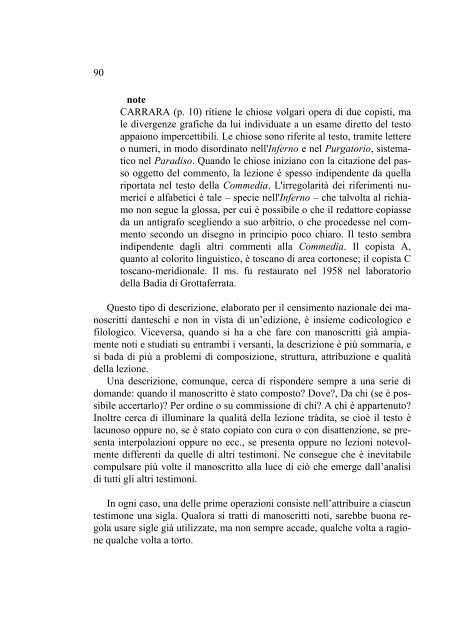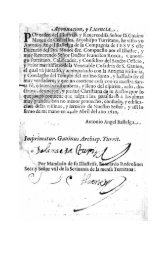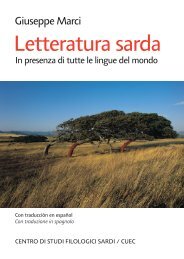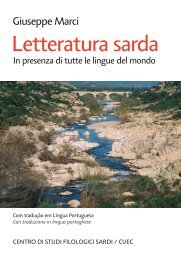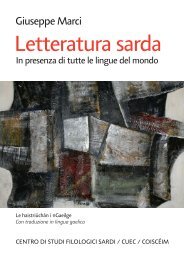1. La tradizione - Centro di studi Filologici Sardi
1. La tradizione - Centro di studi Filologici Sardi
1. La tradizione - Centro di studi Filologici Sardi
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
90<br />
note<br />
CARRARA (p. 10) ritiene le chiose volgari opera <strong>di</strong> due copisti, ma<br />
le <strong>di</strong>vergenze grafiche da lui in<strong>di</strong>viduate a un esame <strong>di</strong>retto del testo<br />
appaiono impercettibili. Le chiose sono riferite al testo, tramite lettere<br />
o numeri, in modo <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>nato nell'Inferno e nel Purgatorio, sistematico<br />
nel Para<strong>di</strong>so. Quando le chiose iniziano con la citazione del passo<br />
oggetto del commento, la lezione è spesso in<strong>di</strong>pendente da quella<br />
riportata nel testo della Comme<strong>di</strong>a. L'irregolarità dei riferimenti numerici<br />
e alfabetici è tale – specie nell'Inferno – che talvolta al richiamo<br />
non segue la glossa, per cui è possibile o che il redattore copiasse<br />
da un antigrafo scegliendo a suo arbitrio, o che procedesse nel commento<br />
secondo un <strong>di</strong>segno in principio poco chiaro. Il testo sembra<br />
in<strong>di</strong>pendente dagli altri commenti alla Comme<strong>di</strong>a. Il copista A,<br />
quanto al colorito linguistico, è toscano <strong>di</strong> area cortonese; il copista C<br />
toscano-meri<strong>di</strong>onale. Il ms. fu restaurato nel 1958 nel laboratorio<br />
della Ba<strong>di</strong>a <strong>di</strong> Grottaferrata.<br />
Questo tipo <strong>di</strong> descrizione, elaborato per il censimento nazionale dei manoscritti<br />
danteschi e non in vista <strong>di</strong> un’e<strong>di</strong>zione, è insieme co<strong>di</strong>cologico e<br />
filologico. Viceversa, quando si ha a che fare con manoscritti già ampiamente<br />
noti e stu<strong>di</strong>ati su entrambi i versanti, la descrizione è più sommaria, e<br />
si bada <strong>di</strong> più a problemi <strong>di</strong> composizione, struttura, attribuzione e qualità<br />
della lezione.<br />
Una descrizione, comunque, cerca <strong>di</strong> rispondere sempre a una serie <strong>di</strong><br />
domande: quando il manoscritto è stato composto? Dove?, Da chi (se è possibile<br />
accertarlo)? Per or<strong>di</strong>ne o su commissione <strong>di</strong> chi? A chi è appartenuto?<br />
Inoltre cerca <strong>di</strong> illuminare la qualità della lezione trà<strong>di</strong>ta, se cioè il testo è<br />
lacunoso oppure no, se è stato copiato con cura o con <strong>di</strong>sattenzione, se presenta<br />
interpolazioni oppure no ecc., se presenta oppure no lezioni notevolmente<br />
<strong>di</strong>fferenti da quelle <strong>di</strong> altri testimoni. Ne consegue che è inevitabile<br />
compulsare più volte il manoscritto alla luce <strong>di</strong> ciò che emerge dall’analisi<br />
<strong>di</strong> tutti gli altri testimoni.<br />
In ogni caso, una delle prime operazioni consiste nell’attribuire a ciascun<br />
testimone una sigla. Qualora si tratti <strong>di</strong> manoscritti noti, sarebbe buona regola<br />
usare sigle già utilizzate, ma non sempre accade, qualche volta a ragione<br />
qualche volta a torto.