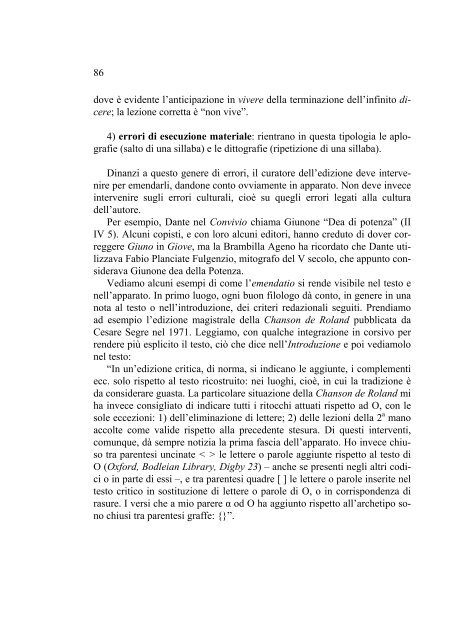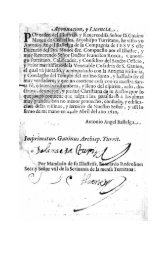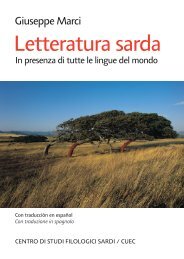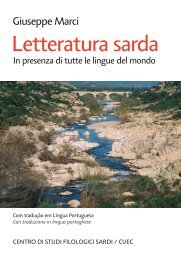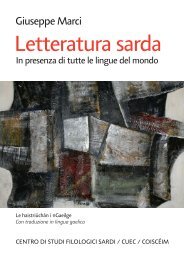1. La tradizione - Centro di studi Filologici Sardi
1. La tradizione - Centro di studi Filologici Sardi
1. La tradizione - Centro di studi Filologici Sardi
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
86<br />
dove è evidente l’anticipazione in vivere della terminazione dell’infinito <strong>di</strong>cere;<br />
la lezione corretta è “non vive”.<br />
4) errori <strong>di</strong> esecuzione materiale: rientrano in questa tipologia le aplografie<br />
(salto <strong>di</strong> una sillaba) e le <strong>di</strong>ttografie (ripetizione <strong>di</strong> una sillaba).<br />
Dinanzi a questo genere <strong>di</strong> errori, il curatore dell’e<strong>di</strong>zione deve intervenire<br />
per emendarli, dandone conto ovviamente in apparato. Non deve invece<br />
intervenire sugli errori culturali, cioè su quegli errori legati alla cultura<br />
dell’autore.<br />
Per esempio, Dante nel Convivio chiama Giunone “Dea <strong>di</strong> potenza” (II<br />
IV 5). Alcuni copisti, e con loro alcuni e<strong>di</strong>tori, hanno creduto <strong>di</strong> dover correggere<br />
Giuno in Giove, ma la Brambilla Ageno ha ricordato che Dante utilizzava<br />
Fabio Planciate Fulgenzio, mitografo del V secolo, che appunto considerava<br />
Giunone dea della Potenza.<br />
Ve<strong>di</strong>amo alcuni esempi <strong>di</strong> come l’emendatio si rende visibile nel testo e<br />
nell’apparato. In primo luogo, ogni buon filologo dà conto, in genere in una<br />
nota al testo o nell’introduzione, dei criteri redazionali seguiti. Pren<strong>di</strong>amo<br />
ad esempio l’e<strong>di</strong>zione magistrale della Chanson de Roland pubblicata da<br />
Cesare Segre nel 197<strong>1.</strong> Leggiamo, con qualche integrazione in corsivo per<br />
rendere più esplicito il testo, ciò che <strong>di</strong>ce nell’Introduzione e poi ve<strong>di</strong>amolo<br />
nel testo:<br />
“In un’e<strong>di</strong>zione critica, <strong>di</strong> norma, si in<strong>di</strong>cano le aggiunte, i complementi<br />
ecc. solo rispetto al testo ricostruito: nei luoghi, cioè, in cui la <strong>tra<strong>di</strong>zione</strong> è<br />
da considerare guasta. <strong>La</strong> particolare situazione della Chanson de Roland mi<br />
ha invece consigliato <strong>di</strong> in<strong>di</strong>care tutti i ritocchi attuati rispetto ad O, con le<br />
sole eccezioni: 1) dell’eliminazione <strong>di</strong> lettere; 2) delle lezioni della 2 a mano<br />
accolte come valide rispetto alla precedente stesura. Di questi interventi,<br />
comunque, dà sempre notizia la prima fascia dell’apparato. Ho invece chiuso<br />
tra parentesi uncinate < > le lettere o parole aggiunte rispetto al testo <strong>di</strong><br />
O (Oxford, Bodleian Library, Digby 23) – anche se presenti negli altri co<strong>di</strong>ci<br />
o in parte <strong>di</strong> essi –, e tra parentesi quadre [ ] le lettere o parole inserite nel<br />
testo critico in sostituzione <strong>di</strong> lettere o parole <strong>di</strong> O, o in corrispondenza <strong>di</strong><br />
rasure. I versi che a mio parere α od O ha aggiunto rispetto all’archetipo sono<br />
chiusi tra parentesi graffe: {}”.