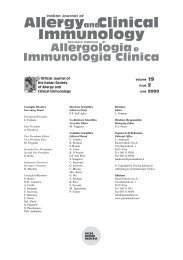Sabato 27 ottobre 2012 - Pacini Editore
Sabato 27 ottobre 2012 - Pacini Editore
Sabato 27 ottobre 2012 - Pacini Editore
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
236<br />
mas and leukemias, whereas the nodular and interstitial patterns<br />
are mainly observed in Hodgkin’s lymphoma and T-cell<br />
lymphomas respectively.<br />
references<br />
1 Addis BJ, Hyjek E, Isaacson PG. Primary pulmonary lymphoma: a reappraisal<br />
of its histogenesis and its relationship to pseudolymphoma<br />
and lymphoid interstitial pneumonia. Histopathology 1988;13:1-17.<br />
2 Chilosi M, Zinzani PL, Poletti V. Lymphoproliferative lung disorders.<br />
Semin Respir Crit Care Med 2005;26:490-501.<br />
3 Kurtin PJ, Myers JL, Adlakha H, et al. Pathologic and clinical features<br />
of primary pulmonary extranodal marginal zone B-cell lymphoma of<br />
MALT type. Am J Surg Pathol 2001;25:997-1008.<br />
4 Remstein ED, Kurtin PJ, Einerson RR, et al. Primary pulmonary<br />
MALT lymphomas show frequent and heterogeneous cytogenetic abnormalities,<br />
including aneuploidy and translocations involving API2<br />
and MALT1 and IGH and MALT1. Leukemia 2004;18:156-60.<br />
5 Guinee D Jr, Jaffe E, Kingma D, et al. Pulmonary lymphomatoid granulomatosis.<br />
Evidence for a proliferation of Epstein-Barr virus infected<br />
B-lymphocytes with a prominent T-cell component and vasculitis. Am<br />
J Surg Pathol 1994;18:753-64.<br />
6 Kanavaros P, De Bruin PC, Briere J, et al. Epstein-Barr virus (EBV) in<br />
extranodal T-cell non-Hodgkin’s lymphomas (T-NHL). Identification<br />
of nasal T-NHL as a distinct clinicopathological entity associated with<br />
EBV. Leuk Lymphoma 1995;18:<strong>27</strong>-34.<br />
Processi linfoproliferativi del tratto gastroenterico<br />
S. Uccella<br />
Università dell’Insubria, Dipartimento di Scienze Cliniche e Morfologiche,<br />
Unità di Anatomia Patologica, Varese<br />
La localizzazione dei processi linfoproliferativi nel tratto<br />
gastrointestinale (TGI) è un evento frequente e, di converso,<br />
il tubo digerente costituisce la sede primitiva maggiormente<br />
interessata dall’insorgenza di linfomi extranodali. Tutte le categorie<br />
di linfomi che insorgono negli organi linfoidi primitivi<br />
possono essere ritrovate in sede gastrointestinale. Si tratta, in<br />
prevalenza, di linfomi non-Hodgkin a cellule B e, in analogia<br />
con quanto accade per i linfomi nodali, il linfoma diffuso a<br />
grandi cellule B (LDGCB) rappresenta l’istotipo più frequente.<br />
Tuttavia nel TGI si osservano anche due tipi di linfomi<br />
peculiari, la cui patogenesi appare strettamente correlata con<br />
eventi sede-specifici: il linfoma della zona marginale extranodale<br />
tipo MALT, che include anche la malattia immunoproliferativa<br />
del piccolo intestino (IPSID) e il linfoma a cellule<br />
T enteropatia-associato (EATL). Il TGI è, inoltre, una sede<br />
frequente di insorgenza delle malattie linfoproliferative posttrapianto.<br />
Nell’ambito del TGI, il linfomi insorgono con una<br />
maggiore frequenza nello stomaco (60%-75%), seguito dal<br />
piccolo (20%-30%) e, infine, dal grosso intestino (6%-12%).<br />
I linfomi del TGI possono costituire un problema diagnostico<br />
a causa della aspecificità della presentazione clinica e del tipo<br />
di materiale esaminabile al microscopio, spesso costituito<br />
da piccole biopsie con artefatti da prelievo. Con l’eccezione<br />
delle neoplasie a grandi cellule B o T, che non costituiscono<br />
una difficoltà per il patologo, i linfomi del TGI necessitano<br />
frequentemente di un approccio diagnostico integrato, con<br />
l’impiego di metodiche immunoistochimiche, citofluorimetriche,<br />
biomolecolari e di citogenetica, senza mai dimenticare un<br />
completo inquadramento clinico del paziente.<br />
Saranno qui discussi i caratteri distintivi e le principali problematiche<br />
diagnostiche relativi alle malattie linfoproliferative<br />
più frequentemente osservate nel TGI.<br />
Il linfoma della zona marginale extranodale tipo MALT (linfoma<br />
MALT gastrico e IPSID)<br />
La maggiore incidenza di linfomi MALT nello stomaco<br />
CONGRESSO aNNualE di aNatOmia patOlOGiCa SiapEC – iap • fiRENzE, 25-<strong>27</strong> OttOBRE <strong>2012</strong><br />
rispetto alle altre sedi del TGI è correlata all’infezione da<br />
parte di Helicobacter pylori, che sembra essere critica per<br />
la linfomagenesi e la cui eradicazione porta alla regressione<br />
della neoplasia in una elevata quota di casi in stadio iniziale.<br />
I criteri morfologici per la diagnosi del linfoma MALT gastrico<br />
sono ben definiti e risiedono nel riconoscimento di una<br />
popolazione neoplastica polimorfa costituita da cellule B della<br />
zona marginale, di dimensioni e aspetto variabile (elementi<br />
centrocito-simili, monocitoidi, plasmocitoidi, fino a vere e<br />
proprie plasmacellule, rari centroblasti). Le cellule neoplastiche<br />
tendono ad invadere la lamina propria e il compartimento<br />
epiteliale (formando le caratteristiche lesioni linfoepiteliali) e<br />
a colonizzare i follicoli linfoidi reattivi. La diagnosi differenziale<br />
con altri linfomi a basso grado si basa, quando necessario,<br />
sulla valutazione immunoistochimica.<br />
Le principali problematiche che emergono nella diagnostica<br />
istopatologica dei linfomi MALT gastrici sono la diagnosi<br />
differenziale con gli infiltrati linfoidi reattivi, la valutazione<br />
della componente a cellule grandi eventualmente presente e,<br />
infine, la gestione della malattia residua.<br />
La malattia immunoproliferativa del piccolo intestino (IPSID),<br />
anche conosciuta come malattia delle catene alfa, è un linfoma<br />
raro, MALT-associato, probabilmente correlato all’infezione<br />
da Campylobacter jejuni. Caratteristica di questo linfoma è la<br />
secrezione di immunoglobuline monotipiche e tronche, costituite<br />
solo da catene pesanti alfa, osservabili come paraproteina<br />
nel siero. Questa malattia colpisce prevalentemente i bambini<br />
e i giovani adulti in aree geografiche definite: il bacino<br />
mediterraneo, l’Africa, il Medio Oriente e l’Asia orientale. I<br />
sintomi clinici sono la diarrea e i dolori addominali associati<br />
a malassorbimento e protidodispersione. Dal punto di vista<br />
istopatologico questo linfoma può presentarsi con uno spettro<br />
morfologico che va da un linfoma a basso grado tipo MALT<br />
a un linfoma ad alto grado tipo LDGCB. In analogia con i<br />
linfomi MALT gastrici, gli stadi iniziali di questa malattia<br />
regrediscono in seguito alla terapia antimicrobica.<br />
Il linfoma a cellule T enteropatia-associato (EATL).<br />
La classificazione WHO riconosce due forme di EATL, tipo<br />
I e tipo II, quest’ultima detta anche variante monomorfa. Entrambe<br />
risultano associate alla malattia celiaca, benché il tipo<br />
II possa insorgere anche comeforma sporadica. Il quadro istologico<br />
è variabile, ma il più delle volte è dominato da cellule<br />
di grandi dimensioni con nuclei pleomorfi e talvolta multipli<br />
o anaplastici. La variante monomorfa (tipo II) è costituita da<br />
cellule di aspetto uniforme, poco più grandi di un linfocito,<br />
con nuclei lievemente irregolari, piccoli nucleoli e una rima di<br />
citoplasma chiaro. Le cellule neoplastiche mostrano frequentemente<br />
epiteliotropismo.<br />
La mucosa intestinale perineoplastica mostra segni di atrofia villare,<br />
iperplasia delle cripte, aumento delle cellule infiammatorie<br />
nella lamina propria e infiltrato linfocitario intraepiteliale. Nel<br />
tipo I queste alterazioni, riconducibili alla malattia celiaca, sono<br />
osservabili in tutti i tratti del piccolo intestino, con uno spettro<br />
di gravità, mentre nel tipo II esse possono essere circoscritte<br />
alla sede del linfoma. Nelle forme di EATL associate a malattia<br />
celiaca refrattaria, i linfociti intraepiteliali presenti nella mucosa<br />
non neoplastica hanno anomalie immunofenotipiche e citogenetiche,<br />
sono monoclonali e possono essere quindi interpretati<br />
come parte del clone neoplastico. D’altro canto, in soggetti con<br />
malattia celiaca refrattaria non affetti da EATL, è stato dimostrato<br />
che i linfociti T intraepiteliali mostrano un riarrangiamento<br />
monoclonale del TCR e che un identico riarrangiamento è presente<br />
nei linfomi insorti durante il follow up. Si ipotizza quindi<br />
l’esistenza di un EATL in situ o “criptico”, il che implica la<br />
necessità di seguire nel tempo i pazienti con malattia celiaca re-