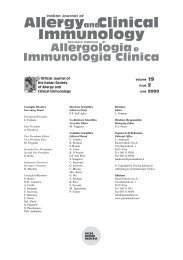Sabato 27 ottobre 2012 - Pacini Editore
Sabato 27 ottobre 2012 - Pacini Editore
Sabato 27 ottobre 2012 - Pacini Editore
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
242<br />
zienti asintomatici, la sede più frequente è la porzione laterale<br />
sinistra della parete aortica, tra 2 e 5 cm dall’origine delle arterie<br />
renali. La conseguente emorragia si può estendere nello<br />
spazio retroperitoneale e provocare uno shock ipovolemico, o<br />
risultare contenuta dai tessuti molli periaortici per un periodo<br />
di tempo non prevedibile.<br />
Le alterazioni e il rimaneggiamento della parete aortica<br />
nelle placche estese e complicate possono coinvolgere la<br />
tonaca media, determinando la c.d. ulcera penetrante dovuta<br />
all’estensione dell’ulcerazione di una placca per un breve<br />
tratto nella media con formazione di un cratere sulla superficie<br />
luminale, senza distensione della superficie esterna del vaso.<br />
La frequenza di tale lesione non è nota ma sembra essere poco<br />
comune. La sede preferenziale è l’aorta addominale.<br />
Nell’aorta, l’anatomia del vaso (in particolare il suo calibro)<br />
fa sì che abbiano in genere rilevanza i fenomeni di trombosi<br />
e di embolizzazione distale, ma non le stenosi. L’aorta ateromatosa<br />
può essere una fonte di emboli periferici o viscerali;<br />
le placche si possono ulcerare rilasciando (soprattutto<br />
i fibroateromi) il loro contenuto nel torrente circolatorio e<br />
provocare embolizzazione distale con la possibilità che gli<br />
organi distali vadano incontro ad atrofia, ischemia o infarto.<br />
Le conseguenze cliniche dipendono dalla presenza di vasi<br />
collaterali.<br />
Aortiti<br />
G. D’Amati<br />
Dipartimento di Scienze Radiologiche, Oncologiche ed Anatomo Patologiche,<br />
Sapienza, Università di Roma.<br />
Con il termine di aortite definiamo un’infiammazione della<br />
parete aortica che coinvolge invariabilmente la tonaca media.<br />
La flogosi è associata in maniera variabile ad altri reperti istopatologici,<br />
come la distruzione delle fibre elastiche, la necrosi<br />
e la fibrosi. L’interessamento della giunzione medio-intimale<br />
e dell’intima è frequente, mentre quello dell’avventizia è<br />
variabile. La classificazione più seguita delle aortiti, adottata<br />
anche da questo gruppo di esperti, si basa sulla suddivisione<br />
in forme infettive e non infettive ed offre il vantaggio di essere<br />
funzionale alla terapia di queste affezioni.<br />
Verranno trattati i principali quadri istologici delle aortiti, i<br />
contesti in cui il patologo si trova a fare diagnosi di queste<br />
affezioni, i problemi di diagnostica differenziale, gli accorgimenti<br />
tecnici per ottimizzare la diagnosi.<br />
zone grigie ed implicazioni future<br />
O. Leone<br />
Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Orsola-Malpighi, Anatomia<br />
ed Istologia Patologica, Bologna<br />
Le aortopatie sono numerose ed eterogenee ed alla loro genesi<br />
concorrono complessi sistemi cellulari e molecolari, che interagiscono<br />
nel determinare il danno parietale ed i conseguenti<br />
eventi clinici delle aortopatie acute (dissezione o rottura) e<br />
croniche (aneurismi/cronicizzazione di quadri acuti) e la loro<br />
progressione/estensione. L’aumento delle conoscenze sulla<br />
struttura e funzione della parete aortica e sulla sua fisiopatologia<br />
ed istopatologia sta delineando un più complesso<br />
approccio conoscitivo alla patologia dell’aorta, tale che l’osservatorio<br />
clinico non rappresenta più oggi l’unica prospettiva<br />
di valutazione.<br />
Le problematiche emergenti investono tematiche classificative,<br />
patogenetiche e diagnostiche, che rendono meno univoca<br />
CONGRESSO aNNualE di aNatOmia patOlOGiCa SiapEC – iap • fiRENzE, 25-<strong>27</strong> OttOBRE <strong>2012</strong><br />
l’interpretazione di quadri dapprima valutati in modo più<br />
grossolano e sbrigativo. Ci poniamo quindi più domande,<br />
alle quali possiamo per ora dare solo risposte parziali: da qui<br />
l’esistenza di zone grigie, che stiamo imparando a valorizzare<br />
come aree conoscitive in evoluzione, che potranno comportare<br />
importanti cambi di paradigma nell’approccio clinicoterapeutico<br />
alle aortopatie.<br />
L’osservatorio istopatologico<br />
La transizione intervenuta negli ultimi due decenni dallo<br />
studio anatomo-patologico preminentemente macroscopico<br />
ad un più approfondito studio istopatologico ha consentito<br />
di ampliare la realtà clinica della patologia aortica, creando<br />
un ponte con i complessi meccanismi biologici operanti nella<br />
parete vasale e le basi per un inquadramento nosografico più<br />
aderente ai reali meccanismi patogenetici in gioco.<br />
Due esempi paradigmatici:<br />
l’acquisizione che il capitolo delle aortopatie infiammatorie<br />
sia caratterizzato da un ampio spettro di quadri infiammatori,<br />
non più limitati solo alle classiche aortiti;<br />
la sempre maggiore consapevolezza che il capitolo delle aortopatie<br />
degenerative non infiammatorie accomuni, all’interno<br />
di un’unica etichetta, malattie molto eterogenee sia dal punto<br />
di vista eziologico che clinico.<br />
Le zone grigie<br />
Riconoscono differenti problematiche:<br />
l’esistenza di quadri overlapping (aterosclerosi infiammata,<br />
periaortite cronica, aneurisma infiammatorio, alcune forme di<br />
aortite) nel contesto di uno spettro eziopatogenetico, patologico<br />
e clinico-evolutivo variegato;<br />
la presenza di entità nosologiche non ancora ben definite dal<br />
punto di vista eziopatogenetico e patologico (es. periaortite<br />
cronica);<br />
l’effettiva possibilità che si realizzino quadri patologici misti,<br />
in cui coesistono aortopatie differenti (un’aortopatia con classiche<br />
lesioni degenerative può complicarsi con l’aterosclerosi<br />
o un’aortite);<br />
lo stesso processo evolutivo delle aortopatie, che può condizionare<br />
la comparsa di aspetti istopatologici differenti da<br />
quelli della malattia di base.<br />
Implicazioni future<br />
Alcuni spunti di riflessione su possibili futuri cambi di paradigma<br />
nell’approccio conoscitivo e clinico-terapeutico rispetto<br />
alle conoscenze classiche sulla patologia aortica, possono<br />
essere così riassunti:<br />
L’aorta come organo con ampio spettro di funzioni e non come<br />
semplice condotto passivo, le cui peculiari caratteristiche<br />
biologiche e le importanti funzioni emodinamiche consentono<br />
la regolazione dell’omeostasi parietale.<br />
Dalla globalità alla distrettualità. Le diverse caratteristiche<br />
embriologiche, strutturali, bioumorali e meccaniche dell’aorta<br />
toracica e addominale sono alla base della sostanziale eterogeneità<br />
dei vari segmenti, che determina corrispettivi funzionali<br />
e patologici differenti.<br />
Dall’aterosclerosi all’infiammazione. Il binomio aterosclerosi-infiammazione,<br />
ben noto in letteratura e documentato<br />
da alcune indubbie evidenze clinico-laboratoristiche, ha la<br />
sua massima evidenza nell’aorta e, come tale, può costituire<br />
un modello di lavoro per ottenere informazioni utili sotto il<br />
profilo della stratificazione prognostica e dell’individuazione<br />
di nuovi target terapeutici.<br />
Dall’intima all’avventizia: andata e ritorno. Per quanto l’intima<br />
abbia attirato per molti anni l’attenzione dei ricercatori<br />
e dei clinici, costituendo il bersaglio iniziale dell’insulto alla<br />
parete vascolare, si sta oggi rivalutando sempre più il ruolo<br />
dell’avventizia come sede finale dell’elaborazione della