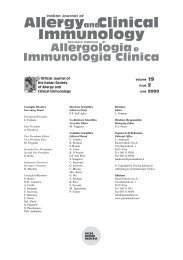Sabato 27 ottobre 2012 - Pacini Editore
Sabato 27 ottobre 2012 - Pacini Editore
Sabato 27 ottobre 2012 - Pacini Editore
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
260<br />
Anatomia Patologica scegliere quella più adatta alla propria<br />
organizzazione.<br />
Utilizzando il processo lavorativo dell’Istologia si possono<br />
identificare con facilità i punti critici più soggetti ad errore e<br />
adottare quindi i correttivi appropriati.<br />
Un punto di partenza molto importante è sicuramente il cosiddetto<br />
“order entry”, cioè una richiesta inviata per via informatica<br />
riportante i dati anagrafici del paziente, materiale, sede<br />
del prelievo, ecc. inviata via web direttamente dal reparto richiedente.<br />
In questo modo si eliminano gli errori in fase di accettazione<br />
dovuti a errori di trascrizione e/o di interpretazione.<br />
A questo punto si acquisiscono i dati e si producono sia il<br />
foglio di lavoro che le etichette da apporre ai contenitori riportanti<br />
il corrispondente n° istologico e il codice 2D, che verrà<br />
richiamato per tutte le fasi lavorative utilizzando una penna<br />
ottica. Sicuramente questo è un punto fondamentale per la<br />
sicurezza del paziente.<br />
Un altro punto importamte è l’utilizzo di stampigliatrici collegate<br />
con il sistema operativo sia per le bio-cassette che per i<br />
vetrini che riporteranno sempre il codice 2D.<br />
In seguito tutto il flusso di lavoro dall’accettazione, campionamento,<br />
processazione, inclusione, taglio, colorazione,<br />
consegna al Medico, ulteriori colorazioni e/o indagini speciali,<br />
viene monitorato e “tracciato” in modo che se si verifica<br />
un’errore, il sistema si blocca e andando a verificare l’incongruenza<br />
è possibile rilevare le non conformità e apportare<br />
subiti gli opportuni correttivi. Ogni operatore per tutte le fasi<br />
lavorative utilizzerà la propria password e in questo modo<br />
viene anche tracciato il “chi fa che cosa”.<br />
Anche tutte le altre strumentazioni utilizzate per colorazioni<br />
e/o indagini speciali possono essere interfacciate con il<br />
sistema operativo in uso, in modo da seguire tutto il flusso<br />
lavorativo.<br />
Una volta consegnato l’esame al Patologo, anche per la lettura<br />
del vetrino e la diagnosi viene utilizzato il codice 2D, in modo<br />
da evitare anche in questa fase errori di scambio tra i vetrini.<br />
In conclusione l’utilizzo dei codici 2D utilizzati nel sistema<br />
gestionale del Servizio, permette di avere tutta la tracciabilità<br />
completa dell’esame durante tutto l’iter lavorativo diminuendo<br />
sensibilmente il margine d’errore in favore della sicurezza<br />
del paziente.<br />
Identificando gli attori dei singoli processi si aumenta il grado<br />
di responsabilità permettendo di verificare la performance<br />
professionale e di ricorrere a correttivi qualora gli errori (mai<br />
azzerabili) si ripetano con una certa frequenza. Permettono<br />
infine un controllo dei carichi di lavoro in modo del tutto<br />
oggettivo identificando eventuali carenze lavorative che altrimenti<br />
sarebbero difficilmente identificabili.<br />
Sperimentazione tecnica e qualità del<br />
preparato istologico: percorso metodologico<br />
nel laboratorio di anatomia patologica<br />
M. Cadei, P.G. Grigolato<br />
Cattedra di Anatomia Patologica II, Università di Brescia<br />
Nel laboratorio di Anatomia Patologica l’allestimento<br />
dei campioni istologici è rimasto pressoché inalterato nel<br />
tempo e dalla fissazione alla processazione dei campioni<br />
istologici, la principale implementazione metodologica<br />
è stata legata alla innovazione strumentale (processatori,<br />
coloratori ecc.).<br />
Da qualche tempo, anche in conseguenza all’introduzione<br />
della legislazione sulla sicurezza è stata posta attenzione<br />
anche riguardo all’utilizzo di sostanze che, da sempre con-<br />
CONGRESSO aNNualE di aNatOmia patOlOGiCa SiapEC – iap • fiRENzE, 25-<strong>27</strong> OttOBRE <strong>2012</strong><br />
siderate indiscutibili (formalina, xilolo, alcool), hanno invece<br />
cominciato a trovare sul mercato validi concorrenti.<br />
Se indubbiamente questo merito è da riconoscere alle Aziende<br />
del settore che hanno fortemente sviluppato la ricerca di possibili<br />
prodotti non tossici in grado di competere con i reagenti<br />
tradizionali, c’è da dire che in molti laboratori si è assistito ad<br />
una maggiore apertura rispetto a prodotti non convenzionali.<br />
La nostra sperimentazione, iniziata qualche anno fa con<br />
l’utilizzo di “prodotti alternativi” della fissazione dei tessuti<br />
di origine murina, si è perfezionata nel tempo con la sperimentazione<br />
su tessuti umani di routine giunti presso il nostro<br />
Servizio per la diagnosi istopatologica. Oggetto del nostro<br />
studio sono stati la valutazione morfologica del preparato<br />
istologico, le tecniche istochimiche ed immunoistochimiche,<br />
l’analisi citofluorimetrica le indagini bio-molecolari, che ad<br />
oggi sempre più frequentemente vengono richieste ad integrazione<br />
della diagnostica.<br />
L’esperienza, finalizzata a dimostrare l’esistenza sul mercato<br />
di un prodotto adatto alle attuali esigenze normative, di buona<br />
qualità morfologica ed adeguato alle necessità metodologiche<br />
più evolute, dovrà essere completata con ulteriori miglioramenti<br />
tecnici e l’ottimizzazione per un possibile utilizzo<br />
routinario di laboratorio.<br />
Tecniche di diagnostica molecolare: attualità e<br />
nuove prospettive<br />
C. Lupo<br />
Casa di Cura di Alta Specialità La Maddalena, Palermo<br />
La diagnostica molecolare in Anatomia Patologica gioca un<br />
ruolo fondamentale nella gestione del paziente oncologico.<br />
L’impiego di tecniche molecolari, finalizzate alla detection di<br />
target specifici, a corredo della diagnosi anatomopatologica,<br />
permette la stratificazione dei pazienti in sottogruppi e di conseguenza<br />
la scelta della terapia più appropriata per ciascuno.<br />
Sappiamo che i test di diagnostica molecolare non possono<br />
prescindere da un corretto management del campione istologico<br />
e citologico finalizzato all’analisi molecolare. Le procedure<br />
interne di ciascun laboratorio identificano e definiscono il<br />
“workflow” del precorso tecnico-diagnostico. In quest’ottica<br />
è fondamentale individuare ed eliminare le variabili preanalitiche<br />
ed analitiche che possono condizionare pesantemente<br />
il dato molecolare. Un altro punto imprescindibile per questo<br />
tipo di diagnostica è il concetto di “idoneità” del materiale<br />
da analizzare. Poiché l’idoneità del campione da analizzare<br />
condiziona pesantemenmte il dato molecolare, in questa fase<br />
risulta essenziale la figura dell’anatomopatologo. Altrettanto<br />
importante è la competenza e l’esperienza dello staff dedicato.<br />
Grazie all’impiego di tecniche di diagnostica molecolare si<br />
eseguono test predittivi di risposta al farmaco. Nella terapia<br />
mirata dei tumori solidi ad esempio, troviamo test, che oramai<br />
fanno parte della diagnostica di routine, quali le analisi delle<br />
mutazioni del gene K-RAS nel carcinoma del colon-retto, del<br />
gene BRAF nel melanoma metastatico, del gene EGFR nel<br />
carcinoma non a piccole cellule del polmone (NSCLC). Per<br />
lo studio delle mutazioni dei geni sopra descritti è necessario<br />
estrarre il DNA genomico dal tessuto tumorale fissato in<br />
formalina ed incluso in paraffina o da campioni citologici. Il<br />
DNA estratto è poi analizzato attraverso diverse tecniche tra<br />
le quali, ad esempio, la PCR Real-Time, TaqMelt Real-time<br />
PCR, il sequenziamento diretto ed il pirosequenziamento.<br />
Di recente, nel carcinoma non a piccole cellule del polmone<br />
(NSCLC), si esegue lo studio del riarrangiamento del gene<br />
ALK. La valutazione di ALK si può effettuare mediante l’im-