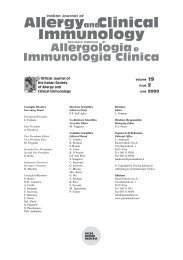Sabato 27 ottobre 2012 - Pacini Editore
Sabato 27 ottobre 2012 - Pacini Editore
Sabato 27 ottobre 2012 - Pacini Editore
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
258<br />
L’incidenza media complessiva di eventi avversi è stata determinata<br />
del 5,2%, quella mediana del 5,5%: è coerente con l’atteso<br />
nel protocollo di studio e si colloca a un livello in media più basso<br />
rispetto al tasso mediano degli studi internazionali (9,2%).<br />
La distribuzione di eventi avversi per specialità è risultata prevalente<br />
in area medica (37,5%); contrariamente ad altri studi,<br />
la chirurgia è in seconda posizione (30,1%), seguita da pronto<br />
soccorso (6,2%) e ostetricia (4,4%).<br />
CONGRESSO aNNualE di aNatOmia patOlOGiCa SiapEC – iap • fiRENzE, 25-<strong>27</strong> OttOBRE <strong>2012</strong><br />
Sala Brunelleschi – 11.30-12.30<br />
Riguardo alle conseguenze degli eventi avversi, essi possono<br />
essere di più tipologie: prevale il prolungamento della degenza<br />
come conseguenza più frequente, seguito dalla presenza<br />
di una disabilità al momento della dimissione, mentre il decesso<br />
del paziente ha un’occorrenza mediana del 9,5%. La<br />
concordanza tra revisori è risultata piuttosto elevata (in media<br />
superiore al 95%).<br />
Qualità e sicurezza nei servizi di anatomia patologica – Parte II<br />
Moderatori: Domenico Ientile (Palermo), Fabio Vecchio (Roma)<br />
L’errore di diagnosi e variabilità diagnostica in<br />
anatomia patologica<br />
A. Fabiano<br />
Ospedale S. Giovanni Calibita Fatebenefratelli, UOC Anatomia Patologica,<br />
Roma<br />
La diagnosi clinica di un patologia si basa sull’analisi dei<br />
segni clinici e sintomatici di un paziente e dal risultato di<br />
specifiche indagini strutturali. La diagnosi istopatologica è un<br />
documento medico di importanza notevole che deve descrivere<br />
in modo meticoloso e conciso tutte le rilevanti caratteristiche<br />
del caso e trasmetterle al clinico, deve essere formulata<br />
rapidamente, deve essere accurata, deve essere una sintesi<br />
interpretativa degli aspetti morfologici strutturali e delle caratteristiche<br />
istocitopatologiche che costituiscono la lesione. Nel<br />
referto il patologo deve evitare termini tecnici, istologici, che<br />
non hanno importanza clinica e concentrarsi su quegli aspetti<br />
relativi alla terapia e alla prognosi che possono essere utilizzati<br />
dal clinico per un miglior inquadramento terapeutico.<br />
Con la consegna di un prelievo un anatomia patologica si<br />
innesca una serie complessa di eventi che hanno come fine<br />
la diagnosi istopatologica. I processi che costituiscono tale<br />
percorso risultano potersi riassumere in processi pre-analitici,<br />
analitici e post-analitici. In tutte queste fasi di accettazione,<br />
allestimento, formulazione della diagnosi e consegna della<br />
diagnosi è possibile che si possano inserire degli eventi che<br />
determinano un errore. “L’errore consiste semplicemente nel<br />
fatto che non sembra essere tale “ (Cartesio) e in medicina<br />
“si parla di errore quando l’esito di un’azione (prestazione o<br />
procedimento più complesso) non ha raggiunto i risultati che<br />
ci si era prefissati” (Carta sicurezza 2001) o anche lo si può<br />
interpretare come “un evento inatteso correlato a processo<br />
assistenziale e che comporta un danno al paziente non intenzionale<br />
e indesiderabile” (Ministero della Salute 2006). Noi ci<br />
occuperemo esclusivamente dell’errore nella diagnostica istocitopatologica.<br />
Varie possono essere le cause di errore, si possono<br />
riassumere in errore di distrazione, errore di sufficienza,<br />
errore di arroganza, errore da ignoranza. Si definisce errore<br />
medico un’omissione di intervento o un intervento inappropriato<br />
a cui consegue un evento avverso per il paziente e<br />
clinicamente significativo. Evidentemente errore diagnostico<br />
l’aver interpretato un carcinoma invasivo della mammella G3,<br />
ad esempio, come fibroadenoma; è invece un errore di diversa<br />
rilevanza clinica se un lipoma è stato interpretato come lipoma<br />
atipico o liposarcoma ben differenziato, in questo caso si<br />
parlerà di variabilità diagnostica che appartiene ad un gruppo<br />
di diagnosi istopatologiche che non hanno una riproducibilità<br />
accertata e la cui variabilità diagnostica non determina risvolti<br />
clinici gravi per il paziente. Esempi di variabilità diagnostica<br />
sono praticamente riportabili in tutte le patologie e possono<br />
raggiungere in alcuni casi livelli di discordanza anche elevata.<br />
Tale variabilità diagnostica che è valutata come detto in<br />
maniera anche percentualmente significativa non determina<br />
variazioni cliniche rilevanti ed è legata alla capacità interpretativa<br />
del singolo patologo, alla sua sensibilità diagnostica,<br />
dato personale non riproducibile e non incontrovertibile. Al<br />
contrario della variabilità diagnostica la cui possibilità di verifica<br />
è stata accertata da diversi lavori, la percentuale di errore<br />
in anatomia patologica risulta praticamente mai accertata, gli<br />
unici lavori si riferiscono ad errori che hanno determinato<br />
verifiche medico-legali.<br />
In linea di massima l’errore in anatomia patologica risulta<br />
nettamente inferiore rispetto all’errore clinico e da valutazioni<br />
generali emerse in alcuni lavori recenti non dovrebbe superare<br />
0,5-1% di tutta la diagnostica anatomo-patologica. Ottimisticamente<br />
l’errore ha anche un valore pedagogico intrinseco che<br />
può riassumersi dallo “sbagliando si impara” legato al comune<br />
buon senso all’”accrescimento della conoscenza e specialmente<br />
della conoscenza scientifica consiste nell’imparare<br />
dagli errore che abbiamo commesso “ (K.Popper).<br />
Eliminare l’errore è praticamente impossibile, possiamo<br />
però limitarlo con controlli di qualità intra-laboratorio ed<br />
inter(extra) laboratorio. A nostro parere nel controllo di qualità<br />
intra-laboratorio occorre scegliere un metodo in cui ci sia<br />
una revisione che preveda una revisione di preparati istologici.<br />
Tra i metodi più seguiti sono: a)Revisione con doppia firma<br />
di tutti i casi positivi; b) Revisione con doppia firma di tutti<br />
i casi; c) Revisione del 10% random dei casi; d) Discussione<br />
collegiale dei casi difficili; e) Revisione con doppia firma dei<br />
casi sentinella, intendendosi casi che il collega ritiene degni di<br />
essere rivisitati e ridiscussi con un collega dello stesso reparto.<br />
Buona norma è: 1) non firmare una diagnosi se non è stata<br />
mai diagnosticata dal gruppo; 2) avere per alcuni settori diagnostici<br />
un gruppo di patologi di riferimento; 3) certificare la<br />
lista dei consulenti esterni; 4) valutare in modalità critica la<br />
diagnosi del consulente esterno.<br />
Una delle conclusioni a cui possiamo giungere su un argomento<br />
che sarà ed è fonte di enorme discussione è che dell’errore<br />
non dobbiamo impaurirci, dobbiamo soltanto capire ed<br />
apprendere che esiste. Occorre seguire procedure che tentino