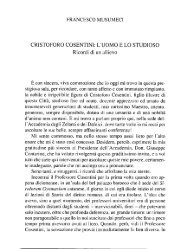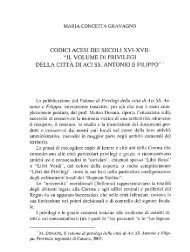Sono trascorsi cento anni dalla morte di Giuseppe Sciuti, avvenuta a ...
Sono trascorsi cento anni dalla morte di Giuseppe Sciuti, avvenuta a ...
Sono trascorsi cento anni dalla morte di Giuseppe Sciuti, avvenuta a ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
La produzione <strong>di</strong> <strong>Giuseppe</strong> <strong>Sciuti</strong> tra verismo e “grande maniera”<br />
cuzione e all’inventiva è del tutto contrastante con quelle che oggi appaiono opzioni storico-critiche in<strong>di</strong>scutibili; ma,<br />
appunto, una considerazione storica non può applicare le concezioni del presente a quanto viceversa appartiene al<br />
passato. In quella contestualizzazione culturale un pittore talvolta era inteso esplicare la propria sublime genialità in<br />
primo luogo in quanto essa appariva temprata dalle aspirazioni del popolo, <strong>di</strong> cui si faceva interprete e <strong>di</strong> cui la sua<br />
pittura era espressione (in quel duplice movimento, interpretativo ed espressivo, trovava le sue ragioni il ‘primato’<br />
della pittura <strong>di</strong> storia).<br />
Questa puntualizzazione (sia pure forse pleonastica) potrebbe essere precisata focalizzando i legami fra la pittura<br />
<strong>di</strong> storia ottocentesca e molti esiti del melodramma italiano: su una matrice ideologica e teorica sostanzialmente analoga<br />
si innestava spesso un comune intento illustrativo. Forse mai come in quella congiuntura culturale si manifestò<br />
così chiaramente l’affinità fra il ‘punto <strong>di</strong> vista’ teatrale e quello della pittura precedente all’Impressionismo. Risulta<br />
particolarmente rilevante in questo senso la ricerca <strong>di</strong> un gesto o <strong>di</strong> una sequenza <strong>di</strong> gesti tali da attirare lo sguardo<br />
dell’osservatore sintetizzando il senso della vicenda ‘messa in scena’. D’altra parte, in quadri <strong>di</strong> questo genere l’osservatore<br />
era già in partenza immaginato come appartenente a un pubblico: non si trattava <strong>di</strong> attivare in un singolo<br />
le implicazioni d’una contemplazione, quanto <strong>di</strong> proporre ad una collettività rimemorazioni e moti dell’animo con<strong>di</strong>visi.<br />
Nella fase <strong>di</strong> transizione in cui <strong>Sciuti</strong> si trovò ad operare quegli usi dell’arte erano già in procinto <strong>di</strong> migrare <strong>dalla</strong><br />
koinè figurativo/teatrale all’ambito cinematografico, là dove improvvisamente l’enfasi nazional-popolare risultava<br />
rinvigorita e talora sembrava giungere a vertici epici. Nel frattempo, la pittura andava trovando una ben <strong>di</strong>versa<br />
nozione <strong>di</strong> ‘verità’ artistica, maturata nello stratificarsi dei realismi e nelle variegate ricerche degli Impressionisti e<br />
dei Macchiaioli. Quella ‘verità’ presupponeva una pittura soggettivamente più autentica, intimistica e inquieta, ma<br />
soprattutto giocata essenzialmente sullo stile, sul linguaggio, e insomma sull’essere pittura, e non strumento per la<br />
raffigurazione d’una tesi o <strong>di</strong> postulati ideologici.<br />
Un paradosso della produzione <strong>di</strong> <strong>Sciuti</strong> è che in essa si trovano anche testimonianze <strong>di</strong> quest’altra vicenda pittorica.<br />
Per cui lo <strong>Sciuti</strong> ‘minore’, capace <strong>di</strong> tenerezze coloristiche e fremiti sentimentali nelle scene legate alla sfera degli<br />
affetti familiari, e nei ritratti, <strong>di</strong> recente ha potuto essere autorevolmente rivalutato e considerato ‘maggiore’.<br />
Tuttavia, in questo modo forse non gli si fa giustizia. <strong>Sciuti</strong> non si è ‘frainteso’. Viceversa, ha interpretato come<br />
meglio sapeva un’istanza decisiva <strong>di</strong> una stagione pittorica <strong>di</strong> transizione. E allora va detto che nei mo<strong>di</strong> concreti <strong>di</strong><br />
questa sua interpretazione è possibile trovare qualcosa <strong>di</strong> inatteso e <strong>di</strong> interessante. Nella macchinosità dei suoi gran<strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>pinti (del resto non <strong>di</strong>versa da quella caratterizzante i quadri <strong>di</strong> tema storico <strong>di</strong> artisti più noti) si coglie infatti una<br />
tensione peculiare fra un intento veristico e la ricerca d’una ‘grande maniera’. Quest’ultima implicherebbe idealizzazione,<br />
‘messa in posa’, enfasi retorica; ma <strong>Sciuti</strong> sembra attento anche al dettaglio, al dato ottico. L’ibridazione <strong>di</strong><br />
frammenti <strong>di</strong> visibile, <strong>di</strong> fantasticherie e <strong>di</strong> movenze irrazionali ma motivate <strong>dalla</strong> sintassi compositiva dell’immagine<br />
è un dato ricorrente nella prassi decorativa ottocentesca; e qui va probabilmente cercato il retaggio della lunga e<br />
alquanto accidentata formazione artistica del pittore (nato a Zafferana Etnea nel 1834), dopo gli inizi a contatto con<br />
alcuni protagonisti dell’ambiente etneo (i pittori <strong>Giuseppe</strong> Rapisar<strong>di</strong> e <strong>Giuseppe</strong> Gandolfo, lo scenografo <strong>Giuseppe</strong><br />
Di Stefano), e poi nei perio<strong>di</strong> a Firenze, dal 1862 al 1866, e a Napoli, dal 1867 al 1975 (in seguito si stabilisce a Roma,<br />
53