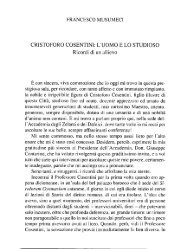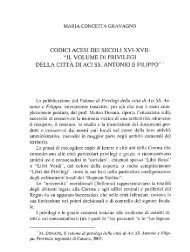Sono trascorsi cento anni dalla morte di Giuseppe Sciuti, avvenuta a ...
Sono trascorsi cento anni dalla morte di Giuseppe Sciuti, avvenuta a ...
Sono trascorsi cento anni dalla morte di Giuseppe Sciuti, avvenuta a ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
L’ultima battaglia <strong>di</strong> <strong>Giuseppe</strong> <strong>Sciuti</strong><br />
Gandolfo, dove si respirava un’altra aria. Gandolfo, che l’Accascina definisce “il migliore pittore dell’Otto<strong>cento</strong><br />
catanese”, era un artista raffinato; godeva <strong>di</strong> grande notorietà. Il suo punto <strong>di</strong> forza erano i ritratti. La sua clientela<br />
apparteneva all’alta burocrazia catanese, ricca e paludata, alla quale piaceva molto la sua pittura elegante, equilibrata.<br />
Il maestro gli spiegava tinte e colori, chiaroscuri, profon<strong>di</strong>tà e, soprattutto, <strong>di</strong>segno, materia che egli aveva insegnato<br />
ad Acireale presso l’Accademia degli Stu<strong>di</strong>. Nel bagaglio culturale <strong>di</strong> <strong>Sciuti</strong> il <strong>di</strong>segno non esisteva. Egli, infatti, <strong>di</strong>pingeva<br />
d’istinto. Fu un tirocinio prezioso, ma non ci volle molto per capire che il suo cammino era <strong>di</strong>verso da quello<br />
del Gandolfo, che imponeva ai propri allievi <strong>di</strong> copiare e ricopiare, con la maggior fedeltà possibile, i capolavori<br />
rinascimentali. Passarono dalle sue mani una, <strong>di</strong>eci, <strong>cento</strong> volte Raffaello, Correggio, Tiziano. <strong>Sciuti</strong> lo riteneva un<br />
esercizio inutile, che, tra l’altro, non aveva ritorni economici. Alle sue recriminazioni, il Gandolfo eccepiva che tutti i<br />
suoi allievi si erano sottoposti <strong>di</strong> buon grado a quella fondamentale prassi. E citava, da ultimo, Antonino Bonaccorsi,<br />
detto “il chiaro”, ormai noto pittore <strong>di</strong> Acireale, considerato un degno epigono <strong>di</strong> Pietro Paolo Vasta. A <strong>Giuseppe</strong> non<br />
interessavano né il Bonaccorsi, né Paolo Vasta: quel copiare da mane a sera non rientrava nella sua turbolenta personalità<br />
e, soprattutto, mal si conciliava col suo modo <strong>di</strong> intendere la pittura, concepita soprattutto come invenzione<br />
dello spirito.<br />
Spinto dall’assoluta necessità <strong>di</strong> “lavorare veramente” e <strong>di</strong> guadagnare, il giovane piantò baracca e burattini e si<br />
rifugiò nella città della madre, dove, tra i decoratori, si era già imposto <strong>Giuseppe</strong> Spina Capritti. Sarà questi a decorare<br />
la volta e i palchetti del teatro Bellini, l’abside e le vele della chiesa <strong>di</strong> S. Maria degli Ammalati, e alcuni saloni <strong>di</strong><br />
rappresentanza del Municipio <strong>di</strong> Acireale. Di tali opere restano soltanto le decorazioni della chiesa e, nella Biblioteca<br />
Zelantea, 19 cartoni del teatro, il resto è andato <strong>di</strong>strutto: il Bellini da un incen<strong>di</strong>o del 1952; le decorazioni del Municipio,<br />
da una ri<strong>di</strong>pintura voluta dal regime fascista.<br />
Spina intuì le potenzialità del suo giovane interlocutore e si rese conto anche delle sue impellenti esigenze economiche.<br />
Gli propose uno stipen<strong>di</strong>o <strong>di</strong> 4 lire, poco più <strong>di</strong> un rimborso spese, ma, al contempo, gli mise in mano spatola<br />
e pennello e gli insegnò a confrontarsi con gran<strong>di</strong> superfici, ad esercitarsi nel campo della prospettiva e dell’affresco,<br />
a educare l’occhio ad abbracciare l’insieme dell’opera senza sbavature. Lo stile del nuovo maestro, anche lui auto<strong>di</strong>datta,<br />
si rifaceva a reminiscenze tardo manieristiche, arricchite da fantasie floreali. Vi si coglieva l’intenzione <strong>di</strong><br />
conferire un uguale valore formale sia allo sfondo che al tema trattato. <strong>Sciuti</strong> si trovò perfettamente a proprio agio.<br />
Tracce significative <strong>di</strong> questo appren<strong>di</strong>stato si trovano in <strong>di</strong>versi palazzi borghesi <strong>di</strong> Giarre, dove il giovanotto affrescò,<br />
tra gli altri, cinque soffitti con Il trionfo <strong>di</strong> Galatea, condensando in pochi metri la Nereide, il pastorello Aci<br />
e il gigante Polifemo; una Figura <strong>di</strong> Donna assisa su armature, tra due angeli, e sei medaglioni intorno; uno stucco<br />
centrale con Natura morta e cinque medaglioni; una Scena marina con animali e paesaggi; cinque medaglioni, uno al<br />
centro con nudo <strong>di</strong> donna e quattro intorno con paesaggi. Il successo ottenuto lo spinse a prendere moglie e a <strong>di</strong>ventare<br />
padre <strong>di</strong> un bel bambino, Eugenio, che gli starà vicino nell’età matura. I sol<strong>di</strong> guadagnati non avevano mitigato<br />
la sua ambizione, anzi, l’avevano alimentata. Non si sentiva portato per questo genere <strong>di</strong> lavoro. La sua strada era<br />
altra. Che non tardò a venire.<br />
Dal 1862 al 1865, lo troviamo già a Firenze, che con Napoli e Roma, costituiva un punto <strong>di</strong> snodo e <strong>di</strong> confronto<br />
fra le <strong>di</strong>verse tendenze artistiche. Qui egli comincia a fare suo quel mondo <strong>di</strong> luce e <strong>di</strong> colori del quale <strong>di</strong>venterà<br />
7