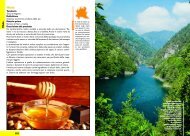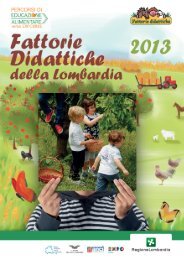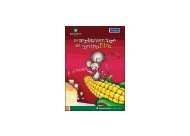Codice della Cucina Lombarda - BuonaLombardia.it - Regione ...
Codice della Cucina Lombarda - BuonaLombardia.it - Regione ...
Codice della Cucina Lombarda - BuonaLombardia.it - Regione ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
kebab, focaccerie e piadinerie…). Cultura commerciale, quella<br />
dei marchi e delle marche, è solo una faccia del sistema alimentare;<br />
sembra ergersi contro le mode, le varietà, le alterazioni, i plagi<br />
e le falsificazioni e proporre una visione retrospettiva e prospettica<br />
rassicurante. Raggiunge, lo sappiamo bene, solo in parte il proprio<br />
obiettivo. L’ident<strong>it</strong>à di un piatto non è diversa da quella di un uomo.<br />
Per accertarla, bisogna fare un passo indietro, osservarla a distanza<br />
storica, ragionando su una modernizzazione del sistema alimentare<br />
che ne è l’ossatura e il divenire. Come tutti i codici, anche quello<br />
<strong>della</strong> cucina lombarda è soggetto a revisione, con la differenza che,<br />
in questa materia, le leggi sono riscr<strong>it</strong>te e plasmate da chi le applica,<br />
casa per casa, trattoria per trattoria. Per quante variazioni si siano<br />
potute registrare in questi quattordici anni, per quanto Milano<br />
e la Lombardia abbiano mutato l’hab<strong>it</strong>us e il proprio modo<br />
di pianificare il futuro, esiste una idea di cucina e delle pratiche<br />
connesse che tengono duro e si ripropongono domandando<br />
una revisione cauta, delle correzioni prudenti.<br />
A DISTANZA STORICA<br />
La prima scelta, nel configurare la storia <strong>della</strong> cucina lombarda,<br />
è quella degli occhiali che dobbiamo inforcare per leggerla.<br />
Dobbiamo individuare un cuoco del XV secolo come Maestro<br />
Martino de Rossi (ticinese <strong>della</strong> valle di Blenio) e, identificando<br />
ingredienti e vivande del suo De re coquinaria, ricostruire<br />
INTRODUZIONE - 6<br />
con coloro che ne hanno raccolto l’ered<strong>it</strong>à, con testi di corte<br />
e di grandi case, sino a noi, le viciss<strong>it</strong>udini delle ricette lombarde?<br />
Oppure scegliamo le cucine milanesi del XIX secolo con le loro<br />
attestazioni stampate e i t<strong>it</strong>oli di piatti riconoscibili, e quelle più<br />
arretrate, più modeste <strong>della</strong> provincia, spesso identificabili con<br />
certezza solo nel XX secolo? O ancora consideriamo il codice<br />
<strong>della</strong> cucina lombarda come qualsiasi corpus di leggi valide oggi<br />
e vigenti? Queste tre vie sono tutte utili: la prima, ravvisando<br />
l’antico ceppo da cui si diramano le formule, mutevoli e controverse;<br />
la seconda, rest<strong>it</strong>uendoci quella memoria retrospettiva che ci permette<br />
di vedere in un passato prossimo, in una lingua a noi familiare,<br />
cibi e bevande d’uso; la terza, nel ricordarci che, di una cucina,<br />
importanti sono la sua attuazione, nelle case e nei locali pubblici,<br />
e gli es<strong>it</strong>i sia pratici che didattici.<br />
Un solo abbaglio va ev<strong>it</strong>ato: quello di r<strong>it</strong>enere il passato lontano più<br />
ver<strong>it</strong>iero, a scap<strong>it</strong>o di un passato prossimo inquinato dalla modern<strong>it</strong>à<br />
e dalle profonde trasformazioni nei campi più diversi quali le<br />
energie, le macchine o i consumi. Ciò premesso, gli occhiali migliori<br />
sono quelli per la media distanza. Le costoline di v<strong>it</strong>ello fr<strong>it</strong>te alla<br />
milanese sono presenti nella Gastronomia moderna del Sorbiatti<br />
(1855) con questa ricetta che è già la nostra:<br />
“Allest<strong>it</strong>e sottilmente sei costoline con garbo, immergetele nell’uovo<br />
sbattuto, indi imborragiatele di pane, fatele soffriggere a fuoco lento<br />
da una parte a color biondo, rivolgetele, salatele, e dopo due minuti<br />
serv<strong>it</strong>ele sul piatto asperse del loro burro, con del limone a parte.”<br />
Siamo in epoca anteriore all’un<strong>it</strong>à d’Italia, ma molte altre<br />
preparazioni, per esempio la polenta taragna o i pizzoccheri<br />
valtellinesi, tarderanno a entrare nei ricettari, molto dopo di essa,<br />
e saranno noti solo nella Guida gastronomica d’Italia del 1931.<br />
A legger le statistiche redatte da Carlo Cattaneo o da Visconti<br />
Venosta, la cucina in Valtellina, agli occhi di un ricco milanese,<br />
era una cosa miserrima, come l’economia valligiana e montanara<br />
sacrificata interamente all’esportazione dei formaggi verso<br />
il Milanese. In questa tipologia provinciale e marginale, ricadono<br />
molti piatti, e solo le codificazioni fasciste e repubblicane<br />
li valorizzeranno, portando a conoscenza, come consuetudinari,<br />
modi di cucinare borghesi festivi o contadini occasionali, di recente<br />
assunti come cardini <strong>della</strong> cultura di terr<strong>it</strong>orio. Una delle costanti<br />
<strong>della</strong> gastronomia dopo l’un<strong>it</strong>à d’Italia è, paradossalmente,<br />
la cresc<strong>it</strong>a dei patrimoni provinciali e locali, a scap<strong>it</strong>o dei piatti<br />
nazionali; le rival<strong>it</strong>à fra casoncelli o ravioli di zucca o mostarde<br />
sono campanilistiche solo all’origine, quindi animano gli assetti<br />
regionali ed oggi vengono proiettate in scenari europei<br />
e internazionali. La cresc<strong>it</strong>a <strong>della</strong> ricchezza, il moltiplicarsi delle<br />
attiv<strong>it</strong>à produttive, hanno portato nelle case lombarde e hanno<br />
ispirato alla ristorazione piatti come i pizzoccheri, già percep<strong>it</strong>i<br />
come indici <strong>della</strong> modestia e <strong>della</strong> auster<strong>it</strong>à delle case meno povere,<br />
quelle che riuscivano a festeggiare con farine miste, burro e formaggi<br />
da cottura. La seconda difficoltà di ordine storico sta nell’approccio<br />
al presente. Una volta identificati piatti con nomi dialettali e <strong>it</strong>aliani<br />
e le rispettive prime datazioni, quanto di questa cultura gastronomica<br />
sopravvive oggi e come? C<strong>it</strong>avamo il petto impanato di tacchino,<br />
ma potremmo riaprire la controversia del risotto alla milanese<br />
o dei casoncelli condivisi e rivali, da Bergamo a Brescia, e ricordare<br />
che i piatti di riso o di pasta fresca sono variabili costantemente<br />
rimesse in gioco nel tempo. Chi usa oggi il midollo di bue per<br />
il risotto alla milanese? E come si comportava alla fine del XX<br />
secolo quando le leggi lo avevano vietato? Ma nessuno oggi ricorda<br />
più i piatti impover<strong>it</strong>i o alterati dall’incubo <strong>della</strong> mucca pazza.<br />
Si dirà che a porsi troppe domande ci si rovina l’appet<strong>it</strong>o, eppure il<br />
mestiere di storico è quello di fare emergere le contraddizioni<br />
e trovare risposte ragionevoli solo se esse sono consent<strong>it</strong>e da carte e<br />
piatti. Gran parte del materiale qui raccolto ed esposto deve ricevere<br />
il beneficio di inventario di modal<strong>it</strong>à di consumo che tendono<br />
a rarefarlo o di proposte commerciali, turistiche e sciistiche nel caso<br />
dei pizzoccheri, che, al contrario, lo enfatizzano, con la conseguente<br />
delusione di non vederlo presente in ricettari di un secolo fa.<br />
La trattazione sarà dunque a vista lunga o corta secondo i casi,<br />
tenendo presente sia l’assenza di documenti che le falsificazioni<br />
documentarie. La cucina infatti, non è nata e cresciuta solo nei<br />
palazzi dei re e dei principi, come oggi non nasce e non cresce nei<br />
soli ristoranti a tre stelle, ed è molto più facile inventare le leggende<br />
che non raccontare il silenzio che circonda l’origine di un dolce.<br />
Quella di Alboino che, durante l’assedio di Pavia, venne “rabbon<strong>it</strong>o<br />
e distolto dai suoi propos<strong>it</strong>i di vendetta dal simbolico dono di un<br />
pan dolce” (ancora c<strong>it</strong>ata nella edizione del 1990 <strong>della</strong> Grande<br />
enciclopedia illustrata <strong>della</strong> gastronomia di Marco Guarnaschelli