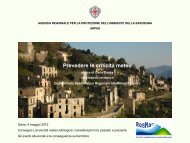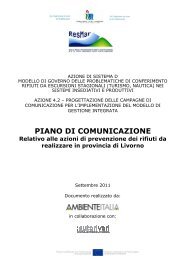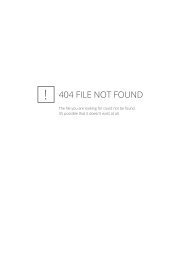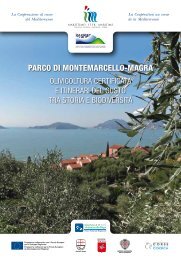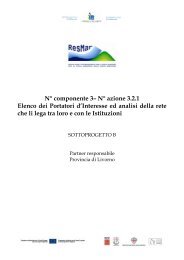Analisi ambientale iniziale del territorio di Porto Conte - RES - MAR
Analisi ambientale iniziale del territorio di Porto Conte - RES - MAR
Analisi ambientale iniziale del territorio di Porto Conte - RES - MAR
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
L’associazione Pistacio-Chamaeropetum humilis, <strong>di</strong>ffusa nel settore calcareo costiero <strong>del</strong> Parco, rappresenta<br />
la fase regressiva sia <strong>del</strong>le formazioni forestali a Juniperus turbinata sui calcari costieri, dove sono evidenti<br />
contatti seriali con il Centaureetum horridae, sia <strong>di</strong> quelle a Quercus ilex dei calcari interni e <strong>del</strong>le zone<br />
pianeggianti costiere, dove in seguito alla degradazione <strong>del</strong>la macchia alta a Pistacia lentiscus, specialmente<br />
in seguito al passaggio <strong>del</strong> fuoco, si sviluppa una variante pioniera a Cistus monspeliensis. Il ruolo<br />
colonizzatore <strong>di</strong> P. lentiscus è particolarmente evidente in tutto il settore costiero <strong>del</strong>la Sardegna nordoccidentale<br />
dove svolge un ruolo non trascurabile nell’evoluzione <strong>del</strong>le formazioni vegetali più mature. Per la<br />
piattaforma carsica <strong>di</strong> Cala <strong>del</strong>la Barca stu<strong>di</strong> sulla <strong>di</strong>stribuzione spaziale evidenziano come P. lentiscus e<br />
Chamaerops humilis tendano a scomparire nelle zone a maggior grado <strong>di</strong> copertura. Sulle arenarie quarzifere<br />
<strong>di</strong> Cala Viola e su superfici pianeggianti presso Nuraghe Palmavera nei pressi <strong>di</strong> Alghero, con suoli più<br />
profon<strong>di</strong> ed aci<strong>di</strong> <strong>del</strong>la terra rossa calcarea circostante, in <strong>di</strong>namiche <strong>di</strong> recupero post-incen<strong>di</strong>o, è presente una<br />
variante acidofila in<strong>di</strong>cata dalla subass. calicotometosum villosae, in contatto seriale con il Chamaeropo-<br />
Juniperetum turbinatae arbutetosum unedonis.<br />
La regressione <strong>del</strong>le formazioni forestali <strong>del</strong>la piana alluvionale <strong>del</strong>la Nurra, su suoli potenti, porta alla<br />
costituzione <strong>di</strong> una cenosi nanofanerofitica <strong>di</strong> sostituzione, mesofila, caratterizzata da specie <strong>del</strong>l’or<strong>di</strong>ne<br />
Pistacio-Rhamnetalia ma <strong>di</strong>fferenziata, rispetto a formazioni più xerofile, da alcune specie arbustive<br />
caducifoglie <strong>del</strong>la classe Rhamno-Prunetea: Pyrus amygdaliformis e Crataegus monogyna. L’associazione<br />
proposta nella piana <strong>del</strong>la Nurra si può rinvenire in contatto catenale con formazioni più igrofile che si<br />
sviluppano lungo i fossi e che sono state recentemente riferite all’associazione Crataego monogynae-Pyretum<br />
amygdaliformis, la cui struttura è dominata da specie <strong>del</strong>la classe Rhamno-Prunetea.<br />
L’associazione Erico arboreae-Arbutetum unedonis, molto <strong>di</strong>ffusa su suoli aci<strong>di</strong> <strong>del</strong> settore metamorfico <strong>del</strong>la<br />
Nurra settentrionale, nel Parco si rinviene nelle zone interne retrostanti al litorale da Cala Viola a <strong>Porto</strong> Ferro,<br />
nonché in alcuni tratti <strong>del</strong>le formazioni calcaree su terre rosse lisciviate e decarbonatate (Monte Doglia, Monte<br />
Timidone).<br />
Questa fitocenosi, che in alcuni casi raggiunge il litorale per compensazione edafica, nelle aree pianeggianti<br />
costiere <strong>di</strong> solito prende contatto seriale con formazioni <strong>di</strong> gariga riferibili all’associazione Rosmarino<br />
officinalis-Genistetum sardoae nella subass. cistetosum salvifolii.<br />
5 Vegetazione forestale<br />
La vegetazione forestale che si sviluppa nei settori interni <strong>del</strong> Parco è principalmente rappresentata da cenosi<br />
relitte a dominanza <strong>di</strong> Quercus ilex che si <strong>di</strong>versificano in rapporto alle caratteristiche <strong>del</strong> substrato e alle<br />
con<strong>di</strong>zioni mesoclimatiche dei luoghi. Molto importanti anche le comunità potenziali a sughera, olivastro e i<br />
boschi riparali.<br />
La vegetazione forestale a olivastro è attualmente presente in maniera frammentaria soprattutto sui versanti<br />
meri<strong>di</strong>onali dei complessi calcarei mesozoici, in particolare Monte Doglia e Monte Timidone. Tuttavia,<br />
nonostante la sua attuale rarità, essa costituisce la testa <strong>di</strong> una serie edafo-xerofila e termofila che sarebbe<br />
molto <strong>di</strong>ffusa nel Parco se non fossero intervenuti tagli e incen<strong>di</strong> nei decenni passati.<br />
L’associazione Prasio majoris- Quercetum ilicis, nei settori calcarei e arenacei costieri <strong>del</strong>la Nurra, si rinviene<br />
localizzata nella Penisola <strong>di</strong> Capo Caccia (Foresta demaniale Prigionette: canale <strong>di</strong> Barinaldo) e P.ta Giglio,<br />
nel complesso <strong>di</strong> M. Doglia e a <strong>Porto</strong> Ferro. In questi luoghi la vegetazione in stu<strong>di</strong>o appare confinata in<br />
impluvi e su versanti con suolo evoluto e leggero surplus idrico, in esposizioni settentrionali e comunque<br />
riparate dai venti salsi. Questa formazione, attualmente in netta ripresa, si presenta ricca in specie<br />
<strong>del</strong>l’alleanza Oleo-Ceratonion.<br />
Agricoltura e paesaggi agrari