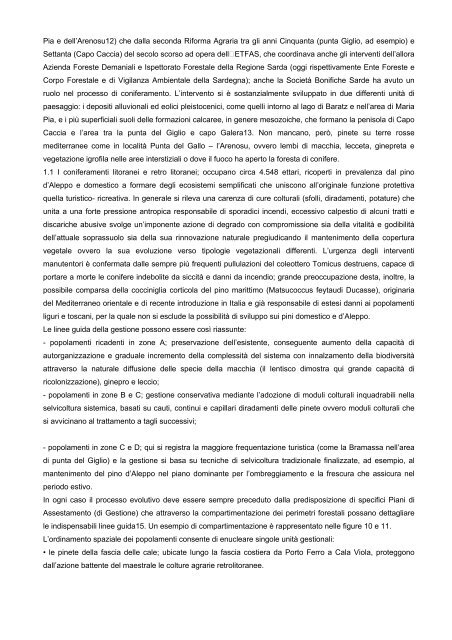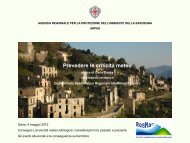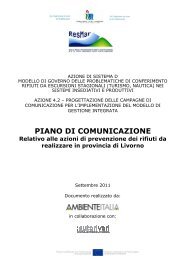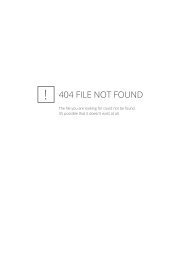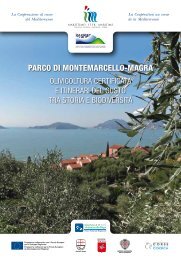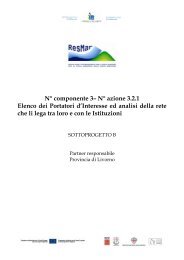Analisi ambientale iniziale del territorio di Porto Conte - RES - MAR
Analisi ambientale iniziale del territorio di Porto Conte - RES - MAR
Analisi ambientale iniziale del territorio di Porto Conte - RES - MAR
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Pia e <strong>del</strong>l’Arenosu12) che dalla seconda Riforma Agraria tra gli anni Cinquanta (punta Giglio, ad esempio) e<br />
Settanta (Capo Caccia) <strong>del</strong> secolo scorso ad opera <strong>del</strong>l ETFAS, che coor<strong>di</strong>nava anche gli interventi <strong>del</strong>l’allora<br />
Azienda Foreste Demaniali e Ispettorato Forestale <strong>del</strong>la Regione Sarda (oggi rispettivamente Ente Foreste e<br />
Corpo Forestale e <strong>di</strong> Vigilanza Ambientale <strong>del</strong>la Sardegna); anche la Società Bonifiche Sarde ha avuto un<br />
ruolo nel processo <strong>di</strong> coniferamento. L’intervento si è sostanzialmente sviluppato in due <strong>di</strong>fferenti unità <strong>di</strong><br />
paesaggio: i depositi alluvionali ed eolici pleistocenici, come quelli intorno al lago <strong>di</strong> Baratz e nell’area <strong>di</strong> Maria<br />
Pia, e i più superficiali suoli <strong>del</strong>le formazioni calcaree, in genere mesozoiche, che formano la penisola <strong>di</strong> Capo<br />
Caccia e l’area tra la punta <strong>del</strong> Giglio e capo Galera13. Non mancano, però, pinete su terre rosse<br />
me<strong>di</strong>terranee come in località Punta <strong>del</strong> Gallo – l’Arenosu, ovvero lembi <strong>di</strong> macchia, lecceta, ginepreta e<br />
vegetazione igrofila nelle aree interstiziali o dove il fuoco ha aperto la foresta <strong>di</strong> conifere.<br />
1.1 I coniferamenti litoranei e retro litoranei; occupano circa 4.548 ettari, ricoperti in prevalenza dal pino<br />
d’Aleppo e domestico a formare degli ecosistemi semplificati che uniscono all’originale funzione protettiva<br />
quella turistico- ricreativa. In generale si rileva una carenza <strong>di</strong> cure colturali (sfolli, <strong>di</strong>radamenti, potature) che<br />
unita a una forte pressione antropica responsabile <strong>di</strong> spora<strong>di</strong>ci incen<strong>di</strong>, eccessivo calpestio <strong>di</strong> alcuni tratti e<br />
<strong>di</strong>scariche abusive svolge un’imponente azione <strong>di</strong> degrado con compromissione sia <strong>del</strong>la vitalità e go<strong>di</strong>bilità<br />
<strong>del</strong>l’attuale soprassuolo sia <strong>del</strong>la sua rinnovazione naturale pregiu<strong>di</strong>cando il mantenimento <strong>del</strong>la copertura<br />
vegetale ovvero la sua evoluzione verso tipologie vegetazionali <strong>di</strong>fferenti. L’urgenza degli interventi<br />
manutentori è confermata dalle sempre più frequenti pullulazioni <strong>del</strong> coleottero Tomicus destruens, capace <strong>di</strong><br />
portare a morte le conifere indebolite da siccità e danni da incen<strong>di</strong>o; grande preoccupazione desta, inoltre, la<br />
possibile comparsa <strong>del</strong>la cocciniglia corticola <strong>del</strong> pino marittimo (Matsucoccus feytau<strong>di</strong> Ducasse), originaria<br />
<strong>del</strong> Me<strong>di</strong>terraneo orientale e <strong>di</strong> recente introduzione in Italia e già responsabile <strong>di</strong> estesi danni ai popolamenti<br />
liguri e toscani, per la quale non si esclude la possibilità <strong>di</strong> sviluppo sui pini domestico e d’Aleppo.<br />
Le linee guida <strong>del</strong>la gestione possono essere così riassunte:<br />
- popolamenti ricadenti in zone A; preservazione <strong>del</strong>l’esistente, conseguente aumento <strong>del</strong>la capacità <strong>di</strong><br />
autorganizzazione e graduale incremento <strong>del</strong>la complessità <strong>del</strong> sistema con innalzamento <strong>del</strong>la bio<strong>di</strong>versità<br />
attraverso la naturale <strong>di</strong>ffusione <strong>del</strong>le specie <strong>del</strong>la macchia (il lentisco <strong>di</strong>mostra qui grande capacità <strong>di</strong><br />
ricolonizzazione), ginepro e leccio;<br />
- popolamenti in zone B e C; gestione conservativa me<strong>di</strong>ante l’adozione <strong>di</strong> moduli colturali inquadrabili nella<br />
selvicoltura sistemica, basati su cauti, continui e capillari <strong>di</strong>radamenti <strong>del</strong>le pinete ovvero moduli colturali che<br />
si avvicinano al trattamento a tagli successivi;<br />
- popolamenti in zone C e D; qui si registra la maggiore frequentazione turistica (come la Bramassa nell’area<br />
<strong>di</strong> punta <strong>del</strong> Giglio) e la gestione si basa su tecniche <strong>di</strong> selvicoltura tra<strong>di</strong>zionale finalizzate, ad esempio, al<br />
mantenimento <strong>del</strong> pino d’Aleppo nel piano dominante per l’ombreggiamento e la frescura che assicura nel<br />
periodo estivo.<br />
In ogni caso il processo evolutivo deve essere sempre preceduto dalla pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> specifici Piani <strong>di</strong><br />
Assestamento (<strong>di</strong> Gestione) che attraverso la compartimentazione dei perimetri forestali possano dettagliare<br />
le in<strong>di</strong>spensabili linee guida15. Un esempio <strong>di</strong> compartimentazione è rappresentato nelle figure 10 e 11.<br />
L’or<strong>di</strong>namento spaziale dei popolamenti consente <strong>di</strong> enucleare singole unità gestionali:<br />
• le pinete <strong>del</strong>la fascia <strong>del</strong>le cale; ubicate lungo la fascia costiera da <strong>Porto</strong> Ferro a Cala Viola, proteggono<br />
dall’azione battente <strong>del</strong> maestrale le colture agrarie retrolitoranee.