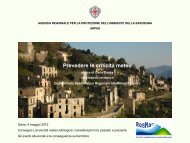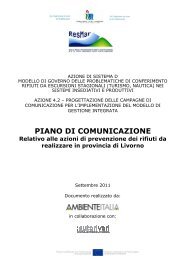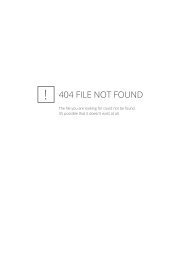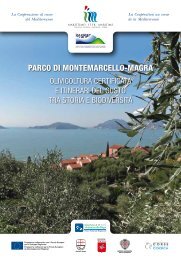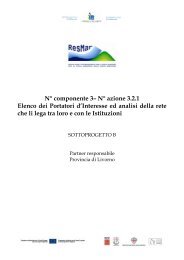Analisi ambientale iniziale del territorio di Porto Conte - RES - MAR
Analisi ambientale iniziale del territorio di Porto Conte - RES - MAR
Analisi ambientale iniziale del territorio di Porto Conte - RES - MAR
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
I livelli me<strong>di</strong>o-bassi <strong>del</strong>le depressioni salate, su suoli argillosi iperalini, umi<strong>di</strong> anche in estate sono occupati<br />
dall’associazione più <strong>di</strong>ffusa nel litorale <strong>del</strong>la Nurra, il Puccinellio festuciformis- Sarcocornietum fruticosae,<br />
dove si rinviene in stagni, depressioni retrodunali e vasche <strong>del</strong>le saline. L’associazione risulta spesso priva<br />
<strong>del</strong>la specie <strong>di</strong>fferenziale Puccinellia. festuciformis che si rinviene in una popolazione costituita da pochissimi<br />
in<strong>di</strong>vidui nella sponda destra idrografica <strong>del</strong> Calich.<br />
5. Vegetazione fluviale e stagnale <strong>del</strong>le acque dolci<br />
Sulle sponde dei corsi d’acqua immissari <strong>del</strong>lo Stagno <strong>di</strong> Calich e in una palude dulciacquicola retrostante il<br />
litorale <strong>di</strong> Mugoni, tra la villa omonima e la villa romana <strong>di</strong> Sant’Imbenia, si sviluppano comunità vegetali legate<br />
ad acque lente o ferme, dolci o debolmente salate, eutrofiche. Si tratta <strong>di</strong> formazioni <strong>di</strong> elofite, geofite ed<br />
emicriptofite (fragmiteti, tifeti, cariceti e scirpeti) che si sviluppano con apparato ipogeo totalmente sommerso<br />
per buona parte <strong>del</strong>l’anno. Sulle sponde dei corpi idrici si stabiliscono comunità forestali a pioppi, salici e olmi,<br />
talora tamerici, legate ai corsi d’acqua dolce.<br />
Attualmente tutte queste comunità vegetali sono notevolmente regre<strong>di</strong>te, talora <strong>del</strong> tutto scomparse, a causa<br />
<strong>del</strong>l’errata gestione <strong>del</strong>lo stagno, <strong>del</strong>le aree palustri e degli immissari fluviali. Infatti nello stagno sono<br />
totalmente scomparse le comunità d’acqua dolce, a vantaggio <strong>di</strong> quelle alofile e subalofile, mentre le sponde<br />
dei fiumi sono gestite come canali, limitando lo spazio per la vegetazione naturale. L’area più importante per<br />
queste comunità, è costituita da una palude dulciacquicola retrostante il litorale <strong>di</strong> Mugoni, tra la villa omonima<br />
e la villa romana <strong>di</strong> Sant’Imbenia, purtroppo sconosciuta ai più.<br />
Il Phragmitetum communis è l’unico tipo <strong>di</strong> vegetazione d’acqua dolce ormai rimasto nello stagno <strong>di</strong> Calich,<br />
presente anche in una palude dulciacquicola retrostante il litorale <strong>di</strong> Mugoni, tra la villa omonima e la villa<br />
romana <strong>di</strong> Sant’Imbenia. I tifeti risultano attualmente completamente scomparsi, mentre i fragmiteti sono molto<br />
ridotti <strong>di</strong> superficie rispetto al passato e alterati dalla presenza <strong>di</strong> Arundo donax, canna comune che tende a<br />
sostituire la cannuccia <strong>di</strong> palude, Phragmites australis.<br />
In una depressione retrostante il litorale <strong>di</strong> Mugoni, tra la villa omonima e la villa romana <strong>di</strong> Sant’Imbenia, è<br />
sopravvissuta una palude dulciacquicola <strong>di</strong> notevole valore <strong>ambientale</strong>. Si tratta <strong>di</strong> uno dei pochi esempi<br />
rimasti nella Sardegna settentrionale <strong>di</strong> palude ad acque dolci o solo debolmente salmastre, perennemente<br />
allagata, con una copertura vegetale densa, dominata da Carex otrubae e Calystegia saepium, alle quali si<br />
accompagnano Phragmites australis, Typha sp., Juncus sp. e <strong>di</strong>verse altre specie perenni <strong>del</strong>le palu<strong>di</strong> dolci. Il<br />
sito, <strong>di</strong> cui si allega la mappa è l’unica vera palude <strong>del</strong> Parco.<br />
VEGETAZIONE DUNALE<br />
1 – La vegetazione psammofila terofitica alo-nitrofila<br />
La vegetazione psammofila terofitica alo-nitrofila è costituita da comunità annuali che crescono sulla zona<br />
<strong>del</strong>la spiaggia inondata in inverno, sulla quale le mareggiate lasciano consistenti depositi <strong>di</strong> sostanza<br />
organica, soprattutto resti <strong>di</strong> Posidonia oceanica (L.) Delile.<br />
L’associazione Salsolo kali-Kakiletum maritimae è costituita da piante annuali effimere, propria <strong>del</strong>la prima<br />
parte <strong>del</strong>la spiaggia emersa; <strong>di</strong>ffusa su tutte le coste <strong>del</strong> Me<strong>di</strong>terraneo, sui litorali <strong>del</strong> Parco è presente in<br />
maniera spora<strong>di</strong>ca e frammentata nella spiaggia <strong>di</strong> <strong>Porto</strong> <strong>Conte</strong> e a Porticciolo, a causa <strong>del</strong>la pulizia<br />
meccanica dei litorali. Per lo stesso motivo risulta assente a Lazzaretto.<br />
2 - Vegetazione psammofila geofisica ed emicriptofitica<br />
Comunità perenni dominate da piante specializzate, ascrivibili alle medesime unità superiori <strong>di</strong> vegetazione<br />
(Euphorbio paraliae-Ammophiletea australis), ma occupanti ambienti ecologicamente <strong>di</strong>versi, influenzati da un<br />
gra<strong>di</strong>ente decrescente <strong>di</strong> salinità e uno crescente <strong>di</strong> evoluzione <strong>del</strong>la duna e lontananza dal mare, nonché