IL PROBLEMA DELLA LIBERTA' TRA ETICA E POLITICA - Filosofia
IL PROBLEMA DELLA LIBERTA' TRA ETICA E POLITICA - Filosofia
IL PROBLEMA DELLA LIBERTA' TRA ETICA E POLITICA - Filosofia
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
(come il bambino) apprende naturalmente ad adottare quelle condotte utili alla<br />
sopravvivenza, senza dover necessariamente ripetere l’esperienza dolorosa. Lo stesso si<br />
dica per le opposte esperienze piacevoli e gratificanti (associate ad esempio alla<br />
ingestione del cibo).<br />
A questo tipo di spiegazione meccanica, Martinetti non si limita ad opporre la<br />
generale accusa di “naturalismo”, in base ad argomenti di tipo generalmente metafisico: la<br />
irriducibilità dello spirito alla materia, della finalità alla causalità meccanica, ecc. (come<br />
avveniva in modo prevalente nei capitoli storico-filosofici). Egli adotta piuttosto una linea di<br />
confronto che muove dall’interno della tradizione scientifica contemporanea, e che ha in<br />
Wilhelm Wundt (1832-1920) l’esponente di spicco di una PSICOLOGIA SPERIMENTALE, che ha<br />
saputo tuttavia staccarsi dai presupposti impliciti di una metafisica empirica ingenua, come<br />
quella dell’associazionismo e del positivismo evoluzionistico. L’empirismo non si avvede di<br />
presupporre, senza volerlo, le funzioni stesse della coscienza, che pretenderebbe di<br />
ricavare in base al puro meccanismo associazionistico. Secondo il resoconto empirista di<br />
Bain, la coscienza scoprirebbe “che alcuni movimenti riflessi ed automatici sono utili a certi<br />
fini: e così poco per volta “ sarebbe indotta a “produrli volontariamente”, imparando con ciò<br />
a volere (L 313). Ma il concetto di “utilità” ha una evidente origine metafisica: come<br />
potrebbe, la volontà, giudicare come utili certi movimenti, certe reazioni organiche, se non<br />
fosse in grado di influenzarli e dirigerli fin dall’inizio? O si riconosce una teleologia alla<br />
base del movimento organico (non necessariamente una “volontà” nel senso di una<br />
capacità sviluppata e distinta da altre facoltà, ma un nisus, uno sforzo o un conato<br />
originario dell’organico e del vivente, in ciò diverso dall’inorganico), oppure non si potrà<br />
mai derivarlo come risultato casuale ed imprevisto del semplice movimento meccanico. Al<br />
contrario, gli stessi movimenti spontanei e riflessi dell’organismo sono spiegabili, come<br />
risultato di tendenze, volontà inferiori, consolidatesi nel tempo in altrettante “abitudini<br />
organiche scese sotto il livello della coscienza” (ibid.). Va dunque respinta ogni teoria<br />
“eterogenetica” della volontà, che non la riconosca, cioè “come un’attività originaria della<br />
coscienza” (teoria autogenetica). Tuttavia, anche la teoria “autogenetica”, che considera la<br />
volontà come forma evoluta di una attività elementare della stessa natura e qualità, non è<br />
esente da difetti, se cade nell’errore di ipostatizzare l’insieme degli atti volontari in una<br />
facoltà inesistente.<br />
La psicologia di Wundt ha spiegato l’origine dell’equivoco in cui cade la psicologia<br />
positivista, in conseguenza del privilegiamento della RAPPRESENTAZIONE come modello<br />
esclusivo del “fatto di coscienza”:<br />
La nostra concezione dei fatti interiori è falsata dalla interposizione di concetti e di analogie derivati dal<br />
mondo della rappresentazione esteriore. Noi costruiamo il mondo degli oggetti con le nostre<br />
rappresentazioni, facendo astrazione dai sentimenti e dal volere: e crediamo poi di poter fare la stessa cosa<br />
quando consideriamo le rappresentazioni come rappresentazioni. Così si trasformano le astrazioni dei<br />
diversi aspetti del fatto interno in diverse categorie di fatti: e si considerano le rappresentazioni come distinte<br />
dai sentimenti e dalle volizioni per quanto con essi in rapporto di azione reciproca. Tutte queste finzioni<br />
scompariscono quando ci accingiamo a rappresentarci il mondo interiore così com’è: allora rappresentazioni,<br />
sentimenti e volizioni ci appariscono come componenti o momenti omogenei di un unico divenire interiore; i<br />
quali non sono mai manifestazioni di una facoltà o di una forza, ma sono sempre soltanto rappresentazioni,<br />
sentimenti, volizioni singole, anzi fatti singoli, nei quali abbiamo ad un tempo un contenuto ossia un aspetto<br />
rappresentativo ed un’attività, ossia un aspetto sentimentale-volitivo (L 315).<br />
Gli atti volontari non sono isolabili dal complesso dell’attività della coscienza, la quale è<br />
inseparabilmente conoscenza, volontà e sentimento. Volontà e sentimento sono i due<br />
momenti (il secondo costituisce la semplice consapevolezza del primo) dell’aspetto attivo<br />
dei nostri atti psichici; l’altro aspetto è quello conoscitivo. La volontà “è una formazione<br />
23


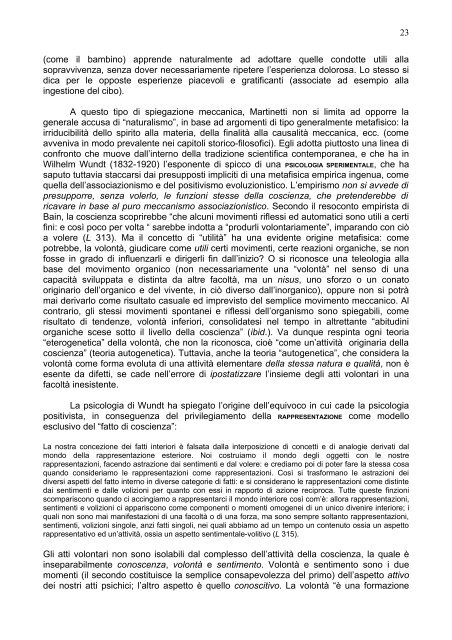












![La teoria dei condizionali [0.2in] di Stalnaker - Dipartimento di Filosofia](https://img.yumpu.com/43208857/1/190x135/la-teoria-dei-condizionali-02in-di-stalnaker-dipartimento-di-filosofia.jpg?quality=85)

