IL PROBLEMA DELLA LIBERTA' TRA ETICA E POLITICA - Filosofia
IL PROBLEMA DELLA LIBERTA' TRA ETICA E POLITICA - Filosofia
IL PROBLEMA DELLA LIBERTA' TRA ETICA E POLITICA - Filosofia
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
La necessità sua non è una necessità fissata nei suoi antecedenti, immobile, stagnante, ma una necessità<br />
che si rinnova incessantemente, si eleva e si rivela a se stessa sotto forme sempre più alte: ciò che diciamo<br />
il dover essere non è che la preparazione e la rivelazione, nello spirito, d’una più profonda necessità<br />
dell’essere (L 409-410).<br />
A sciogliere l’antinomia dell’esperienza e a salvare la testimonianza della coscienza a<br />
favore della libertà, dal rischio dell’annullamento soggettivistico, interviene qui la ragione<br />
con il suo insopprimibile “bisogno metafisico”. “E’ il mondo – Martinetti si interroga - in<br />
seno all’io o l’io in seno al mondo”? La realtà è “un pensiero, che porta in sé, come<br />
fondamento oscuro, la natura e che ha il compito di sublimarla in se stesso attraverso una<br />
serie infinita di negazioni”, oppure è “una forza cieca, che agita dalle necessità tenebrose<br />
del tempo la sua mole immensa e genera nel corso delle sue trasformazioni, come un fiore<br />
delicato ed effimero, lo spirito?” (L 410). Nell’ipotesi del determinismo naturalistico<br />
“l’imputabilità morale non avrebbe più senso”, con la caduta conseguente di ogni<br />
distinzione di valore. Ma questo tipo di determinismo ammette l’auto-confutazione sul<br />
piano logico: in esso tanto l’affermazione quanto la negazione della libertà risultano infatti<br />
ugualmente necessarie (L 412-413). L’autore lo aveva del resto già superato, sostituendo<br />
a una nozione di causalità passiva e meccanica, quella di una causalità sintetica e<br />
formale, in cui l’effetto è sì sempre legato indissolubilmente ai suoi antecedenti, ma “vi è<br />
legato dalla sua stessa necessità, non è il passivo portato della necessità degli<br />
antecedenti: la sua necessità è un dover essere proprio, qualche cosa di più e di<br />
imprevedibile”. Dunque è possibile mantenere il più rigoroso determinismo senza cadere<br />
negli assurdi del meccanicismo e del fatalismo: l’atto umano risulta “determinato e<br />
necessario, ma non metafisicamente predeterminato” (L 414-415).<br />
Vanno sottolineate le implicazioni etiche dell’idealismo metafisico martinettiano: l’io<br />
e la sua identità sono “il risultato dell’azione formale d’un principio metafisico: perciò la sua<br />
libertà è la sovrapposizione, alle necessità concorrenti, d’una necessità formale superiore”<br />
(L 415). Nell’atto moralmente libero (la cui fenomenologia è svolta da Martinetti alle pagg.<br />
415 e sgg.), la volontà è mossa sempre dallo stimolo sensibile, il quale agisce però come<br />
la rappresentazione di un’idea (esso ha, per così dire, un “nimbo” ideale). La generalità<br />
che accompagna lo stimolo è pur sempre un elemento del soggetto empirico, fa parte<br />
della sua “preparazione”, così che l’azione morale rientra nella concatenazione causale<br />
empirica (la legge morale pura non può infatti muovere direttamente – come pretende<br />
Kant – la volontà). Ma il risultato di questa azione empiricamente condizionata corrisponde<br />
a una norma universale assoluta: di qui il senso di “liberazione” che accompagna<br />
l’esercizio della vita morale. La norma morale assoluta opera come una idea regolativa,<br />
nella realizzazione empirica di norme sempre più universali. Il carattere empirico è “in<br />
progresso” verso il carattere intelligibile, esso non è - come pretendeva Schopenhauer -<br />
una semplice “traduzione che distenda nel tempo l’unità intelligibile”, ma “un’ascensione,<br />
una creazione orientata nel senso dell’unità sua intelligibile” (L 416). Ciò richiede una<br />
radicale trasformazione della nozione stessa del tempo. Il carattere intelligibile, infatti, è<br />
“l’unità immobile, che in sé riassume la totalità reale delle sue manifestazioni empiriche<br />
causalmente concatenate e che appunto perciò non può in alcun modo entrare in esse<br />
come fattore” (L 416). Come Dio (è evidente qui il richiamo a Plotino), esso è fuori dalla<br />
concatenazione temporale, non vi appartiene. La libertà è dunque possibile solo<br />
riconoscendo nell’io “un’unità formale metafisica, che è di tutto il processo psichico il<br />
termine ed il limite ideale e che ne compendia tutta la realtà, quale si svolge per esso nel<br />
tempo, nella sua eterna e immutabile unità” (ibid.). Ma come si traduce questa libertà del<br />
volere nell’agire? Come si conciliano necessità ideale e il determinismo fisico? Solo se la<br />
realtà fisica non è la realtà assoluta (quindi solo all’interno di una METAFISICA IDEALISTICA),<br />
essa può attuare, a livello fenomenico la libertà spirituale. Anziché pensare qui ad un<br />
66


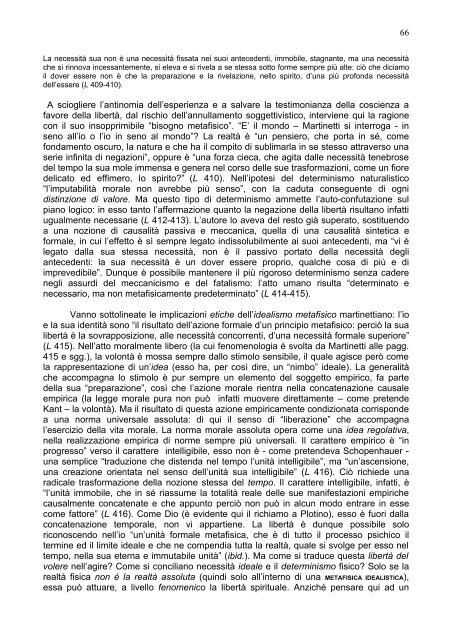












![La teoria dei condizionali [0.2in] di Stalnaker - Dipartimento di Filosofia](https://img.yumpu.com/43208857/1/190x135/la-teoria-dei-condizionali-02in-di-stalnaker-dipartimento-di-filosofia.jpg?quality=85)

