IL PROBLEMA DELLA LIBERTA' TRA ETICA E POLITICA - Filosofia
IL PROBLEMA DELLA LIBERTA' TRA ETICA E POLITICA - Filosofia
IL PROBLEMA DELLA LIBERTA' TRA ETICA E POLITICA - Filosofia
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
interessi e gli egoismi particolari si compongano spontaneamente in un felice equilibrio: ma questa è anche<br />
più spesso la via che per l’immoderato svolgersi degli egoismi conduce alla rovina. Ciò è visibile<br />
singolarmente nel campo economico con i risultati che dà nella pratica la superstizione degli economisti per il<br />
rispetto assoluto dei naturali conflitti economici (L 361).<br />
La libertà economica (e la connessa teoria della lotta di classe, sia nella variante liberista<br />
che in quella opposta marxista), benché rientri come materia nella sfera formale del diritto,<br />
non è accolta da Martinetti come termine di riferimento assoluto delle libertà civili. Essa<br />
può anzi essere limitata dallo stato (come si legge nel Breviario spirituale), quando ciò sia<br />
indispensabile per assicurare il rispetto della concreta personalità morale dei cittadini e la<br />
aspirazione di tutti e di ciascuno al bene comune: un concetto questo, di ascendenze<br />
aristotelico-tomistiche, che il “laicista” Martinetti (come gli è stato sovente rimproverato dai<br />
cattolici) mostra di non disprezzare affatto. Analogo realismo, nel rifiuto di ogni facile<br />
ottimismo “giusnaturalistico”, si osserva nel rifiuto di considerare le più determinate libertà<br />
civili: diritto di associazione e di riunione, libertà di stampa, ecc. come un mero diritto<br />
naturale dell’individuo, che ne oblia la concreta appartenenza a un più ampio insieme<br />
morale, politicamente qualificato: “la libertà di associazione e la libertà di stampa, che<br />
sono generalmente (ed a torto) considerate come inerenti all’individuo, sono in realtà<br />
elementi e problemi della libertà politica: perché il diritto di associazione e il diritto della<br />
stampa sono coefficienti essenziali della costituzione politica” (L 364-365).<br />
Una critica altrettanto netta è rivolta alle dottrine politiche ispirate a un principio<br />
collettivistico. L’errore del COLLETTIVISMO è di porre “lo stato prima dell’individuo come il tutto<br />
è prima della parte: la sua volontà generale obbiettiva esprime la più profonda realtà e<br />
perciò ne costituisce anche la reale libertà” (L 359-360). Sia nella versione liberale di<br />
Hegel, che in quella conservatrice e tradizionalista di Haller, un analogo vizio organicistico<br />
è sotteso a tali concezioni, che stentano a sottrarsi dalla tentazione di “divinizzare” lo stato<br />
(statolatria, come la definiva ad esempio Croce: con riferimento a quella particolare<br />
versione di destra dell’hegelismo napoletano, ripresa poi da Gentile e da lui usata come<br />
impropria legittimazione “liberale” del totalitarismo fascista). Ma Martinetti sembra<br />
estendere la sua critica alle opposte forme socialistiche (o meglio comunistiche) di<br />
collettivismo, che abbandonano l’originaria matrice liberale. In esse egli denunzia anzitutto<br />
l’economicismo:<br />
Non è senz’altro accettabile […] la teoria […] che […] la libertà consista nella perfetta subordinazione alla<br />
volontà generale incarnata nello stato. Sebbene lo stato rappresenti una ragione impersonale e collettiva,<br />
esso non è che la razionalità della vita inferiore, che sola è disciplinata dal diritto. Tutto ciò che costituisce<br />
propriamente la vita dello spirito trascende l’orizzonte e la capacità dello stato. Perciò voler porre come limite<br />
ed essenza ideale della libertà la immedesimazione con la volontà collettiva dello stato è un voler proporre<br />
all’umanità l’ideale sociale delle formiche o delle termiti, un trasformare lo stato in una collettività di servitori<br />
senza personalità e senza volontà. A che allora tutto questo meccanismo colossale, che non ha altro<br />
compito se non di difendere e di nutrire i suoi servi: i quali a loro volta non hanno altro fine che di piegarsi in<br />
tutte le loro attività allo stato e di sacrificarsi per esso? (L 362).<br />
Nella teoria politica dell’epoca non era ancora invalso il termine totalitarismo, per<br />
descrivere questa reciproca, in fondo assurda, finalizzazione dell’individuo allo stato e<br />
dello stato al soddisfacimento dei bisogni elementari della massa (termine in cui si<br />
dissolve ogni parvenza di singolarità personale): ma la cosa, potremmo dire, era ben<br />
presente a Martinetti. Anche senza assumere prese di distanza esplicite da comunismo e<br />
fascismo, era evidente quale ne fosse la implicita valutazione, in questa sua denunzia<br />
dell’errore teorico fondamentale del “collettivismo”. Del resto, qualche velato accenno alla<br />
contemporaneità politica, si poteva anche cogliere: ad esempio, nell’accenno alla<br />
“tirannide” politica, che “è sempre educazione di servi e di ribelli, non di uomini liberi,<br />
51


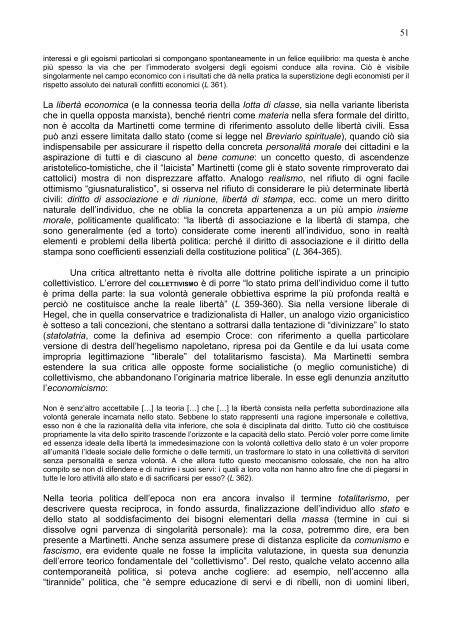












![La teoria dei condizionali [0.2in] di Stalnaker - Dipartimento di Filosofia](https://img.yumpu.com/43208857/1/190x135/la-teoria-dei-condizionali-02in-di-stalnaker-dipartimento-di-filosofia.jpg?quality=85)

