IL PROBLEMA DELLA LIBERTA' TRA ETICA E POLITICA - Filosofia
IL PROBLEMA DELLA LIBERTA' TRA ETICA E POLITICA - Filosofia
IL PROBLEMA DELLA LIBERTA' TRA ETICA E POLITICA - Filosofia
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
situazione, opereremmo necessariamente nello stesso modo” (L 385-386). Non si tratta di<br />
un gioco psicologistico (di sapore freudiano), ma di quello che Kant definiva a priori come<br />
il “carattere intelligibile”. L’unico modo di risolvere l’antinomia razionale tra determinismo<br />
degli atti e libertà trascendentale è infatti quello che suggerisce una “doppia lettura” delle<br />
nostre azioni. Esse appaiono, sul piano fenomenico del loro naturalistico accadere,<br />
sorrette da una rigida concatenazione di cause ed effetti, antecedenti e conseguenti. La<br />
loro spiegazione sufficiente è fornita dal nesso causale dei motivi con il carattere empirico<br />
dell’individuo. Questa medesima serie, senza con ciò perdere il proprio aspetto<br />
deterministico, può tuttavia essere riferita, sul piano del suo dover essere morale, ad un<br />
unico centro di spontaneità personale, ad un io, che ne assume intera la responsabilità.<br />
Non è sul piano naturalistico dell’accadere, ma in quello valutativo (e dunque<br />
antinaturalistico) della ragion pratica, che si risolve l’antinomia tra necessità<br />
(determinismo) e libertà. Affinché non siano frustrate le richieste universali della ragione<br />
(ma anche per non falsificare le risultanze fenomenologiche della coscienza morale,<br />
specialmente quando essa si apra al bisogno di assolutezza della coscienza religiosa), si<br />
deve poter riconoscere a un tale “io noumenico” (o “carattere intelligibile”, o “migliore<br />
persona”) un efficace potere di revoca sulle proprio decisioni:<br />
Il senso dell’imputabilità non costituisce affatto una prova che il colpevole avrebbe potuto agire<br />
diversamente; ma significa che la disposizione sua non fa parte di quell’ordine della ragione che noi<br />
riconosciamo come solo legittimo: e che, se quest’ordine fosse realizzato, e la disposizione e l’atto che ne<br />
procede non avrebbe avuto luogo. Il non dover essere implica il poter non essere; perché ciò che non fa<br />
parte dell’ordine razionale che solo deve essere (e veramente è) non solo non deve essere, ma realmente<br />
non è dal punto di vista assoluto. Il rammarico del non dover essere non è quindi solo un rammarico<br />
platonico; perché la realtà che ha dinanzi (la colpa) non è una realtà assoluta; per quanto empiricamente<br />
necessaria essa è, con tutta la concatenazione empirica, qualche cosa che dinanzi alla perfezione del<br />
mondo intelligibile non deve essere e, se questa fosse realizzata, assolutamente non sarebbe (L 386).<br />
Il tono di questa prosa martinettiana si fa decisamente metafisico (ed esso si andrà<br />
accentuando negli ultimi due capitoli (sul libero arbitrio e sul determinismo), che<br />
convergono infatti in un sobrio “epilogo metafisico” (cap. XVIII). Martinetti si interrogherà<br />
sulla necessità o meno di ammettere, accanto a questa libertas maior, che si identifica con<br />
la volontà del bene, la tradizionale libertas minor del libero arbitrio, in quanto volontà del<br />
bene o del male. Dopo l’esito negativo di questa inchiesta, che si risolve nella posizione di<br />
un puro determinismo razionale, a baluardo della coscienza morale, egli avvertirà<br />
l’esigenza di collocare sullo sfondo della aspirazione religiosa all’assoluto (di una religione<br />
che si mantenga per altro nei limiti della ragione, di una pudica fede razionale) l’intera<br />
indagine, che si è mossa anch’essa nell’ambito di uno stretto (benché non arido)<br />
razionalismo. E’ da notare come in questa pagina Martinetti traduca l’imperativo kantiano<br />
“devi, dunque puoi”, nella forma riflessiva, che ne mostra il risvolto metafisico: “il non<br />
dover essere implica il poter non essere”. Questo potere di revoca, che il soggetto morale<br />
riconosce in se stesso (ma che non proviene da lui, in quanto io psicologico e carattere<br />
empirico, bensì funge in lui, in quanto operare impersonale della ragione come carattere<br />
intelligibile), corrisponde al concetto di LIBERTÀ <strong>TRA</strong>SCENDENTALE. Per tale potere (rivolto<br />
sempre al futuro, mai al passato), diventa possibile quella conversione radicale della<br />
volontà empirica alla volontà buona (cui va riconosciuto un carattere “noumenico”,<br />
transfenomenico), che pur senza mutare il corso esterno degli eventi, ne modifica<br />
interiormente il senso (Sinn) e l’importanza (Bedeutung). Questo potere di nullificazione<br />
della coscienza (che Husserl – in altro contesto – estenderà a negazione del significato<br />
naturalistico del mondo e della realtà di fatto – Weltvernichtung – in vista della<br />
modificazione intenzionale del suo senso o della sua verità) deve essere tale, da far sì che<br />
ciò che è stato, pur senza divenire altro, sia riconosciuto, rispetto al suo reale potere di<br />
ulteriore motivazione sulla volontà, per quello che in realtà è, ossia come nulla. Il senso di<br />
60


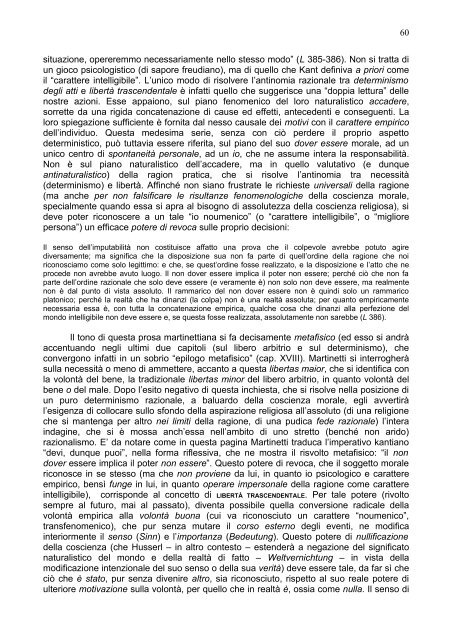












![La teoria dei condizionali [0.2in] di Stalnaker - Dipartimento di Filosofia](https://img.yumpu.com/43208857/1/190x135/la-teoria-dei-condizionali-02in-di-stalnaker-dipartimento-di-filosofia.jpg?quality=85)

