IL PROBLEMA DELLA LIBERTA' TRA ETICA E POLITICA - Filosofia
IL PROBLEMA DELLA LIBERTA' TRA ETICA E POLITICA - Filosofia
IL PROBLEMA DELLA LIBERTA' TRA ETICA E POLITICA - Filosofia
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Rinunciamo per il momento a seguire ulteriormente in dettaglio il discorso kantiano,<br />
che condurrà ad una conciliazione possibile di determinismo e libertà. Mi limito ad<br />
accennare a questa posizione conciliativa (o, come suol dirsi oggi, COMPATIB<strong>IL</strong>ISTA). La<br />
soluzione delle antinomie dinamiche della Critica della ragione pura (la terza, che abbiamo<br />
visto, e la quarta, che si riferisce all’esistenza o meno di un “ente assolutamente<br />
necessario” come causa del mondo), a differenza di quella delle antinomie matematiche<br />
(le prime due, che si riferiscono rispettivamente alla possibilità di un “inizio assoluto” del<br />
mondo nel tempo o della sua “eternità” e alla possibilità di concepire l’estensione della<br />
materia come “infinitamente divisibile” oppure composta di “parti semplici” indivisibili),<br />
conduce alla ammissione di due piani – fenomenico e noumenico – di esplicabilità<br />
metafisica del reale. Le antinomie matematiche trovano infatti una soluzione logica nella<br />
ammissione che la tesi e l’antitesi sono entrambe false (dunque, a falso, omnia<br />
sequuntur). Invece le antinomie dinamiche propongono due tesi entrambe vere, ma che si<br />
riferiscono l’una (quella che ammette il concetto di libertà trascendentale) al mondo<br />
noumenico delle cose in sé; l’altra (quella che esclude tale concetto) al mondo fenomenico<br />
delle apparenze. Kant lascia cioè uno spiraglio aperto al concetto di libertà trascendentale,<br />
che ha qui soltanto un carattere negativo, per riempirlo in seguito di contenuto positivo<br />
(con i concetti di “legge morale incondizionata” e di “carattere intelligibile” della<br />
Fondazione della metafisica dei costumi e della Critica della ragione pratica). Egli ritiene<br />
cioè fin d’ora compatibile l’affermazione della libertà morale con quella del determinismo<br />
fisico naturale, senza ricorrere alla tesi insostenibile dell’INDETERMINISMO fisico o della<br />
contingenza delle leggi di natura.<br />
3. Questa stessa è fondamentalmente l’opinione di Martinetti, nell’opera La libertà che ci<br />
accingiamo a studiare. Va però subito segnalata una differenza tra la posizione di<br />
Martinetti e quella classica di Kant (ammesso che si possa individuare una tale lettura<br />
“classica”, che è poi quella della vulgata neokantiana del secolo scorso). L’idea oggi più<br />
accreditata di ciò che “ha veramente detto” Kant risale infatti al neokantismo (a chi volesse<br />
farsi un’idea di tale centralità del paradigma neokantiano, per l’emergere delle alternative<br />
teoriche fondamentali del novecento, in seguito divaricatesi nella contrapposizione tra<br />
neopositivismo ed esistenzialismo o, come anche si dice, tra analitici e continentali,<br />
segnalo il recentissimo volume di Michael Friedman, La filosofia al bivio. Carnap,<br />
Cassirer, Heidegger, Cortina, Milano, 2004). Secondo tale idea, Kant non sarebbe affatto<br />
un pensatore della metafisica, ma della scienza, e il criticismo sarebbe nato in buona<br />
sostanza dal ripensamento filosofico del newtonianesimo e del paradigma logico della<br />
fisica matematica moderna (dal “fatto della scienza”: come esprime Hermann Cohen<br />
questa idea, del criticismo come IDEALISMO <strong>DELLA</strong> SCIENZA, ripresa e meglio divulgata<br />
nell’opera di Ernst Cassirer). Questa lettura sembra suggerire una discussione dei rapporti<br />
tra determinismo, indeterminismo, libertà, che faccia riferimento esclusivamente all’ambito<br />
della epistemologia. E’ ciò che in effetti è avvenuto negli ultimi decenni, specialmente in<br />
ambito culturale anglosassone: cfr. la ricostruzione di tale dibattito nel recente volume di<br />
Paola Dessì, Le metamorfosi del determinismo, Franco Angeli, Milano, 1997. E’<br />
significativo che l’autrice, pur riconoscendo l’importanza della tradizione storica del<br />
determinismo filosofico o metafisico, accanto a quella più strettamente epistemologica, e<br />
pur provenendo da una tradizione di studi torinese, in cui non è affatto oscuro il nome di<br />
Martinetti, non avverta mai l’opportunità di citare un testo classico per la discussione del<br />
problema del determinismo come La libertà. La ragione vera di una tale omissione (se non<br />
vogliamo restringerci al topos storiografico del “filosofo dimenticato”, ossia della casuale<br />
ignoranza), va ricercata nella singolarità della lettura di Kant condotta da Martinetti. Lo si<br />
può constatare dalla semplice lettura del capitolo a lui dedicato nella parte storica del<br />
volume in oggetto, ma lo si potrebbe meglio apprezzare, mediante lo studio delle sue<br />
7


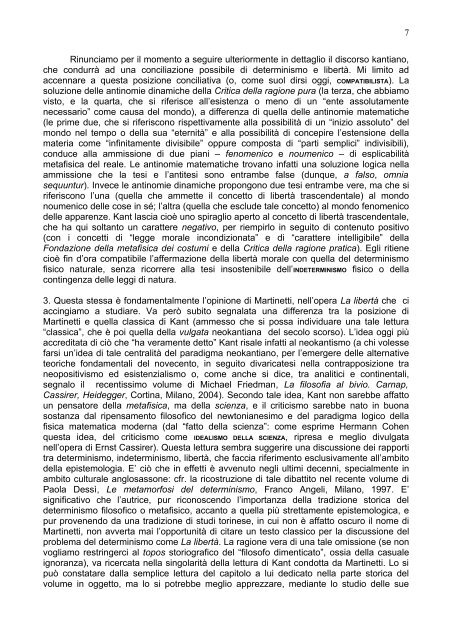












![La teoria dei condizionali [0.2in] di Stalnaker - Dipartimento di Filosofia](https://img.yumpu.com/43208857/1/190x135/la-teoria-dei-condizionali-02in-di-stalnaker-dipartimento-di-filosofia.jpg?quality=85)

