IL PROBLEMA DELLA LIBERTA' TRA ETICA E POLITICA - Filosofia
IL PROBLEMA DELLA LIBERTA' TRA ETICA E POLITICA - Filosofia
IL PROBLEMA DELLA LIBERTA' TRA ETICA E POLITICA - Filosofia
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
1. NECESSARIO O CONTINGENTE?<br />
Martinetti inizia la propria disamina della libertà dal problema del carattere contingente<br />
oppure necessario degli atti volontari (L II, 8). Chiariamo anzitutto il concetto di libertà che<br />
egli intende escludere o contestare: si tratta del concetto comune (fatto proprio dagli<br />
scolastici) della libertà come liberum arbitrium indifferentiae. Esso è chiarito bene da<br />
Schopenhauer (un avversario, come Martinetti, della libertà d’indifferenza) nei termini<br />
seguenti:<br />
Dall’assunzione di un simile liberum arbitrium indifferentiae deriva immediatamente la seguente affermazione<br />
[…]: cioè che un individuo umano, in circostanze esteriori del tutto individuali e completamente determinate,<br />
possa, in virtù di questa libertà d’indifferenza, agire in due modi diametralmente opposti (A. Schopenhauer,<br />
La libertà del volere umano, trad. it. Bruno Mondadori, Milano, 1998, p. 39).<br />
Schopenhauer fa notare come questa nozione forte di libertà derivi generalmente al senso<br />
comune da una confusione tra libertà di fare (libertas agendi) e libertà di volere (libertas<br />
volendi). Il sentimento, che giace al fondo della coscienza individuale, di “poter fare ciò<br />
che si vuole”, prevale su quello di una più recondita condizionatezza del nostro volere:<br />
Se interrogaste un uomo del tutto spregiudicato, ecco come si esprimerebbe riguardo a questa coscienza<br />
immediata, che si scambia così spesso per una presunta libertà della volontà: “Io posso fare ciò che voglio.<br />
Se voglio andare a sinistra, vado a sinistra; se voglio andare a destra, vado a destra. Questo dipende<br />
unicamente dalla mia volontà e dunque sono libero”. Una tale testimonianza è perfettamente vera e giusta:<br />
solo che presuppone la volontà e ammette implicitamente che la decisione sia già stata presa: la libertà della<br />
decisione stessa non può essere in alcun modo stabilita attraverso questa affermazione (ivi,p. 64).<br />
Per capire bene il problema, ci possiamo rifare all’analogia, cara ai deterministi, tra<br />
l’atto di scelta compiuto dalla volontà e la B<strong>IL</strong>ANCIA. Abbiamo visto come Herzen, ad<br />
esempio, sostenesse che il cervello pesa le impressioni ricevute dal mondo esterno e,<br />
sulla base di una previsione esatta e deterministica dei benefici o dei danni fisiologici<br />
conseguenti (piacere e dolore), reagisce imprimendo alla volontà una direzione<br />
determinata, cui segue immediatamente l’azione. Il processo mentale della deliberazione,<br />
che precede la scelta, e che viene solitamente caratterizzato come un “pensare”, è in<br />
realtà un “pesare” i pro e i contro dell’azione da compiere, che non concede alla volontà<br />
spazio alcuno di indecisione. Possiamo allora caratterizzare nei termini seguenti le due<br />
situazioni previste rispettivamente da chi afferma la necessità dell’atto volontario o la sua<br />
contingenza (nel significato forte di indifferenza):<br />
a) la volontà è sempre determinata dalla FORZA DEI MOTIVI, che sono i fattori causali dell’agire.<br />
Tra due motivi possibili ve ne è sempre uno più forte, che fa propendere la bilancia<br />
decisamente da un lato. La scelta si compie “a piatti fermi”: quando cioè si è concluso il<br />
processo deliberativo, e “si vede” da che parte stanno i motivi più forti e quelli più deboli.<br />
b) La volontà è sì condizionata dai motivi, ma è essa stessa a determinarne la forza, e ad<br />
imprimere alla scelta il suo carattere finale. Questa si compie – per così dire – “a piatti<br />
oscillanti”: è la volontà a risolversi in un senso o nell’altro, facendo propendere<br />
decisamente la bilancia da un lato (ma avrebbe potuto, con altrettanta decisione, farla<br />
propendere dall’altro lato).<br />
Potremmo chiamare riflessivo il primo tipo di comportamento e decisionista il secondo:<br />
osservando però come, dal punto di vista PSICOLOGICO, entrambe le descrizioni siano vere, e<br />
debbano perciò lasciare il posto ad una analisi puramente LOGICA. Osserva infatti<br />
Schopenhauer:<br />
9


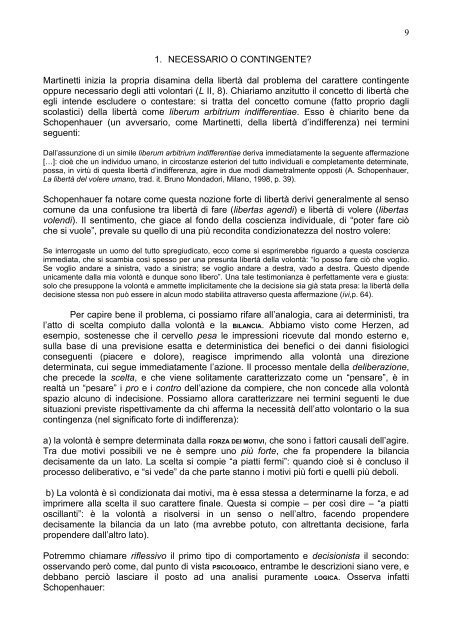












![La teoria dei condizionali [0.2in] di Stalnaker - Dipartimento di Filosofia](https://img.yumpu.com/43208857/1/190x135/la-teoria-dei-condizionali-02in-di-stalnaker-dipartimento-di-filosofia.jpg?quality=85)

