IL PROBLEMA DELLA LIBERTA' TRA ETICA E POLITICA - Filosofia
IL PROBLEMA DELLA LIBERTA' TRA ETICA E POLITICA - Filosofia
IL PROBLEMA DELLA LIBERTA' TRA ETICA E POLITICA - Filosofia
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
metafisiche di Cartesio),– questa, e non un’altra, è l’unica spiegazione scientifica possibile<br />
del comportamento animale.<br />
Anche dopo che la scienza ha abbandonato l’ipotesi insostenibile del<br />
meccanicismo, è rimasto il pregiudizio filosofico della totale assenza di libertà dal<br />
comportamento animale. Martin Heidegger, ad esempio, afferma che soltanto all’uomo il<br />
mondo è aperto come ambito di possibilità e di libertà, in conseguenza del suo modo<br />
specifico e unico di rapportarsi all’ente infra-mondano (quello del Dasein ossia della<br />
presenza consapevole-problematizzante al proprio essere nel mondo). L’animale e il suo<br />
comportamento restano invece rinchiusi all’interno dell’ambiente (Umwelt, anziché Welt), e<br />
sono determinati dall’istinto. Benché non sia affatto chiaro di che cosa si tratti<br />
esattamente, quando si parla di istinto (ad esempio se l’uomo, in quanto animale, ne sia<br />
fornito, ecc.), sembra assodato che il comportamento dell’animale non umano (Tier) sia<br />
sufficientemente spiegato in base a fattori innati e biologicamente previsti. L’animale – si<br />
dice – ha una risposta automatica agli stimoli che gli provengono dall’ambiente. Il suo non<br />
è un agire intenzionale (anche quando è assai simile a quello dell’uomo), ma guidato<br />
dall’istinto, che è una risposta a quelli che si definiscono i suoi “disibinitori specifici”. Ogni<br />
specie animale è perfettamente adattata al proprio ambiente (o “nicchia ecologica”), il<br />
quale contiene in sé gli elementi adeguati a soddisfare i suoi bisogni (nutrizione, crescita,<br />
riproduzione). L’animale è ricettivo soltanto a quegli stimoli, a quelle proprietà (colori,<br />
odori, resistenze) che i suoi organi di senso sono in grado di recepire (vista, olfatto, tatto),<br />
e che suscitano in lui una reazione immancabile. Anche se il paradigma meccanicistico è<br />
stato abbandonato dalle scienze, l’istinto animale continua ad essere immaginato (ad<br />
esempio mediante la teoria dei riflessi fisiologici) come una “molla compressa”, pronta a<br />
scattare, a rilasciare cioè la propria forza, in presenza dello stimolo. La fame (ad esempio)<br />
è “inibita” (l’animale può resistere per giorni o addirittura per mesi senza cibo), finché non<br />
incontra, sul proprio cammino, il “disibinitore” ad essa adeguato (la preda per l’animale<br />
carnivoro, certi vegetali per l’erbivoro, ecc.). La risposta allo stimolo è sempre una risposta<br />
biologicamente prevista, in cui domina perciò il più ferreo determinismo.<br />
Ora, Martinetti lascia aperto il problema della “libertà pratica” nell’animale non<br />
umano (anche se sembra citare con approvazione l’opinione di Aristotele, secondo il quale<br />
anche gli animali possiedono una phronesis, una forma di intelligenza diversa da quella<br />
dell’uomo, ma comunque sufficiente a garantire loro l’acquisizione di un “bene” specifico,<br />
della “vita buona” per ciascuna specie vivente). Gli preme piuttosto sottolineare come<br />
anche l’uomo (ad esempio il bambino piccolo) si comporti per lo più come l’animale,<br />
abbandonandosi “per così dire alla sua vita di essere naturale”, seguendo “finché qualche<br />
circostanza non lo arresta mettendo in azione l’intelligenza e la riflessione, il libero corso<br />
degli impulsi e degli istinti di natura” (L 325). L’animal rationale, cioè, rimane (per un lungo<br />
periodo della propria esistenza e per gran parte dei propri comportamenti “quotidiani”,<br />
finalizzati alla soddisfazione dei bisogni) animal: un essere bisognoso e fragile,<br />
potenzialmente riflessivo e razionale, ma che agisce anche in modo istintivo. Questa<br />
considerazione è generalmente utilizzata dai filosofi (ad esempio da Kant) per sottolineare<br />
l’insufficienza delle determinazioni naturali (sensibili) dell’uomo (homo phaenomenon), per<br />
giustificarne appieno la razionalità e la libertà (homo noumenon). Ora, non è che<br />
Martinetti non percorra anch’egli questa strada (lo farà soprattutto nei capitoli successivi,<br />
che trattano della differenza tra mera LIBERTÀ PRATICA e autentica LIBERTÀ MORALE). Ma in<br />
questo capitolo gli preme qualcosa di diverso. Se la libertà come spontaneità, di cui anche<br />
l’uomo (in quanto animale) dispone e fa uso è qualcosa di certamente deterministico,<br />
come mai accade che essa appaia alla autocoscienza umana nella forma positiva della<br />
libertà, anzi in quella più pura del sentimento vitale sfrenato, nella gioia? Se riusciremo a<br />
35


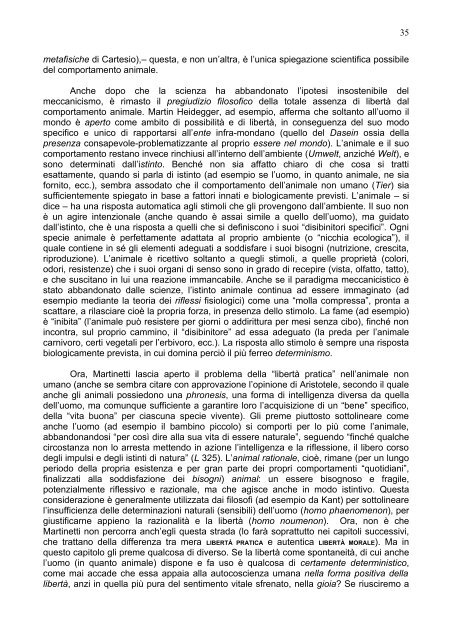












![La teoria dei condizionali [0.2in] di Stalnaker - Dipartimento di Filosofia](https://img.yumpu.com/43208857/1/190x135/la-teoria-dei-condizionali-02in-di-stalnaker-dipartimento-di-filosofia.jpg?quality=85)

