IL PROBLEMA DELLA LIBERTA' TRA ETICA E POLITICA - Filosofia
IL PROBLEMA DELLA LIBERTA' TRA ETICA E POLITICA - Filosofia
IL PROBLEMA DELLA LIBERTA' TRA ETICA E POLITICA - Filosofia
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
somma di denaro che mi è stata affidata da un creditore, affinché la custodisca e in<br />
seguito la restituisca, e che sono invece tentato di trattenere, nella eventualità che il<br />
creditore sia nel frattempo morto e che gli eredi legittimi siano all’oscuro di questa<br />
circostanza. Debbo o non debbo restituire il deposito? Se comprendi che cosa significa<br />
deposito (ossia una “somma di denaro che va restituita”) – risponde Kant – non puoi<br />
volere che la tua massima egoistica (in questo caso particolare mi conviene trattenerlo) sia<br />
adottata da tutti come legge universale, perché allora “il deposito non sarebbe più un<br />
deposito”! Ma – obietta Hegel – questo è appunto ciò che vuole in concreto chi si<br />
comporta immoralmente (ed è ciò che si verifica frequentemente a livello sociale), e non<br />
sarà mai il riconoscimento di una contraddizione logica a trattenerlo!<br />
Ora, Martinetti è risoluto nella difesa di Kant da tali fraintendimenti. Il suo concetto<br />
di forma non coincide infatti con l’astratto (ossia con una vuota generalizzazione, che non<br />
considera i casi concreti). L’astratto in sé, come puro formalismo logico, rappresenta una<br />
determinazione insufficiente della volontà. Il formalismo logico si attua in concreto<br />
mediante l’unione funzionale con l’elemento particolare della volizione: “l’azione dei motivi<br />
ideali si esercita come ogni altra azione di oggetti concettuali: per mezzo di<br />
rappresentazioni particolari. La ragione astratta, i principi universali non muovono per sé la<br />
volontà: un fine è sempre un fine concreto e particolare” (L 351). La LEGGE MORALE si limita a<br />
formulare una esigenza assoluta: quella “dell’unità di tutti i voleri in una volontà unica”<br />
(L 350). Esigenza che non si presenta mai in astratto, ma sempre congiunta con la<br />
“preparazione” spirituale che l’agire autenticamente morale concretamente richiede.<br />
Martinetti fa l’esempio dell’elemosina: “altro è soccorrere un indigente per impulso di pietà,<br />
altro è aiutarlo con quello spirito di carità superiore che in un dolore vede gli innumerevoli<br />
dolori di tutti coloro che soffrono” (L 351). Nel primo caso abbiamo un agire “patologico”<br />
(nel significato kantiano di impulsivo), nel secondo caso un agire “pratico” (qui nel senso<br />
specifico di morale). La libertà morale consiste in una disposizione costante della volontà,<br />
acquisita mediante l’esercizio concreto della moralità, per una stratificazione di atti<br />
giudicativi, sedimentati in una attitudine o modalità tipica del sentimento: quella<br />
“disposizione per cui l’uomo è in grado di opporre un animo sempre uguale a tutte le<br />
circostanze, per cui egli ha immedesimato se stesso con un ordine di principi immutabili,<br />
contro cui poco più possono le impressioni del momento” (ibid.). Ma se ciò è vero, sbaglia<br />
Kant nel contrapporre i moventi dell’agire, sulla base della loro origine sensibile<br />
(inclinazioni), oppure razionale-intellettiva (motivi). Chi fa del bene a un amico non compie<br />
un’azione morale, perché a ciò è indotto anche dal sentimento, mentre lo compie chi fa del<br />
bene a un nemico. Qui Kant rivela una rigidità morale, contro cui già Schiller all’epoca era<br />
insorto. Ma da che cosa dipende questo persistente dualismo di sensibile e intelligibile,<br />
che ipostatizza le due fonti concorrenti dell’agire umano in due facoltà astrattamente<br />
concepite (sensibilità e intelligenza)?<br />
Potremmo dire che è un residuo di platonismo, che Martinetti valuta in maniera<br />
duplice. Da un lato, si tratta per lui (che segue in questo punto l’esegesi kantiana di<br />
Friedrich Paulsen) di una eredità positiva. Il dualismo metafisico, benché razionalmente<br />
insostenibile e contraddittorio, riveste sempre un profondo significato religioso. E’ l’antico<br />
motivo (orfico-platonico-gnostico-cristiano) della distinzione assiologica assoluta di Dio e<br />
mondo, trascendenza e immanenza, infinito e finitezza, eternità e tempo. Martinetti rifugge<br />
(spinozianamente) dall’interpretare tale dualismo come contrasto assoluto di bene e male,<br />
peccato e salvazione, anche se c’è stato qualche interprete (Augusto Del Noce) che lo ha<br />
voluto intendere così, in una luce di pessimismo religioso. Ma nelle pagine de La libertà io<br />
leggo piuttosto una forma di ottimismo razionale, tinto di religiosità platonico-stoica. Con<br />
queste parole Martinetti rileva il significato religioso del kantismo:<br />
45


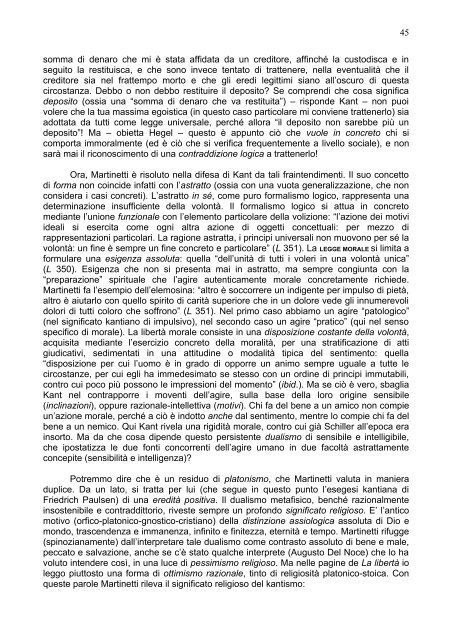












![La teoria dei condizionali [0.2in] di Stalnaker - Dipartimento di Filosofia](https://img.yumpu.com/43208857/1/190x135/la-teoria-dei-condizionali-02in-di-stalnaker-dipartimento-di-filosofia.jpg?quality=85)

