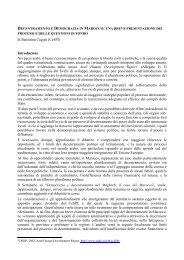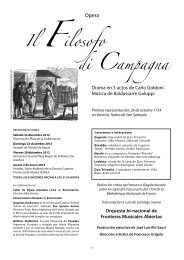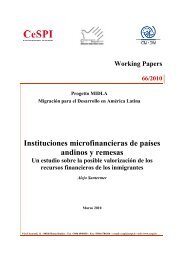Le diaspore africane tra due continenti Indagine sulle ... - CeSPI
Le diaspore africane tra due continenti Indagine sulle ... - CeSPI
Le diaspore africane tra due continenti Indagine sulle ... - CeSPI
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
del grande progetto post-coloniale. I loro paesi sono stati preda di colpi di stato, difficoltà di vita e<br />
crisi economiche, ritiro precipitoso dello Stato dagli investimenti pubblici, <strong>tra</strong>dimenti da parte dei<br />
politici al potere, che hanno seriamente minato le possibilità di un rientro positivo, garantito e<br />
valorizzante. Sono stati per cosi dire “dimenticati” all’estero. Dall’al<strong>tra</strong>, successivamente, hanno<br />
dovuto fare i conti con le difficoltà di integrazione in Italia, con una società poco preparata a<br />
considerarli una risorsa da apprezzare, con un paese poco attento all’inclusione e alla cultura delle<br />
differenze, politicamente inadeguato a gestire fenomeni come il razzismo, la discriminazione<br />
lavorativa e sociale, le richieste di partecipazione e di cittadinanza. Terminata quella breve stagione<br />
compresa <strong>tra</strong> il 1989 e il 1991, in cui ci fu la prima grandissima manifestazione antirazzista (ottobre<br />
1989) in reazione all’omicidio di Jerry Maslo, e la promulgazione della prima <strong>Le</strong>gge Organica in<br />
materia di immigrazione ad opera dell’allora ministro Claudio Martelli (1990), il clima generale nei<br />
confronti dell’immigrazione e dei migranti, prima decisamente positivo, a partire dalla seconda<br />
metà degli anni ’90 sembra lasciare progressivamente il posto ad una diversa percezione<br />
dell’immigrazione e ad atteggiamenti di chiusura, fastidio e criminalizzazione 51 . Cosicché, quella<br />
generazione di migranti si è trovata a doversi cercare in maniera solitaria e individualistica le<br />
proprie s<strong>tra</strong>de di inserzione, orfana del progetto politico/sociale e culturale che aveva animato la<br />
propria partenza e al contempo senza una adeguata offerta di partecipazione nella nuova società<br />
(Int. 13 RM; Int. 6 RM; FG RM1).<br />
Il rapporto con l’Africa e con il proprio paese di provenienza, da strettamente intrecciato alle<br />
vicende nazionali e continentali si è perciò rapidamente incanalato e rifugiato all’interno delle<br />
relazioni famigliari, passando dalla sfera pubblica e progettuale a quella privata e affettiva.<br />
Con la crisi del debito a metà degli anni ’80 si è creata l’impossibilità di rientro alla fine degli studi. Ci<br />
siamo dovuti inventare questo ruolo nella società europea e hanno pesato molto di più le logiche<br />
personali e soggettive che quelle collettive. Ciascuno di noi ha fatto i conti con la permanenza e si è<br />
inventato un modello soggettivo, contingente (…) Questa capacità di essere in grado di dare un<br />
contributo è stata inficiata all’origine dal fatto che non era quello il progetto e poi dalla dispersione<br />
causata della ricerca individuale della felicità. Non ci sono stati processi collettivi di presa di coscienza<br />
come diaspora, di doversi attivare per l’Africa. Alcuni, ma pochi, hanno cominciato a sviluppare questa<br />
coscienza ma per molti, ed è triste dirlo perché ci sono delle facce dietro a quello che dico, ha prevalso la<br />
logica della sopravvivenza (Int. 13 RM).<br />
Il disincanto e la delusione per come procedono le vicende <strong>africane</strong> non sembra comunque<br />
affievolire il legame con la propria provenienza e la propria matrice culturale e spirituale, che in<br />
alcuni casi continua a venir coltivata nell’ambito di raggruppamenti associativi di connazionali o<br />
più inclusivamente africani.<br />
Negli anni successivi alla <strong>Le</strong>gge Martelli, si verifica una prima significativa ondata di associazioni<br />
di migranti, incoraggiata dal sostegno all’associazionismo previsto dalla legge 52 , che vede spesso<br />
come protagonisti la generazione degli studenti africani primo-migranti: si creano sia associazioni<br />
di connazionali sia associazioni ‘pan<strong>africane</strong>’, come l’Associazione degli studenti africani in<br />
Umbria, la sezione africana degli studenti membri dell’UCSEI (Ufficio cen<strong>tra</strong>le studenti esteri in<br />
Italia) , oppure l’associazione di studenti africani dell’Università Cattolica di Milano, che si chiama<br />
significativamente ‘Presenza Studentesca Africana’ da ‘Présence Africaine’. <strong>Le</strong> attività di queste<br />
diverse associazioni sono ancora fondamentalmente rivolte alla società di destinazione, in quanto da<br />
una parte si avverte il bisogno di costruire solidarietà <strong>africane</strong> direzionate verso il reciproco<br />
sostegno in terra s<strong>tra</strong>niera, dall’al<strong>tra</strong> la situazione di sviluppo inceppato e di crisi politica e sociale<br />
51 Una efficace descrizione della deriva negativa subita dall’immagine dell’immigrazione della figura dell’immigrato<br />
avvenuta in Italia nel corso degli anni ’90 è presente in Dal Lago A. (1999), Non-persone. L’esclusione dei migranti in<br />
una società globale, Milano, Feltrinelli.<br />
52 Per una rassegna storica dell’associazionismo immigrato in Italia, si veda: Caponio, T. (2005), “Policy Networks and<br />
Immigrants’ Associations in Italy: The Cases of Milan, Bologna and Naples”, Journal of Ethnic and Migration Studies,<br />
vol. 31, n.5, September.<br />
29