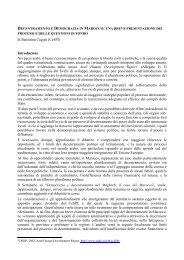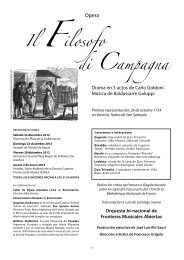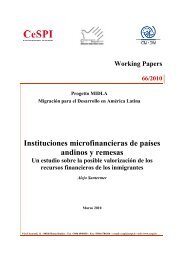Le diaspore africane tra due continenti Indagine sulle ... - CeSPI
Le diaspore africane tra due continenti Indagine sulle ... - CeSPI
Le diaspore africane tra due continenti Indagine sulle ... - CeSPI
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
1. PANORAMICA SUL CONCETTO DI “DIASPORA” E “DIASPORA PER LO SVILUPPO”<br />
1.1. Introduzione<br />
Per motivi diversi il termine diaspora ha oggi assunto una rivisitata connotazione, attorno alla quale<br />
sono emerse nuove ricerche e iniziative in ambito accademico, politico e della società civile.<br />
Diaspora descrive <strong>tra</strong>dizionalmente la migrazione di un popolo costretto ad abbandonare la terra<br />
d’origine disperdendosi nel mondo (tipicamente, il caso ebraico o armeno). La diaspora è quindi<br />
l’effetto del movimento forzato di un gruppo religioso e/o etnico che trova rifugio e sopravvivenza<br />
in una terra al<strong>tra</strong>, adattandosi, radicando la propria cultura o rimanendo minoritario.<br />
Il termine diaspora è oggi spesso sostituito a comunità immigrata 1 . Dove la letteratura odierna<br />
mutui questo termine 2 e ne re-inventi e aggiorni il concetto 3 , in esso sono compresi e descritti quei<br />
gruppi etnici <strong>tra</strong>nsnazionali e deterritorializzati che innescano, a distanza, forme e manifestazioni di<br />
appartenenza, produzione culturale ed attivazione economica, politica e sociale (Sheffer, 2003). In<br />
esso sono ricondotti significati quali dispersione geografica, (eventuali) progetti di ritorno,<br />
attivazione e mobilitazione in chiave <strong>tra</strong>nsnazionale, costruzione e rafforzamento dell’identità<br />
etnica – in chiave individuale o associativa-comunitaria 4 .<br />
All’interno del fenomeno del <strong>tra</strong>nsnazionalismo e della globalizzazione (Van Hear, 1998; Sheffer,<br />
1986; Shuval, 2003 e Gilroy, 1994), per diaspora si intende quindi un attore − collettivo − inserito<br />
in contesti e spazi <strong>tra</strong>nsnazionali 5 . In tal modo, un gruppo immigrato può essere considerato<br />
* Capitolo a cura di Anna Ferro.<br />
1<br />
Oltre a Sheffer (2003), si veda a tal proposito Reis (2004) che propone l’evoluzione storica e l’applicazione del<br />
concetto di diaspora a partire dall’esperienza ebraica o Cohen (1997) che spiega la relazione <strong>tra</strong> migranti e paesi<br />
d’origine at<strong>tra</strong>verso una rilettura del concetto (che differenzia in cinque tipologie storiche: diaspora di vittime/esiliati, di<br />
lavoratori, di espatriati delle colonie, commerciale e culturale). Per mettere in luce le ambiguità del termine – spesso in<br />
binomio con “ibrido, creolizzato, meticciato” oppure con “movimenti post-coloniali, nazionalisti, migratori,<br />
<strong>tra</strong>nsnazionali” – si veda il capitolo introduttivo di Braziel e Mannur in Theorizing diasporas (2003).<br />
2<br />
Non è un caso se dal 1991 esiste la rivista Diaspora. A journal of Transnational Studies e di recente inaugurazione sia<br />
African Diasporas.<br />
3<br />
Durante gli anni 1990 molti hanno proposto tipizzazioni e categorizzazioni del concetto di diaspora. Sheffer (1993)<br />
distingue <strong>tra</strong> stateless diasporas (i.e. palestinese), senza uno stato d’origine, e state-based diaspora. In risposta a tale<br />
tipologia territoriale, Cohen (1997) ne propone una distinzione che include labour diasporas (i.e. indiana); imperial<br />
diasporas (i.e. britannica); <strong>tra</strong>de diasporas (i.e. cinese, libanese); cultural diasporas (ie. caraibica). Safran ne parla<br />
come “expatriate minority communities: that are dispersed from a original “center” to at least two “peripheral” places;<br />
that maintain a “memory,” vision or myth about their original homeland; that “believe they are not – and perhaps cannot<br />
be – fully accepted by their host country; that see the ances<strong>tra</strong>l home as a place of eventual return when the time is right;<br />
that are committed to the maintenance or restoration of this homeland, and of which the group’s consciousness and<br />
solidarity are “importantly defined” by this continuing relationships with the homeland” (in Anteby-Yemini e<br />
Berthomière, 2005: 264). Medam (1993) ha proposto una tipologia basata sul grado di coesione e dinamismo delle<br />
organizzazioni diasporiche (distinguendo <strong>tra</strong> crystallised diasporas e fluid diasporas). Bruneau (1995), distingue le<br />
<strong>diaspore</strong> <strong>tra</strong> imprenditoriali (ie. Cinese o Libanese), religiose (ie. ebree) e politiche (ie. Palestinesi, Tibetane).<br />
4<br />
“Modern diasporas are ethnic minority groups of migrant origins residing and acting in host countries but<br />
maintaining strong sentimental and material links with their countries of origin—their homelands” (Sheffer, 1986: 3).<br />
5<br />
Rispetto all’interesse e protagonismo che viene oggi riconosciuto alle <strong>diaspore</strong> come elementi di congiunzione <strong>tra</strong><br />
luoghi e mondi di appartenenza, è emersa l’esigenza di ricondurre la natura delle comunità <strong>tra</strong>nsnazionali entro uno<br />
schema teorico radicato nei <strong>tra</strong>tti dell’economia globale e dei diversi confini nazionali-territoriali. Di fronte alle diverse<br />
declinazioni del ruolo della diaspora – quindi il <strong>tra</strong>nsnazionalismo politico, i processi di pace, lo sviluppo socioeconomico,<br />
il flusso di capitali finanziari, culturali, umani etc. – Appadurai (2003) propone una lettura immaginifica di<br />
come i differenti movimenti di persone e capitali modifichino la natura dell’economia culturale globale (entro cui<br />
rien<strong>tra</strong>no aspetti politici, economici, finanziari, culturali, sociali etc.). Cinque sono le dimensioni da lui indicate<br />
at<strong>tra</strong>verso cui leggere le comunità diasporiche, le relazioni e i comportamenti <strong>tra</strong>nsnazionali: ethnscape (persone,<br />
migranti, rifugiati), mediascape (nuovi media e strumenti elettronici), technoscape (nuove tecnologie), financescape<br />
(flussi di capitali globali, mercati finanziari, investimenti), ideoscape (ideologie, movimenti e contenuti culturali).<br />
3