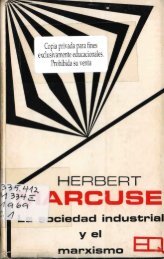La società unidimensionale e il suo superamento - Marcuse.org
La società unidimensionale e il suo superamento - Marcuse.org
La società unidimensionale e il suo superamento - Marcuse.org
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Neri, <strong>La</strong> <strong>società</strong> <strong>unidimensionale</strong> e <strong>il</strong> <strong>suo</strong> <strong>superamento</strong> (2008) 6<br />
essere-nel-lavoro. Permanenza significa che dal lavoro deve essere tratto qualcosa che sia più<br />
duraturo del singolo atto lavorativo, cioè qualcosa che sia in sé perdurante e che continui a<br />
sussistere anche dopo la conclusione dell’atto lavorativo. L’onerosità del lavoro è però<br />
l’aspetto più importante: “[ … ] Già <strong>il</strong> lavoro in quanto tale si presenta come “peso”, poiché<br />
sottomette <strong>il</strong> fare umano ad una legge estranea, che a questo viene imposta: alla legge della<br />
“cosa” che bisogna fare ( e che rimane una “cosa”, qualcosa che è altro dalla vita, anche se è<br />
l’uomo stesso a darsi <strong>il</strong> <strong>suo</strong> lavoro ). Nel lavoro si tratta sempre in primo luogo della cosa<br />
stessa e non del lavoratore, anche quando non abbia ancora avuto luogo una separazione<br />
totale tra lavoro e ' prodotto del lavoro '. Nel lavoro l’uomo viene continuamente allontanato<br />
dal <strong>suo</strong> essere-se-stesso e indirizzato a qualcosa d’altro, è continuamente presso qualcosa<br />
d’altro e per altri” 6 . Le parole di <strong>Marcuse</strong> sottolineano chiaramente che <strong>il</strong> lavoro è<br />
estraniazione, è un continuo allontanamento dell’uomo da ciò che dovrebbe essere la vita, un<br />
lavorare per essere al servizio di un processo produttivo <strong>il</strong> cui oggetto finale avrà la<br />
caratteristica di “essere-per-altri”, cioè creato dal lavoratore non per se stesso e per i <strong>suo</strong>i<br />
bisogni, ma per consentire alla catena produttiva di continuare a funzionare. In polemica con<br />
Marx, che distingueva nettamente tra oggettività ed alienazione, <strong>Marcuse</strong> le risolve l’una<br />
nell’altra sostenendo, in ultima analisi, che <strong>il</strong> <strong>superamento</strong> dell’alienazione non può essere<br />
cercato nel lavoro, ma solo nel gioco. Anche in questo si ha a che fare gli con oggetti, ma<br />
l’oggettività assolve in esso ad una funzione radicalmente diversa da quella che ha nel lavoro.<br />
Nel gioco l’uomo non si conforma agli oggetti e al loro essere già dati, bensì è egli stesso a<br />
creare liberamente per essi una nuova forma, che gli consente di disporre delle cose a proprio<br />
piacimento e quindi di porsi al di sopra di esse, sentendosi finalmente libero da quella cosalità<br />
che nel lavoro lo schiacciava. Sono questi i temi e le riflessioni che formano <strong>il</strong> bagaglio<br />
culturale di <strong>Marcuse</strong> quando questi nel 1933 entra a far parte dell’Institut für Sozialforschung<br />
( Istituto per la Ricerca Sociale ), divenuto poi famoso con <strong>il</strong> nome di Scuola di Francoforte.<br />
L’Istituto vide la luce nel 1923 per opera di Felix We<strong>il</strong> e fu inizialmente diretto da Karl<br />
Gründberg. In esso confluiranno personalità del calibro di Karl August Wittfogel, studioso<br />
delle <strong>società</strong> asiatiche pre-capitaliste, Henryk Grossmann e Friedrich Pollok, economisti,<br />
Franz Borkenau, storico, Max Horkheimer e Theodor Wisengrund Adorno, f<strong>il</strong>osofi. Nel 1929<br />
Gründberg dovette dimettersi e alla carica di direttore gli successe Max Horkheimer. Fu sotto<br />
la sua direzione che l’Istituto conobbe la sua migliore stagione, assumendo quelle<br />
6 H. <strong>Marcuse</strong>, Über die ph<strong>il</strong>osophischen Grundlagen des wirtschaftswissenschaftlichen Arbeitsbegriffs, in Kultur<br />
und Gesellschaft, Surhkamp, Francoforte 1965 ( Sui fondamenti f<strong>il</strong>osofici del concetto di lavoro, in Cultura e<br />
<strong>società</strong>. Saggi di teoria critica 1933-1965, tr. it. d. C. Ascheri, Einaudi, Torino 1969, p. 159 ).