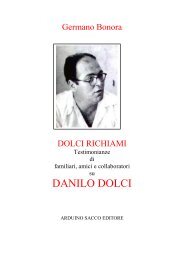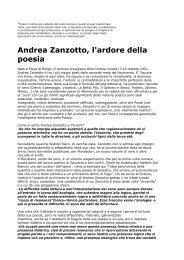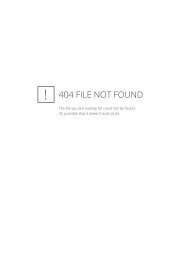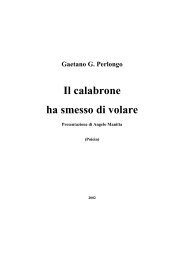Speciale Sardegna - Centro Studi e Ricerche Aleph
Speciale Sardegna - Centro Studi e Ricerche Aleph
Speciale Sardegna - Centro Studi e Ricerche Aleph
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
A passo di gambero, un commento<br />
di Fabiana Barilli<br />
A passo di gambero è un racconto che si articola in tre episodi. Il<br />
primo di questi esprime, celata dietro un’apparente lezione<br />
filosofica, la volontà di Alberto Cantoni di affermare uno dei<br />
principi fondamentali dell’umorismo: la labilità, l’illusorietà delle<br />
apparenze che impediscono di giungere ad una verità<br />
incondizionata, ad una scoperta assoluta, ad un’affermazione<br />
precisa, come quella cui aspira il professore protagonista: la<br />
creazione di Dio.<br />
Tuttavia, la questione centrale è costituita non dalla volontà e<br />
dalla possibilità di creare nientemeno che Dio, ma l’episodio dal<br />
quale queste, a detta dello stesso professore, sono scaturite.<br />
L’affollata assemblea, trepidante per essere sul punto di assistere<br />
all’invenzione del secolo, si trova a dover ascoltare un discorso su<br />
un bottone! Fichte confessa di essere rimasto sconvolto ed<br />
intellettualmente immobilizzato da una visione sconcertante: la<br />
giacca del suo migliore alunno priva di un bottone. La chiave del<br />
discorso sta nella dichiarazione di sapersi concentrare su una<br />
mancanza piuttosto che su una presenza, e di fondare su questa<br />
la propria sicurezza.<br />
Nella vita, date le sue ambiguità e contraddizioni, accade proprio<br />
che sia più semplice dire, vedere, capire, ciò che non è piuttosto<br />
che quel che è. La scucitura della stoffa rappresenta gli strappi<br />
moderni della coscienza umana, ovvero i dubbi, le angosce, le<br />
perplessità, non necessariamente apportati da eventi tristi o<br />
addirittura luttuosi, ma anche dalla semplice quotidianità, la quale<br />
spesso non è in grado di garantire certezze e punti di riferimento,<br />
persino sulla propria identità e su quella degli altri, nel gioco delle<br />
parti che è la vita.<br />
«Quel bottone che non c’era divenne la mia stella polare»,<br />
dichiara il filosofo. La stella polare dell’autore, il quale cerca di<br />
trasmetterla ai suoi lettori, è invece la capacità di prendere<br />
coscienza dell’illusorietà e della molteplicità del reale. Non ha più<br />
tanta importanza la proclamazione o meno di Dio:<br />
Ma il povero Dio fu tanto subissato sotto una gragnuola così fitta<br />
di obiettività e di subiettività che alla stretta dei conti si avrebbe<br />
potuto giurare che o Dio c’era anche prima di Fichte, o non c’era e<br />
non ci sarà né prima né dopo.<br />
La vera e più risolutiva scoperta (almeno finché bisogna fare i<br />
conti con l’umile esistenza terrena) è un’altra: possono essere<br />
proprio un’assenza, una rottura, una mancanza, a riempire, a<br />
colmare, a spiegare, a stimolare; queste sono spesso più vere e<br />
più possibili della matematica certezza e di un riferimento<br />
assoluto. Il vuoto e l’imperfezione sono le situazioni più correnti e<br />
normali, per cui l’unica via di salvezza può essere il cercare di<br />
renderle anche ideali.<br />
Ci possono essere solo consolazioni per la precarietà dell’essere<br />
umano. I punti di riferimento diventano allora le abitudini, le cose<br />
che si sa di poter trovare sempre al medesimo posto in mezzo al<br />
caos fisiologico del mondo; in tal caso allora non è il bottone nello<br />
stesso punto sul cappotto che bisogna cercare, ma il pezzo di<br />
stoffa rimasto vuoto per la mancanza di quel bottone, rivelatore di<br />
una banale quanto rassicurante certezza: quello che là dovrebbe<br />
esserci, per completezza e precisione, ma soprattutto per<br />
normalità, è assente. Fondamentale non è la condizione di<br />
presenza piuttosto che di assenza, ma è la lucidità di saper<br />
individuare un punto fisso cui riferirsi; poco importante poi è che<br />
sia rappresentato da un pieno o da un vuoto, da un più o da un<br />
meno.<br />
Il grande passo che solo l’umorista sa compiere è proprio quello di<br />
sapersi adattare all’anormalità e alla stranezza comprendendo<br />
che queste sono solo apparenti, perché le facciate del reale<br />
possono celare quanto di più immaginoso e spettacolare.<br />
In poche righe Cantoni riesce ad avere intuizioni sottili e capaci di<br />
distaccarsi da quella morale che, non per nulla, suol dirsi<br />
“comune”; se il protagonista del racconto è lo studioso,<br />
l’antagonista non è incarnato da un’unica entità, ma dalla folla<br />
divoratrice, dalla maggioranza indistinta emblema della carenza di<br />
sensibilità e dell’incapacità di profonda riflessione. Il popolo è<br />
portatore di relativa coscienza e di modesta capacità di<br />
comunicazione, e per questo ancora più ingiustificato e ridicolo<br />
nella continua volontà di giudizio ferreo e inderogabile.<br />
Progetto Babele Dodici<br />
- 39 -<br />
Anche la scelta di Fichte (operando addirittura una sostituzione<br />
con Locke, vero protagonista dell’evento, come spiega in nota lo<br />
stesso autore) è significativa: se l’umorista è il negatore dell’unità<br />
dell’Io, il filosofo, con il suo idealismo, pone la base filosofica del<br />
Romanticismo tedesco: identifica il reale con l’Io e vede il mondo<br />
esterno come sua negazione, non-Io. Da qui nasce l’impulso di<br />
fuga dal reale, il soggettivismo esasperato, la tensione verso<br />
l’infinito, ma anche la cosiddetta “ironia romantica” che sorge dalla<br />
consapevolezza che appunto la realtà esteriore non è altro che<br />
una riproduzione e che come tale non può fare a meno di essere<br />
sempre un poco falsata.<br />
«Voltiamo pagina»: sono le parole che utilizza Cantoni con un<br />
intervento diretto a segnalare il passaggio dall’aneddoto di Fichte<br />
all’episodio successivo. Ecco allora un esempio di meta-racconto,<br />
dove l’autore è narratore e critico insieme. Presenta infatti<br />
direttamente al pubblico il suo scritto in fieri, e ne scandisce i<br />
passaggi ad alta voce (oltre che graficamente attraverso i tre<br />
asterischi e lo spazio bianco del foglio).<br />
La narrazione seguente si apre con una dichiarazione forte e<br />
decisa in prima persona:<br />
Io sono miope.<br />
Si annuncia la storia di un buffo scambio, attraverso l’espediente<br />
favolistico dell’incantesimo, fra due tizî che hanno opposti<br />
problemi di vista e che quindi si compensano e<br />
contemporaneamente s’invidiano a vicenda. L’immedesimazione<br />
dell’autore con il protagonista è palese: il miope è «uno sciagurato<br />
che divora più libri di quel che non mangi ciambelle» e, per di più,<br />
ha come compagno un contadino (e Cantoni, si sa, non si è mai<br />
voluto staccare dal mondo della campagna).<br />
Si possono individuare più modelli di lettura e dunque più finalità<br />
pedagogiche dell’opera. Il primo consiglio vuole essere quello di<br />
sapersi accontentare e di non illudersi che il bello e il buono<br />
assoluti esistano, e che, pur apparenti, stiano sempre da una<br />
parte ben precisa; si vuole appunto allertare sul pericolo di<br />
credere che ciò che appartiene ad altri sia sempre migliore del<br />
nostro, quando in realtà tutto è ontologicamente momentaneo e<br />
relativo nel gran caos illusorio che è la vita.<br />
Infatti se il miope, una volta scambiata la sua vista con quella del<br />
contadino, riesce ad ammirare le cose lontane e a distinguerle con<br />
chiarezza, non è più in grado però di svolgere con disinvoltura<br />
l’attività che più ama, la lettura:<br />
[…] lietissimo perché non scambiavo più le donne per uomini, gli<br />
uomini per donne e i cani per bambini gridai al miracolo […] ma io<br />
disgraziato non po-te-vo-più-leg-ge-re!<br />
Comprende allora quanto questa non abbia prezzo per lui e<br />
quanto il benessere dell’altro, con la sua «vista da falco», sia<br />
soltanto apparente. Allo stesso modo il contadino rimpiange lo<br />
CONSIGLI DI LETTURA<br />
Alberto Cantoni (1841-1904)<br />
Alberto Cantoni è uno di quei casi di autori che non<br />
inseguirono la popolarità, ma piuttosto restarono in disparte, in<br />
modo anche un po’ eccentrico: “Sì, me lo dico da me - diceva<br />
di sé stesso - io sono uno di quegli uomini che non si possono<br />
amare bene che dopo morti; lasciatemi questa illusione!”. Nato<br />
a Pomponesco (MN) nel 1841, morto a Mantova nel 1904. Il<br />
padre Israel era un ebreo convertito, da cui Alberto ereditò<br />
grandi possedimenti, nel Mantovano, in cui visse per tutta la<br />
vita, anche se amava andare in giro per l’Europa ed aveva<br />
moltissimi corrispondenti in vari paesi. Esordisce come<br />
scrittore nel 1875 con quattro racconti sulla “Nuova Antologia”.<br />
Successivamente scrive una serie di racconti e romanzi che<br />
pubblica in editori di poca risonanza. “Un sacerdote<br />
dell’inedito” lo definiva Alberto Musatti sul “Fanfulla della<br />
domenica”. Opere principali: Un re umorista (1891), L’altalena<br />
delle antipatie (1893), Pietro e Paola (1897), Scaricalasino<br />
(1901), L’illustrissimo (1904). Ebbe recensioni favorevoli da<br />
grandi nomi, come Pirandello, Croce e Bacchelli, ma l’oblio<br />
intorno al suo nome non si diradò neanche dopo la morte,<br />
come invece forse sperava. C.S.