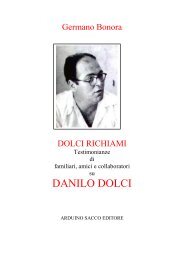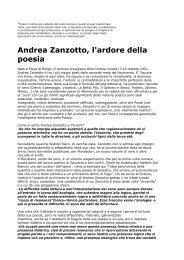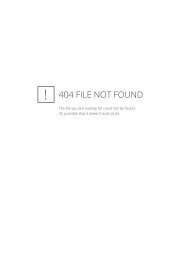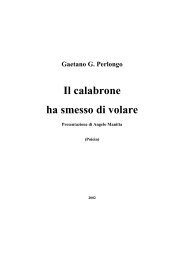Speciale Sardegna - Centro Studi e Ricerche Aleph
Speciale Sardegna - Centro Studi e Ricerche Aleph
Speciale Sardegna - Centro Studi e Ricerche Aleph
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Progetto Babele Dodici<br />
La Secchia Rapita, poema eroicomico.<br />
A cura di Carlo Santulli<br />
“La Secchia rapita” di Alessandro Tassoni (1622)<br />
I G R A N D I U M O R I S T I<br />
A Modena, all'interno<br />
della Ghirlandina, la torre<br />
che costituisce il simbolo<br />
di questa città, erede di<br />
una rivalità mica tanto<br />
dimenticata con la<br />
bolognese torre degli<br />
Asinelli, è appesa una<br />
secchia " in alto per trofeo<br />
posta e legata/con una<br />
gran catena a' curvi<br />
sassi". Niente di speciale,<br />
la secchia in sé, al punto<br />
che la catena, come<br />
osserva il poeta, appare<br />
sproporzionata alla<br />
bisogna.<br />
Tuttavia, la secchia<br />
rappresenta, nelle sue<br />
grandezze e nelle sue<br />
inevitabili miserie, quella<br />
che fu la lotta comunale<br />
in Italia, qualcosa al suo apice di tragico ed insieme patriottico, ma<br />
con aspetti burleschi che fanno ricordare le disfide di campanile<br />
per le quali è noto il nostro campionato di calcio. Ma lasciamo la<br />
parola al prologo de "La secchia rapita" di Alessandro Tassoni:<br />
"La Secchia Rapita, poema di nuova spezie inventata dal<br />
Tassone, contiene una impresa mezza eroica e mezza civile,<br />
fondata su l'istoria della guerra, che passò tra i Bolognesi e i<br />
Modanesi al tempo dell'imperador Federico Secondo, nella quale<br />
Enzio re di Sardigna, figliuolo del medesimo Federico,<br />
combattendo in aiuto de' Modanesi, restò prigione e prima d'esser<br />
liberato morí in Bologna, come oggidi ancora può vedersi<br />
dall'epitafio della sua sepoltura nella chiesa di S. Domenico".<br />
La vicenda quindi, cui risale il furto della secchia, fa parte di quelle<br />
guerre e guerricciole della nostra età comunale, ed era stata<br />
preceduta da qualcosa come trent'anni di litigi e rivendicazioni da<br />
parte dei modenesi (ghibellini) ai danni dei bolognesi (guelfi).<br />
Coi parametri del tempo, comunque, la battaglia cosiddetta della<br />
Secchia Rapita (15 novembre 1325) non fu piccola affatto. Diamo<br />
qualche numero: trentamila fanti e duemila cavalieri per i<br />
Bolognesi, e cinquemila fanti e duemila cavalieri per i Modenesi.<br />
Fu anche una battaglia molto sanguinosa, che lasciò più di<br />
duemila morti sul campo. I Modenesi, nonostante la massa di fanti<br />
schierata contro di loro, prevalsero: anzi, messi in fuga i rivali, li<br />
inseguirono, data anche la modesta distanza tra le due città, fino<br />
alle porte di Bologna. Qui giunti, realizzarono che Bologna era<br />
una città molto più grande di quel che credevano, e che non si<br />
poteva invaderla e sarebbe stato anche poco realistico pensare di<br />
dare ai Bolognesi una sonora lezione. Si limitarono a correre un<br />
gran numero di tornei sotto le mura, a prenderli in giro insomma, e<br />
si impadronirono della secchia. Aperta una porta della città, che si<br />
diceva legata dalla catena che ora tiene la secchia ancorata al<br />
muro di volta della Ghirlandina, la secchia, faceva loro comodo<br />
per bere a qualche pozzo, perché avevano sete, e scapparono<br />
indietro verso Modena.<br />
Come si vede da questi pochi cenni, tragico e burlesco sono<br />
strettamente mescolati, e questo è per così dire molto tipico della<br />
nostra storia medievale. La letteratura del tempo non ignorò<br />
questo scontro, anzi il bolognese Antonio Beccari, poeta girovago<br />
che aveva vissuto alla corte degli Oleggio, diversi anni più tardi<br />
citò lo scontro di Zappolino in una rima, dove lamentava la<br />
crudeltà e la perfidia dell’animo umano.<br />
Tuttavia, col tempo, la violenza di questo scontro che era seguito<br />
a tanti anni di discordia, fu dimenticata: la secchia appesa sotto il<br />
muro di volta della Ghirlandina ne rimase il ricordo, ed un ricordo<br />
più burlesco che tragico, in verità.<br />
Così, quando il Tassoni, circa tre secoli dopo, pubblica il suo<br />
poema eroicomico "La secchia rapita" (1622), la battaglia era<br />
stata declassata a scaramuccia dalla tradizione, e questi sono i<br />
- 53 -<br />
CONSIGLI DI LETTURA<br />
Alessandro Tassoni (1565-1635)<br />
Alessandro Tassoni<br />
nacque a Modena nel<br />
1565 da una famiglia<br />
nobile. Rimasto orfano,<br />
dopo anni di<br />
dissolutezze, completò<br />
gli studi tra Bologna,<br />
Ferrara e Pisa e fu<br />
posto al servizio del<br />
Cardinale Ascanio<br />
Colonna, con il quale<br />
visse in Spagna dal<br />
1600 al 1603. Rientrato<br />
in Italia, fu ambasciatore<br />
piemontese a Roma al<br />
servizio del duca Carlo<br />
Emanuele I di Savoia, che lo scrittore riteneva “il più<br />
magnanimo principe che abbia la nostra età”,<br />
ammirandone la politica d’indipendenza nei<br />
confronti della Spagna. In questo periodo compose<br />
una raccolta di pensieri dal titolo "Varietà di pensieri<br />
di Alessandro Tassoni" divisa in nove parti e<br />
contrassegnata da un tenace anti-aristotelismo.<br />
Già da questi scritti si nota la personalità vivace ed<br />
irosa che lo caratterizzò per tutta la vita, e la sua<br />
corrosiva vena polemica, spesso indirizzata contro<br />
gli emuli del Petrarca. La pedantesca cultura<br />
secentista si coniuga in Tassoni al desiderio di<br />
nuovo, alla ricerca del paradossale e del bizzarro.<br />
I suoi forti sentimenti anti-spagnoli animano<br />
un’opera di oratoria politica, praticamente un<br />
pamphlet, che rappresenta una delle poche<br />
espressioni letterarie della protesta contro la<br />
dominazione straniera: le “Filippiche contro gli<br />
Spagnoli”. Il Tassoni invitava i principi italiani a<br />
ribellarsi, seguendo appunto l’esempio del duca di<br />
Savoia Carlo Emanuele, che nel 1612 aveva mosso<br />
guerra alla Spagna per il Monferrato.<br />
Stampate tra il 1614 e il 1615, le Filippiche sono<br />
concordemente attribuite al Tassoni dalla critica,<br />
benché egli non ammise mai di esserne l’autore,<br />
per timore di ritorsioni e vendette, e gli ottennero di<br />
entrare ancor più nelle grazie dello stesso duca di<br />
Savoia, che nel 1618 lo volle a Torino col titolo di<br />
primo segretario. Nel 1621 Tassoni si ritirò a vita<br />
privata a causa della mutata politica del duca<br />
sabaudo e delle conseguenti ostilità dell’ambiente di<br />
corte nei suoi confronti.<br />
Nel 1622 pubblicò “La secchia rapita”, composta in<br />
ottava rima, in cui, sebbene l'azione si svolga nel<br />
secolo XIII, i riferimenti alla contemporaneità sono<br />
numerosi ed espressi con arguzia e riferimenti<br />
polemici di carattere personale che contribuiscono a<br />
vivacizzare i personaggi.<br />
Nel 1626 fu al servizio del cardinale Ludovisi e nel<br />
1632 del duca Francesco I di Modena. Morì nella<br />
sua città natale appena tre anni dopo, il 25 aprile<br />
1635.