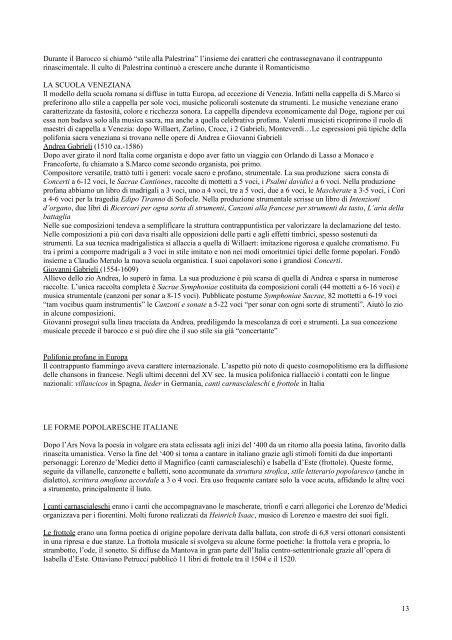STORIA DELLA MUSICA
STORIA DELLA MUSICA
STORIA DELLA MUSICA
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Durante il Barocco si chiamò “stile alla Palestrina” l’insieme dei caratteri che contrassegnavano il contrappunto<br />
rinascimentale. Il culto di Palestrina continuò a crescere anche durante il Romanticismo<br />
LA SCUOLA VENEZIANA<br />
Il modello della scuola romana si diffuse in tutta Europa, ad eccezione di Venezia. Infatti nella cappella di S.Marco si<br />
preferirono allo stile a cappella per sole voci, musiche policorali sostenute da strumenti. Le musiche veneziane erano<br />
caratterizzate da fastosità, colore e ricchezza sonora. La cappella dipendeva economicamente dal Doge, ragione per cui<br />
essa non badava solo alla musica sacra, ma anche a quella celebrativa profana. Valenti musicisti ricoprirono il ruolo di<br />
maestri di cappella a Venezia: dopo Willaert, Zarlino, Croce, i 2 Gabrieli, Monteverdi…Le espressioni più tipiche della<br />
polifonia sacra veneziana si trovano nelle opere di Andrea e Giovanni Gabrieli<br />
Andrea Gabrieli (1510 ca.-1586)<br />
Dopo aver girato il nord Italia come organista e dopo aver fatto un viaggio con Orlando di Lasso a Monaco e<br />
Francoforte, fu chiamato a S.Marco come secondo organista, poi primo.<br />
Compositore versatile, trattò tutti i generi: vocale sacro e profano, strumentale. La sua produzione sacra consta di<br />
Concerti a 6-12 voci, le Sacrae Cantiones, raccolte di mottetti a 5 voci, i Psalmi davidici a 6 voci. Nella produzione<br />
profana abbiamo un libro di madrigali a 3 voci, uno a 4 voci, tre a 5 voci, due a 6 voci, le Mascherate a 3-5 voci, i Cori<br />
a 4-6 voci per la tragedia Edipo Tiranno di Sofocle. Nella produzione strumentale scrisse un libro di Intenzioni<br />
d’organo, due libri di Ricercari per ogna sorta di strumenti, Canzoni alla francese per strumenti da tasto, L’aria della<br />
battaglia<br />
Nelle sue composizioni tendeva a semplificare la struttura contrappuntistica per valorizzare la declamazione del testo.<br />
Nelle composizioni a più cori dava risalti alle opposizioni delle parti e agli effetti timbrici, spesso sostenuti da<br />
strumenti. La sua tecnica madrigalistica si allaccia a quella di Willaert: imitazione rigorosa e qualche cromatismo. Fu<br />
tra i primi a comporre madrigali a 3 voci in stile imitato e non nei modi omoritmici tipici delle forme popolari. Fondò<br />
insieme a Claudio Merulo la nuova scuola organistica. I suoi capolavori sono i grandiosi Concerti.<br />
Giovanni Gabrieli (1554-1609)<br />
Allievo dello zio Andrea, lo superò in fama. La sua produzione è più scarsa di quella di Andrea e sparsa in numerose<br />
raccolte. L’unica raccolta completa è Sacrae Symphoniae costituita da composizioni corali (44 mottetti a 6-16 voci) e<br />
musica strumentale (canzoni per sonar a 8-15 voci). Pubblicate postume Symphoniae Sacrae, 82 mottetti a 6-19 voci<br />
“tam vocibus quam instrumentis” le Canzoni e sonate a 5-22 voci “per sonar con ogni sorte di strumenti”. Aiutò lo zio<br />
in alcune composizioni.<br />
Giovanni proseguì sulla linea tracciata da Andrea, prediligendo la mescolanza di cori e strumenti. La sua concezione<br />
musicale precede il barocco e si può dire che il suo stile sia già “concertante”<br />
Polifonie profane in Europa<br />
Il contrappunto fiammingo aveva carattere internazionale. L’aspetto più noto di questo cosmopolitismo era la diffusione<br />
delle chansons in francese. Negli ultimi decenni del XV sec. la musica polifonica riallacciò i contatti con le lingue<br />
nazionali: villancicos in Spagna, lieder in Germania, canti carnascialeschi e frottole in Italia<br />
LE FORME POPOLARESCHE ITALIANE<br />
Dopo l’Ars Nova la poesia in volgare era stata eclissata agli inizi del ‘400 da un ritorno alla poesia latina, favorito dalla<br />
rinascita umanistica. Verso la fine del ‘400 si torna a cantare in italiano grazie agli stimoli forniti da due importanti<br />
personaggi: Lorenzo de’Medici detto il Magnifico (canti carnascialeschi) e Isabella d’Este (frottole). Queste forme,<br />
seguite da villanelle, canzonette e balletti, sono accomunate da struttura strofica, stile letterario popolaresco (anche in<br />
dialetto), scrittura omofona accordale a 3 o 4 voci. Era uso frequente cantare solo la voce acuta, affidando le altre voci<br />
a strumento, principalmente il liuto.<br />
I canti carnascialeschi erano i canti che accompagnavano le mascherate, trionfi e carri allegorici che Lorenzo de’Medici<br />
organizzava per i fiorentini. Molti furono realizzati da Heinrich Isaac, musico di Lorenzo e maestro dei suoi figli.<br />
Le frottole erano una forma poetica di origine popolare derivata dalla ballata, con strofe di 6,8 versi ottonari consistenti<br />
in una ripresa e due stanze. La frottola musicale si svolgeva su alcune forme poetiche: la frottola vera e propria, lo<br />
strambotto, l’ode, il sonetto. Si diffuse da Mantova in gran parte dell’Italia centro-settentrionale grazie all’opera di<br />
Isabella d’Este. Ottaviano Petrucci pubblicò 11 libri di frottole tra il 1504 e il 1520.<br />
13