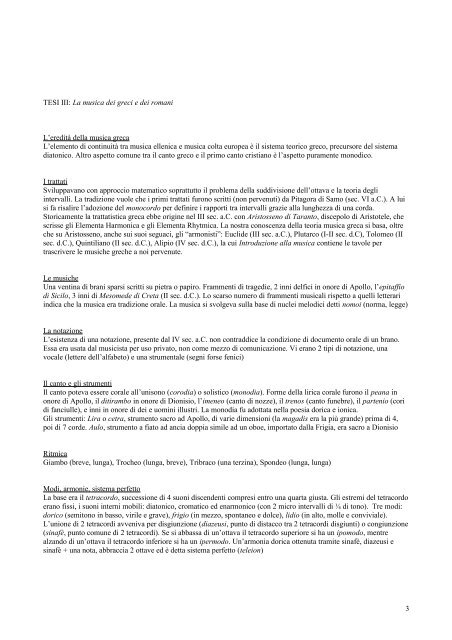STORIA DELLA MUSICA
STORIA DELLA MUSICA
STORIA DELLA MUSICA
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
TESI III: La musica dei greci e dei romani<br />
L’eredità della musica greca<br />
L’elemento di continuità tra musica ellenica e musica colta europea è il sistema teorico greco, precursore del sistema<br />
diatonico. Altro aspetto comune tra il canto greco e il primo canto cristiano è l’aspetto puramente monodico.<br />
I trattati<br />
Sviluppavano con approccio matematico soprattutto il problema della suddivisione dell’ottava e la teoria degli<br />
intervalli. La tradizione vuole che i primi trattati furono scritti (non pervenuti) da Pitagora di Samo (sec. VI a.C.). A lui<br />
si fa risalire l’adozione del monocordo per definire i rapporti tra intervalli grazie alla lunghezza di una corda.<br />
Storicamente la trattatistica greca ebbe origine nel III sec. a.C. con Aristosseno di Taranto, discepolo di Aristotele, che<br />
scrisse gli Elementa Harmonica e gli Elementa Rhytmica. La nostra conoscenza della teoria musica greca si basa, oltre<br />
che su Aristosseno, anche sui suoi seguaci, gli “armonisti”: Euclide (III sec. a.C.), Plutarco (I-II sec. d.C), Tolomeo (II<br />
sec. d.C.), Quintiliano (II sec. d.C.), Alipio (IV sec. d.C.), la cui Introduzione alla musica contiene le tavole per<br />
trascrivere le musiche greche a noi pervenute.<br />
Le musiche<br />
Una ventina di brani sparsi scritti su pietra o papiro. Frammenti di tragedie, 2 inni delfici in onore di Apollo, l’epitaffio<br />
di Sicilo, 3 inni di Mesomede di Creta (II sec. d.C.). Lo scarso numero di frammenti musicali rispetto a quelli letterari<br />
indica che la musica era tradizione orale. La musica si svolgeva sulla base di nuclei melodici detti nomoi (norma, legge)<br />
La notazione<br />
L’esistenza di una notazione, presente dal IV sec. a.C. non contraddice la condizione di documento orale di un brano.<br />
Essa era usata dal musicista per uso privato, non come mezzo di comunicazione. Vi erano 2 tipi di notazione, una<br />
vocale (lettere dell’alfabeto) e una strumentale (segni forse fenici)<br />
Il canto e gli strumenti<br />
Il canto poteva essere corale all’unisono (corodia) o solistico (monodia). Forme della lirica corale furono il peana in<br />
onore di Apollo, il ditirambo in onore di Dionisio, l’imeneo (canto di nozze), il trenos (canto funebre), il partenio (cori<br />
di fanciulle), e inni in onore di dei e uomini illustri. La monodia fu adottata nella poesia dorica e ionica.<br />
Gli strumenti: Lira o cetra, strumento sacro ad Apollo, di varie dimensioni (la magadis era la più grande) prima di 4,<br />
poi di 7 corde. Aulo, strumento a fiato ad ancia doppia simile ad un oboe, importato dalla Frigia, era sacro a Dionisio<br />
Ritmica<br />
Giambo (breve, lunga), Trocheo (lunga, breve), Tribraco (una terzina), Spondeo (lunga, lunga)<br />
Modi, armonie, sistema perfetto<br />
La base era il tetracordo, successione di 4 suoni discendenti compresi entro una quarta giusta. Gli estremi del tetracordo<br />
erano fissi, i suoni interni mobili: diatonico, cromatico ed enarmonico (con 2 micro intervalli di ¼ di tono). Tre modi:<br />
dorico (semitono in basso, virile e grave), frigio (in mezzo, spontaneo e dolce), lidio (in alto, molle e conviviale).<br />
L’unione di 2 tetracordi avveniva per disgiunzione (diazeusi, punto di distacco tra 2 tetracordi disgiunti) o congiunzione<br />
(sinafè, punto comune di 2 tetracordi). Se si abbassa di un’ottava il tetracordo superiore si ha un ipomodo, mentre<br />
alzando di un’ottava il tetracordo inferiore si ha un ipermodo. Un’armonia dorica ottenuta tramite sinafè, diazeusi e<br />
sinafè + una nota, abbraccia 2 ottave ed è detta sistema perfetto (teleion)<br />
3