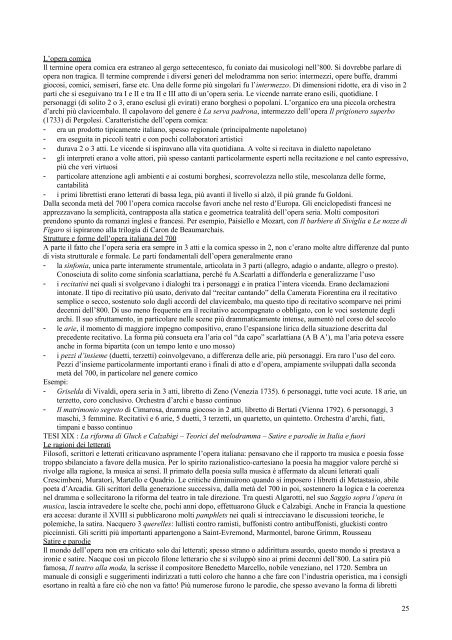STORIA DELLA MUSICA
STORIA DELLA MUSICA
STORIA DELLA MUSICA
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
L’opera comica<br />
Il termine opera comica era estraneo al gergo settecentesco, fu coniato dai musicologi nell’800. Si dovrebbe parlare di<br />
opera non tragica. Il termine comprende i diversi generi del melodramma non serio: intermezzi, opere buffe, drammi<br />
giocosi, comici, semiseri, farse etc. Una delle forme più singolari fu l’intermezzo. Di dimensioni ridotte, era di viso in 2<br />
parti che si eseguivano tra I e II e tra II e III atto di un’opera seria. Le vicende narrate erano esili, quotidiane. I<br />
personaggi (di solito 2 o 3, erano esclusi gli evirati) erano borghesi o popolani. L’organico era una piccola orchestra<br />
d’archi più clavicembalo. Il capolavoro del genere è La serva padrona, intermezzo dell’opera Il prigionero superbo<br />
(1733) di Pergolesi. Caratteristiche dell’opera comica:<br />
- era un prodotto tipicamente italiano, spesso regionale (principalmente napoletano)<br />
- era eseguita in piccoli teatri e con pochi collaboratori artistici<br />
- durava 2 o 3 atti. Le vicende si ispiravano alla vita quotidiana. A volte si recitava in dialetto napoletano<br />
- gli interpreti erano a volte attori, più spesso cantanti particolarmente esperti nella recitazione e nel canto espressivo,<br />
più che veri virtuosi<br />
- particolare attenzione agli ambienti e ai costumi borghesi, scorrevolezza nello stile, mescolanza delle forme,<br />
cantabilità<br />
- i primi librettisti erano letterati di bassa lega, più avanti il livello si alzò, il più grande fu Goldoni.<br />
Dalla seconda metà del 700 l’opera comica raccolse favori anche nel resto d’Europa. Gli enciclopedisti francesi ne<br />
apprezzavano la semplicità, contrapposta alla statica e geometrica teatralità dell’opera seria. Molti compositori<br />
prendono spunto da romanzi inglesi e francesi. Per esempio, Paisiello e Mozart, con Il barbiere di Siviglia e Le nozze di<br />
Figaro si ispirarono alla trilogia di Caron de Beaumarchais.<br />
Strutture e forme dell’opera italiana del 700<br />
A parte il fatto che l’opera seria era sempre in 3 atti e la comica spesso in 2, non c’erano molte altre differenze dal punto<br />
di vista strutturale e formale. Le parti fondamentali dell’opera generalmente erano<br />
- la sinfonia, unica parte interamente strumentale, articolata in 3 parti (allegro, adagio o andante, allegro o presto).<br />
Conosciuta di solito come sinfonia scarlattiana, perché fu A.Scarlatti a diffonderla e generalizzarne l’uso<br />
- i recitativi nei quali si svolgevano i dialoghi tra i personaggi e in pratica l’intera vicenda. Erano declamazioni<br />
intonate. Il tipo di recitativo più usato, derivato dal “recitar cantando” della Camerata Fiorentina era il recitativo<br />
semplice o secco, sostenuto solo dagli accordi del clavicembalo, ma questo tipo di recitativo scomparve nei primi<br />
decenni dell’800. Di uso meno frequente era il recitativo accompagnato o obbligato, con le voci sostenute degli<br />
archi. Il suo sfruttamento, in particolare nelle scene più drammaticamente intense, aumentò nel corso del secolo<br />
- le arie, il momento di maggiore impegno compositivo, erano l’espansione lirica della situazione descritta dal<br />
precedente recitativo. La forma più consueta era l’aria col “da capo” scarlattiana (A B A’), ma l’aria poteva essere<br />
anche in forma bipartita (con un tempo lento e uno mosso)<br />
- i pezzi d’insieme (duetti, terzetti) coinvolgevano, a differenza delle arie, più personaggi. Era raro l’uso del coro.<br />
Pezzi d’insieme particolarmente importanti erano i finali di atto e d’opera, ampiamente sviluppati dalla seconda<br />
metà del 700, in particolare nel genere comico<br />
Esempi:<br />
- Griselda di Vivaldi, opera seria in 3 atti, libretto di Zeno (Venezia 1735). 6 personaggi, tutte voci acute. 18 arie, un<br />
terzetto, coro conclusivo. Orchestra d’archi e basso continuo<br />
- Il matrimonio segreto di Cimarosa, dramma giocoso in 2 atti, libretto di Bertati (Vienna 1792). 6 personaggi, 3<br />
maschi, 3 femmine. Recitativi e 6 arie, 5 duetti, 3 terzetti, un quartetto, un quintetto. Orchestra d’archi, fiati,<br />
timpani e basso continuo<br />
TESI XIX : La riforma di Gluck e Calzabigi – Teorici del melodramma – Satire e parodie in Italia e fuori<br />
Le ragioni dei letterati<br />
Filosofi, scrittori e letterati criticavano aspramente l’opera italiana: pensavano che il rapporto tra musica e poesia fosse<br />
troppo sbilanciato a favore della musica. Per lo spirito razionalistico-cartesiano la poesia ha maggior valore perché si<br />
rivolge alla ragione, la musica ai sensi. Il primato della poesia sulla musica è affermato da alcuni letterati quali<br />
Crescimbeni, Muratori, Martello e Quadrio. Le critiche diminuirono quando si imposero i libretti di Metastasio, abile<br />
poeta d’Arcadia. Gli scrittori della generazione successiva, dalla metà del 700 in poi, sostennero la logica e la coerenza<br />
nel dramma e sollecitarono la riforma del teatro in tale direzione. Tra questi Algarotti, nel suo Saggio sopra l’opera in<br />
musica, lascia intravedere le scelte che, pochi anni dopo, effettuarono Gluck e Calzabigi. Anche in Francia la questione<br />
era accesa: durante il XVIII si pubblicarono molti pamphlets nei quali si intrecciavano le discussioni teoriche, le<br />
polemiche, la satira. Nacquero 3 querelles: lullisti contro ramisti, buffonisti contro antibuffonisti, gluckisti contro<br />
piccinnisti. Gli scritti più importanti appartengono a Saint-Evremond, Marmontel, barone Grimm, Rousseau<br />
Satire e parodie<br />
Il mondo dell’opera non era criticato solo dai letterati; spesso strano o addirittura assurdo, questo mondo si prestava a<br />
ironie e satire. Nacque così un piccolo filone letterario che si sviluppò sino ai primi decenni dell’800. La satira più<br />
famosa, Il teatro alla moda, la scrisse il compositore Benedetto Marcello, nobile veneziano, nel 1720. Sembra un<br />
manuale di consigli e suggerimenti indirizzati a tutti coloro che hanno a che fare con l’industria operistica, ma i consigli<br />
esortano in realtà a fare ciò che non va fatto! Più numerose furono le parodie, che spesso avevano la forma di libretti<br />
25