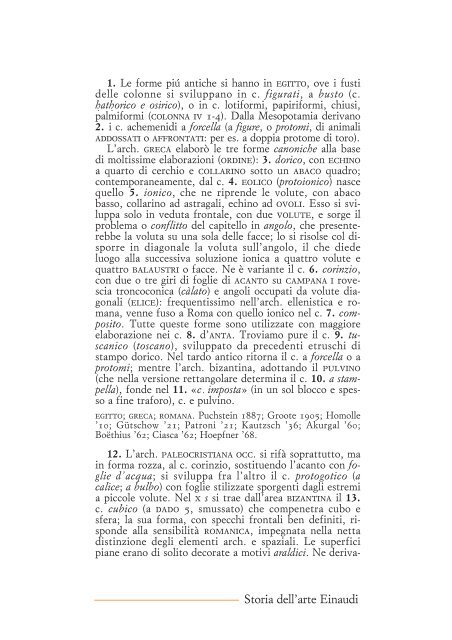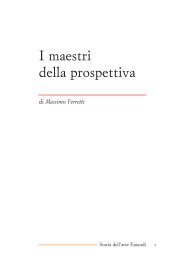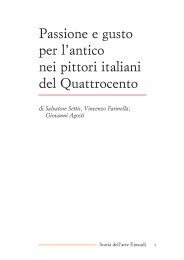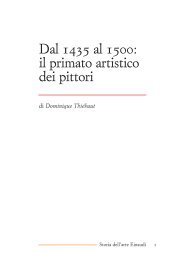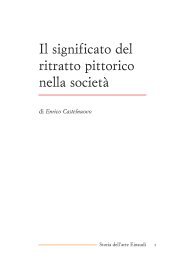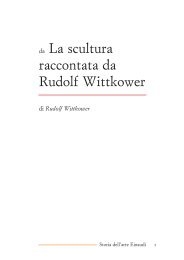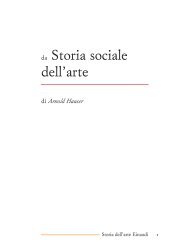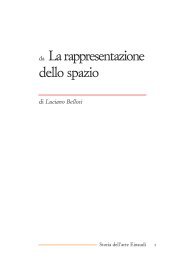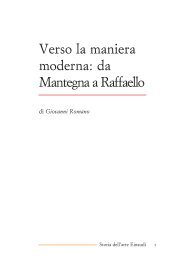You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
1. Le forme piú antiche si hanno in eg<strong>it</strong>to, ove i fusti<br />
delle colonne si sviluppano in c. figurati, a busto (c.<br />
h. ath. orico e osirico), o in c. lotiformi, papiriformi, chiusi,<br />
palmiformi (colonna iv 1-4). Dalla Mesopotamia derivano<br />
2. i c. achemenidi a forcella (a figure, o protomi, di animali<br />
addossati o affrontati: per es. a doppia protome di toro).<br />
L’arch. greca elaborò le tre forme canoniche alla base<br />
di moltissime elaborazioni (ordine): 3. dorico, con echino<br />
a quarto di cerchio e collarino sotto un abaco quadro;<br />
contemporaneamente, dal c. 4. eolico (protoionico) nasce<br />
quello 5. ionico, che ne riprende le volute, con abaco<br />
basso, collarino ad astragali, echino ad ovoli. Esso si sviluppa<br />
solo in veduta frontale, con due volute, e sorge il<br />
problema o confl<strong>it</strong>to del cap<strong>it</strong>ello in angolo, che presenterebbe<br />
la voluta su una sola delle facce; lo si risolse col disporre<br />
in diagonale la voluta sull’angolo, il che diede<br />
luogo alla successiva soluzione ionica a quattro volute e<br />
quattro balaustri o facce. Ne è variante il c. 6. corinzio,<br />
con due o tre giri di foglie di acanto su campana i rovescia<br />
troncoconica (càlato) e angoli occupati da volute diagonali<br />
(elice): frequentissimo nell’arch. ellenistica e romana,<br />
venne fuso a Roma con quello ionico nel c. 7. compos<strong>it</strong>o.<br />
Tutte queste forme sono utilizzate con maggiore<br />
elaborazione nei c. 8. d’anta. Troviamo pure il c. 9. tuscanico<br />
(toscano), sviluppato da precedenti etruschi di<br />
stampo dorico. Nel tardo antico r<strong>it</strong>orna il c. a forcella o a<br />
protomi; mentre l’arch. bizantina, adottando il pulvino<br />
(che nella versione rettangolare determina il c. 10. a stampella),<br />
fonde nel 11. «c. imposta» (in un sol blocco e spesso<br />
a fine traforo), c. e pulvino.<br />
eg<strong>it</strong>to; greca; romana. Puchstein 1887; Groote 1905; Homolle<br />
’10; Gütschow ’21; Patroni ’21; Kautzsch ’36; Akurgal ’60;<br />
Boëthius ’62; Ciasca ’62; Hoepfner ’68.<br />
12. L’arch. paleocristiana occ. si rifà soprattutto, ma<br />
in forma rozza, al c. corinzio, sost<strong>it</strong>uendo l’acanto con foglie<br />
d’acqua; si sviluppa fra l’altro il c. protogotico (a<br />
calice; a bulbo) con foglie stilizzate sporgenti dagli estremi<br />
a piccole volute. Nel x s si trae dall’area bizantina il 13.<br />
c. cubico (a dado 5, smussato) che compenetra cubo e<br />
sfera; la sua forma, con specchi frontali ben defin<strong>it</strong>i, risponde<br />
alla sensibil<strong>it</strong>à romanica, impegnata nella netta<br />
distinzione degli elementi arch. e spaziali. Le superfici<br />
piane erano di sol<strong>it</strong>o decorate a motivi araldici. Ne deriva-<br />
<strong>Storia</strong> dell’arte <strong>Einaudi</strong>