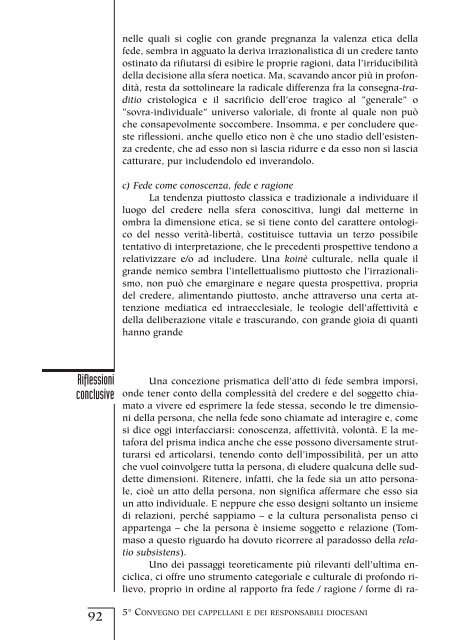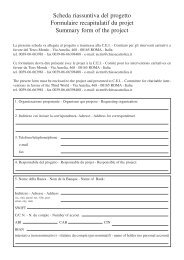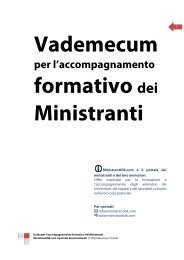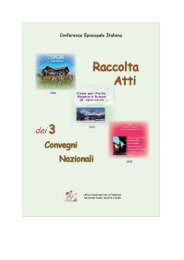Quaderno CEI n 24-08 - Chiesa Cattolica Italiana
Quaderno CEI n 24-08 - Chiesa Cattolica Italiana
Quaderno CEI n 24-08 - Chiesa Cattolica Italiana
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Riflessioni<br />
conclusive<br />
92<br />
nelle quali si coglie con grande pregnanza la valenza etica della<br />
fede, sembra in agguato la deriva irrazionalistica di un credere tanto<br />
ostinato da rifiutarsi di esibire le proprie ragioni, data l’irriducibilità<br />
della decisione alla sfera noetica. Ma, scavando ancor più in profondità,<br />
resta da sottolineare la radicale differenza fra la consegna-traditio<br />
cristologica e il sacrificio dell’eroe tragico al “generale” o<br />
“sovra-individuale” universo valoriale, di fronte al quale non può<br />
che consapevolmente soccombere. Insomma, e per concludere queste<br />
riflessioni, anche quello etico non è che uno stadio dell’esistenza<br />
credente, che ad esso non si lascia ridurre e da esso non si lascia<br />
catturare, pur includendolo ed inverandolo.<br />
c) Fede come conoscenza, fede e ragione<br />
La tendenza piuttosto classica e tradizionale a individuare il<br />
luogo del credere nella sfera conoscitiva, lungi dal metterne in<br />
ombra la dimensione etica, se si tiene conto del carattere ontologico<br />
del nesso verità-libertà, costituisce tuttavia un terzo possibile<br />
tentativo di interpretazione, che le precedenti prospettive tendono a<br />
relativizzare e/o ad includere. Una koinè culturale, nella quale il<br />
grande nemico sembra l’intellettualismo piuttosto che l’irrazionalismo,<br />
non può che emarginare e negare questa prospettiva, propria<br />
del credere, alimentando piuttosto, anche attraverso una certa attenzione<br />
mediatica ed intraecclesiale, le teologie dell’affettività e<br />
della deliberazione vitale e trascurando, con grande gioia di quanti<br />
hanno grande<br />
Una concezione prismatica dell’atto di fede sembra imporsi,<br />
onde tener conto della complessità del credere e del soggetto chiamato<br />
a vivere ed esprimere la fede stessa, secondo le tre dimensioni<br />
della persona, che nella fede sono chiamate ad interagire e, come<br />
si dice oggi interfacciarsi: conoscenza, affettività, volontà. E la metafora<br />
del prisma indica anche che esse possono diversamente strutturarsi<br />
ed articolarsi, tenendo conto dell’impossibilità, per un atto<br />
che vuol coinvolgere tutta la persona, di eludere qualcuna delle suddette<br />
dimensioni. Ritenere, infatti, che la fede sia un atto personale,<br />
cioè un atto della persona, non significa affermare che esso sia<br />
un atto individuale. E neppure che esso designi soltanto un insieme<br />
di relazioni, perché sappiamo – e la cultura personalista penso ci<br />
appartenga – che la persona è insieme soggetto e relazione (Tommaso<br />
a questo riguardo ha dovuto ricorrere al paradosso della relatio<br />
subsistens).<br />
Uno dei passaggi teoreticamente più rilevanti dell’ultima enciclica,<br />
ci offre uno strumento categoriale e culturale di profondo rilievo,<br />
proprio in ordine al rapporto fra fede / ragione / forme di ra-<br />
5° CONVEGNO DEI CAPPELLANI E DEI RESPONSABILI DIOCESANI