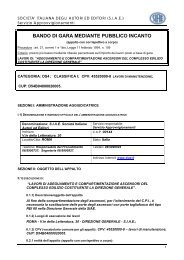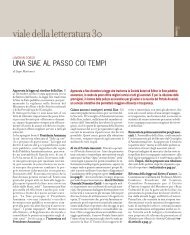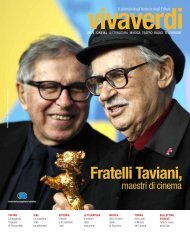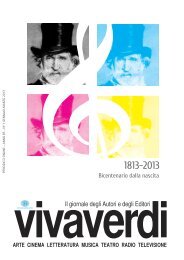You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
A destra Luigi Russolo al Russolophone,<br />
in Alexandre Grenier, Michel Seuphor<br />
Un siècle de libertés. Entretiens avec<br />
Michel Seuphor, Hazan, Paris, 1996<br />
VIVAVERDI<br />
19<br />
FUTURISMO/2<br />
LE SEI FAMIGLIE<br />
DEI RUMORI<br />
di Dario Oliveri<br />
Uno dei risvolti cruciali dell’intervento futurista<br />
era costituito dalla sua volontà di perseguire<br />
un rinnovamento globale dell’esperienza<br />
umana, dall’arte alla vita e viceversa.<br />
Lo dimostrano, per esempio, gli innumerevoli<br />
manifesti pubblicati dopo il 1909: alcuni<br />
davvero sorprendenti, come il Manifesto<br />
futurista della Lussuria, realizzato nel 1913<br />
dalla poetessa francese Valentine de Saint-<br />
Pont; altri semplicemente bizzarri, come il<br />
Manifesto della cucina futurista (1930), in<br />
cui si teorizza “l’abolizione della pastasciutta,<br />
assurda religione gastronomica italiana”<br />
e la creazione di “bocconi simultanei […]<br />
che contengano dieci, venti sapori da gustare<br />
in pochi attimi”; altri, infine, destinati a<br />
diventare pietre angolari della nostra percezione<br />
del moderno. È il caso, per esempio,<br />
del manifesto di Carlo Carrà intitolato<br />
La pittura dei suoni, rumori e odori (11 agosto<br />
1913), che suggerisce l’ipotesi di un rapporto<br />
“da lontano” con il gruppo del Cavaliere<br />
Azzurro di Marc e Kandinskij. Per<br />
quanto riguarda la musica, si segnalano invece<br />
le vibranti declamazioni parolibere di<br />
Marinetti (Battaglia di Adrianopoli, Festa<br />
dei motori di guerra, Battaglia simultanea<br />
di terra mare cielo, etc.), i tre manifesti pubblicati<br />
da Francesco Balilla Pratella fra il 1910<br />
e il 1912, la singolare esperienza dei Balli<br />
plastici di Fortunato Depero, ma soprattutto<br />
i saggi teorici e le opere, sia pittoriche sia<br />
musicali, di Luigi Russolo.<br />
L’idea che possa esistere un’arte dei rumori, o che il rumore possa considerarsi un aspetto<br />
dell’espressione artistica, segna i percorsi di molta musica novecentesca: da Edgar Varèse ad<br />
Aphex Twin, passando per la musique concrète, Stockhausen, i Beatles e il rap. A volerne<br />
rintracciare la genesi, il suo primo e originario apparire, ci si ritrova tuttavia nel bel mezzo del<br />
Futurismo italiano e del suo frenetico tentativo di “ricostruire l’universo” a propria immagine e<br />
somiglianza.<br />
Nato a Lugo di Romagna nel 1880, Pratella<br />
fu “il primo musicista che aderì nel ’10 alla<br />
causa del Futurismo” (D. Nicolodi) e l’autore<br />
di un famoso e controverso Manifesto dei<br />
musicisti futuristi in cui lo slancio antiaccademico<br />
si aggiunge all’aggressione contro<br />
“i grandi editori-mercanti” e “le opere<br />
basse, rachitiche e volgari di Puccini e Giordano”.<br />
Al tempo stesso, e per ragioni che ci<br />
appaiono a dir poco incomprensibili, l’autore<br />
esalta però “i tentativi d’innovazione nella<br />
parte armonica” di Pietro Mascagni e le “tendenze<br />
novatrici” di Sibelius e di Debussy,<br />
mentre condanna Richard Strauss “per<br />
l’aridità, il mercantilismo e la banalità dell’anima<br />
sua” e omette del tutto di considerare<br />
“quello che già bolliva in pentola nell’Europa<br />
musicale del primo Novecento, tra<br />
Parigi, Vienna e Berlino, da Ravel a Erik Satie<br />
e Strawinsky, da Hindemith e Bartók a<br />
Schönberg e alla sua scuola” (L. Rognoni).<br />
Come autore, Pratella è inoltre ricordato per<br />
alcune opere ormai desuete come la sinfonia<br />
Inno alla vita, presentata al Teatro Costanzi<br />
sotto “una pioggia ininterrotta di verdure,<br />
di frutta e castagnacci” (F.B. Pratella),<br />
come il ciclo di danze La guerra (1918) oppure<br />
il dramma in tre atti L’aviatore Dro<br />
(1911-14). Descritto da Mario Labroca come<br />
“un’opera di esasperante dilettantismo,<br />
basata per giunta su un libretto di inverosimile<br />
bruttezza”, il “capolavoro” di Francesco<br />
Balilla Pratella, rappresentato per la prima<br />
volta nel 1920, ebbe il singolare destino<br />
di attirarsi dapprima l’ostilità della critica<br />
fascista (dovuta alla presenza di alcuni episodi<br />
ritenuti scabrosi) e in seguito le riserve<br />
di un autore decisamente legato ai destini<br />
dell’avanguardia europea come Lugi Rognoni,<br />
che malgrado “le didascalie provocatorie<br />
e le ‘violenze’ sceniche” intravede<br />
nell’opera un deplorevole intreccio fra il<br />
“debussismo all’italiana allora dilagante” e<br />
“un tessuto armonico e melodico-vocale di<br />
chiara derivazione verista”.<br />
Ciò premesso, e pur considerando le occasionali<br />
convergenze futuriste di Silvio Mix<br />
(con il balletto Psicologia delle macchine),<br />
di Virgilio Mortari (temporaneamente arruolato<br />
al Teatro della Sorpresa), di Luigi