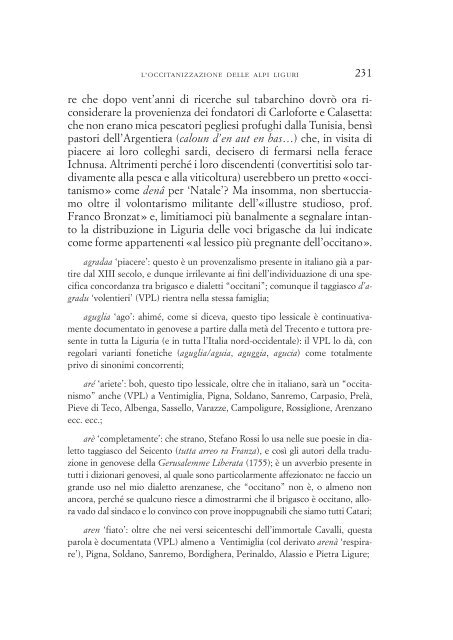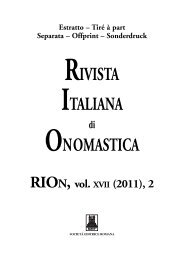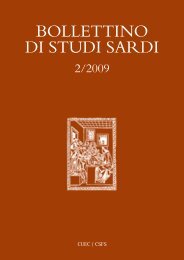L'occitanizzazione delle Alpi Liguri e il caso del brigasco: un ...
L'occitanizzazione delle Alpi Liguri e il caso del brigasco: un ...
L'occitanizzazione delle Alpi Liguri e il caso del brigasco: un ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
L’OCCITANIZZAZIONE DELLE ALPI LIGURI 231<br />
re che dopo vent’anni di ricerche sul tabarchino dovrò ora riconsiderare<br />
la provenienza dei fondatori di Carloforte e Calasetta:<br />
che non erano mica pescatori pegliesi profughi dalla T<strong>un</strong>isia, bensì<br />
pastori <strong>del</strong>l’Argentiera (calo<strong>un</strong> d’en aut en bas…) che, in visita di<br />
piacere ai loro colleghi sardi, decisero di fermarsi nella ferace<br />
Ichnusa. Altrimenti perché i loro discendenti (convertitisi solo tardivamente<br />
alla pesca e alla viticoltura) userebbero <strong>un</strong> pretto «occitanismo»<br />
come denâ per ‘Natale’? Ma insomma, non sbertucciamo<br />
oltre <strong>il</strong> volontarismo m<strong>il</strong>itante <strong>del</strong>l’«<strong>il</strong>lustre studioso, prof.<br />
Franco Bronzat» e, limitiamoci più banalmente a segnalare intanto<br />
la distribuzione in <strong>Liguri</strong>a <strong><strong>del</strong>le</strong> voci brigasche da lui indicate<br />
come forme appartenenti «al lessico più pregnante <strong>del</strong>l’occitano».<br />
agradaa ‘piacere’: questo è <strong>un</strong> provenzalismo presente in italiano già a partire<br />
dal XIII secolo, e d<strong>un</strong>que irr<strong>il</strong>evante ai fini <strong>del</strong>l’individuazione di <strong>un</strong>a specifica<br />
concordanza tra <strong>brigasco</strong> e dialetti “occitani”; com<strong>un</strong>que <strong>il</strong> taggiasco d’agradu<br />
‘volentieri’ (VPL) rientra nella stessa famiglia;<br />
aguglia ‘ago’: ahimé, come si diceva, questo tipo lessicale è continuativamente<br />
documentato in genovese a partire dalla metà <strong>del</strong> Trecento e tuttora presente<br />
in tutta la <strong>Liguri</strong>a (e in tutta l’Italia nord-occidentale): <strong>il</strong> VPL lo dà, con<br />
regolari varianti fonetiche (aguglia/aguia, aguggia, agucia) come totalmente<br />
privo di sinonimi concorrenti;<br />
aré ‘ariete’: boh, questo tipo lessicale, oltre che in italiano, sarà <strong>un</strong> “occitanismo”<br />
anche (VPL) a Ventimiglia, Pigna, Soldano, Sanremo, Carpasio, Prelà,<br />
Pieve di Teco, Albenga, Sassello, Varazze, Campoligure, Rossiglione, Arenzano<br />
ecc. ecc.;<br />
arè ‘completamente’: che strano, Stefano Rossi lo usa nelle sue poesie in dialetto<br />
taggiasco <strong>del</strong> Seicento (tutta arreo ra Franza), e così gli autori <strong>del</strong>la traduzione<br />
in genovese <strong>del</strong>la Gerusalemme Liberata (1755); è <strong>un</strong> avverbio presente in<br />
tutti i dizionari genovesi, al quale sono particolarmente affezionato: ne faccio <strong>un</strong><br />
grande uso nel mio dialetto arenzanese, che “occitano” non è, o almeno non<br />
ancora, perché se qualc<strong>un</strong>o riesce a dimostrarmi che <strong>il</strong> <strong>brigasco</strong> è occitano, allora<br />
vado dal sindaco e lo convinco con prove inoppugnab<strong>il</strong>i che siamo tutti Catari;<br />
aren ‘fiato’: oltre che nei versi seicenteschi <strong>del</strong>l’immortale Cavalli, questa<br />
parola è documentata (VPL) almeno a Ventimiglia (col derivato arenà ‘respirare’),<br />
Pigna, Soldano, Sanremo, Bordighera, Perinaldo, Alassio e Pietra Ligure;