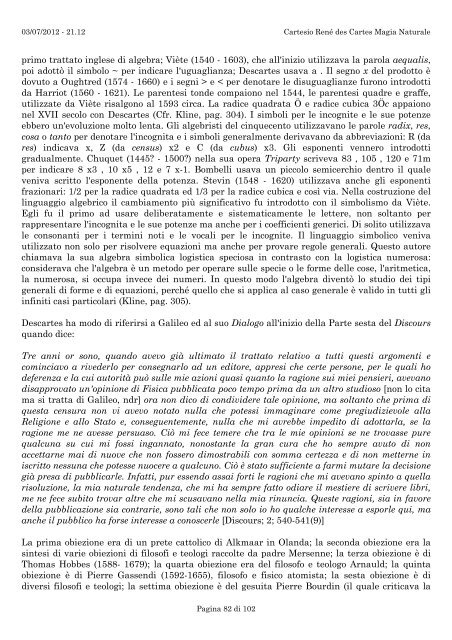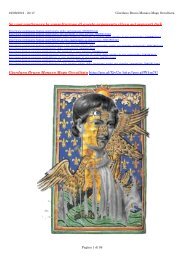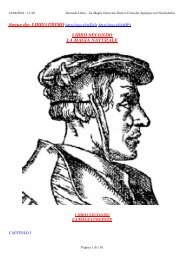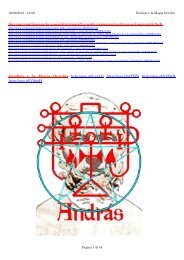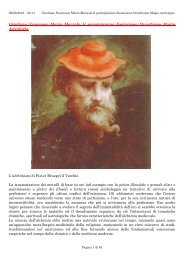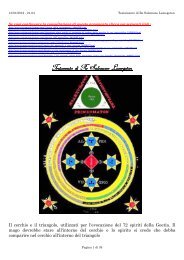Cartesio René des Cartes Magia Naturale
Cartesio René des Cartes Magia Naturale
Cartesio René des Cartes Magia Naturale
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
03/07/2012 - 21.12 <strong><strong>Cartes</strong>io</strong> <strong>René</strong> <strong>des</strong> <strong>Cartes</strong> <strong>Magia</strong> <strong>Naturale</strong><br />
primo trattato inglese di algebra; Viète (1540 - 1603), che all'inizio utilizzava la parola aequalis,<br />
poi adottò il simbolo ~ per indicare l'uguaglianza; Descartes usava a . Il segno x del prodotto è<br />
dovuto a Oughtred (1574 - 1660) e i segni > e < per denotare le disuguaglianze furono introdotti<br />
da Harriot (1560 - 1621). Le parentesi tonde compaiono nel 1544, le parentesi quadre e graffe,<br />
utilizzate da Viète risalgono al 1593 circa. La radice quadrata Ö e radice cubica 3Öc appaiono<br />
nel XVII secolo con Descartes (Cfr. Kline, pag. 304). I simboli per le incognite e le sue potenze<br />
ebbero un'evoluzione molto lenta. Gli algebristi del cinquecento utilizzavano le parole radix, res,<br />
cosa o tanto per denotare l'incognita e i simboli generalmente derivavano da abbreviazioni: R (da<br />
res) indicava x, Z (da census) x2 e C (da cubus) x3. Gli esponenti vennero introdotti<br />
gradualmente. Chuquet (1445? - 1500?) nella sua opera Triparty scriveva 83 , 105 , 120 e 71m<br />
per indicare 8 x3 , 10 x5 , 12 e 7 x-1. Bombelli usava un piccolo semicerchio dentro il quale<br />
veniva scritto l'esponente della potenza. Stevin (1548 - 1620) utilizzava anche gli esponenti<br />
frazionari: 1/2 per la radice quadrata ed 1/3 per la radice cubica e così via. Nella costruzione del<br />
linguaggio algebrico il cambiamento più significativo fu introdotto con il simbolismo da Viète.<br />
Egli fu il primo ad usare deliberatamente e sistematicamente le lettere, non soltanto per<br />
rappresentare l'incognita e le sue potenze ma anche per i coefficienti generici. Di solito utilizzava<br />
le consonanti per i termini noti e le vocali per le incognite. Il linguaggio simbolico veniva<br />
utilizzato non solo per risolvere equazioni ma anche per provare regole generali. Questo autore<br />
chiamava la sua algebra simbolica logistica speciosa in contrasto con la logistica numerosa:<br />
considerava che l'algebra è un metodo per operare sulle specie o le forme delle cose, l'aritmetica,<br />
la numerosa, si occupa invece dei numeri. In questo modo l'algebra diventò lo studio dei tipi<br />
generali di forme e di equazioni, perché quello che si applica al caso generale è valido in tutti gli<br />
infiniti casi particolari (Kline, pag. 305).<br />
Descartes ha modo di riferirsi a Galileo ed al suo Dialogo all'inizio della Parte sesta del Discours<br />
quando dice:<br />
Tre anni or sono, quando avevo già ultimato il trattato relativo a tutti questi argomenti e<br />
cominciavo a rivederlo per consegnarlo ad un editore, appresi che certe persone, per le quali ho<br />
deferenza e la cui autorità può sulle mie azioni quasi quanto la ragione sui miei pensieri, avevano<br />
disapprovato un'opinione di Fisica pubblicata poco tempo prima da un altro studioso [non lo cita<br />
ma si tratta di Galileo, ndr] ora non dico di condividere tale opinione, ma soltanto che prima di<br />
questa censura non vi avevo notato nulla che potessi immaginare come pregiudizievole alla<br />
Religione e allo Stato e, conseguentemente, nulla che mi avrebbe impedito di adottarla, se la<br />
ragione me ne avesse persuaso. Ciò mi fece temere che tra le mie opinioni se ne trovasse pure<br />
qualcuna su cui mi fossi ingannato, nonostante la gran cura che ho sempre avuto di non<br />
accettarne mai di nuove che non fossero dimostrabili con somma certezza e di non metterne in<br />
iscritto nessuna che potesse nuocere a qualcuno. Ciò è stato sufficiente a farmi mutare la decisione<br />
già presa di pubblicarle. Infatti, pur essendo assai forti le ragioni che mi avevano spinto a quella<br />
risoluzione, la mia naturale tendenza, che mi ha sempre fatto odiare il mestiere di scrivere libri,<br />
me ne fece subito trovar altre che mi scusavano nella mia rinuncia. Queste ragioni, sia in favore<br />
della pubblicazione sia contrarie, sono tali che non solo io ho qualche interesse a esporle qui, ma<br />
anche il pubblico ha forse interesse a conoscerle [Discours; 2; 540-541(9)]<br />
La prima obiezione era di un prete cattolico di Alkmaar in Olanda; la seconda obiezione era la<br />
sintesi di varie obiezioni di filosofi e teologi raccolte da padre Mersenne; la terza obiezione è di<br />
Thomas Hobbes (1588- 1679); la quarta obiezione era del filosofo e teologo Arnauld; la quinta<br />
obiezione è di Pierre Gassendi (1592-1655), filosofo e fisico atomista; la sesta obiezione è di<br />
diversi filosofi e teologi; la settima obiezione è del gesuita Pierre Bourdin (il quale criticava la<br />
Pagina 82 di 102