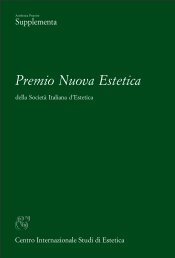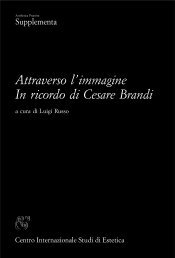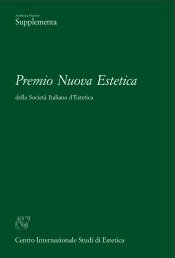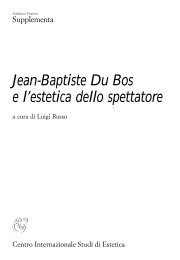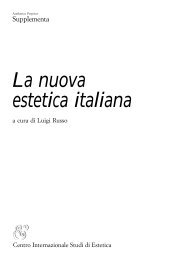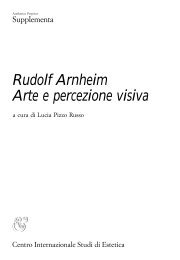imprecisione: le differenze indicate non sembrano tanto recise (prescrizionee verisimiglianza); e così le analogie proposte dovranno in parterimeditarsi.La prima di queste riguarda l’unità d’intenti e fini – con differenzemeno sostanziali che formali – riscontrabile nell’estetica italiana einglese. La proposta è altamente suggestiva; ma sul piano storico è naturalmenteazzardato trarre conclusioni in termini di consonanze intellettualiladdove queste non siano dichiarate o appaiano solo adombrateda circostanze più spesso casuali: posto che in Addison e in Shaftesbury,come assume <strong>Morpurgo</strong>-<strong>Tagliabue</strong>, echeggino motivi presentianche in Muratori, ciò non assicura molto in termini di “simpatia”speculativa fra Italia e Inghilterra. Di fatto Addison aveva una conoscenzapiuttosto limitata <strong>del</strong>la cultura italiana, a quanto attesta il Catalogue<strong>del</strong>la sua biblioteca 20 ; e Shaftesbury, che risiedette stabilmentea Napoli negli ultimi anni di vita, ebbe pochi e sporadici rapporti congli intellettuali <strong>del</strong> luogo e appare tutt’altro che informato <strong>del</strong>le ricercheerudite che vi si andavano svolgendo presso il circolo dei Cartesiani,ad esempio, o l’Accademia degli Investiganti. In termini “paralleli”a quelli formulati da <strong>Morpurgo</strong>-<strong>Tagliabue</strong>, vorrei dire che, se purenel <strong>Settecento</strong> vi fu certo un risveglio d’interesse per l’Italia e la suacultura, testimoniato anche dal numero e dalle presenze di viaggiatoriinglesi, a quell’interesse fu tuttavia estranea la cultura italiana coeva.<strong>Morpurgo</strong>-<strong>Tagliabue</strong> insiste sulle analogie dottrinali solo superficialmenteoccultate da divergenze riconducibili a «sapienza retorica» e«competenza stilistica», specialità italiche <strong>del</strong> tutto assenti in Inghilterra,ove l’azione <strong>del</strong>la filosofia empiristica aveva piuttosto sviluppatoun’«attitudine alla riflessione» (p. 130); e lo studioso addita nelle rispettiveipostasi <strong>del</strong> «gentleman» e <strong>del</strong> «dotto» tutta la differenza fra le teorie<strong>del</strong> gusto elaborate nei due Paesi (p. 132). Il gusto degli Inglesi edegli Italiani differiva però nel concreto non meno che nell’astratto; el’indagine teorica sul gusto in corso in Italia poteva giungere solo pocopiù che flebilmente all’orecchio degli Inglesi, essendo diverso il lorogusto nella pratica. Gli Inglesi rimasero piuttosto insensibili a quantosul piano artistico e letterario venne producendosi in Italia già a partiredalla seconda metà <strong>del</strong> Seicento e per gran parte <strong>del</strong> <strong>Settecento</strong>.L’attrazione su di loro esercitata dall’arte italiana andava poco oltreMichelangelo e Raffaello; essi amavano assai più Rembrandt, Poussin,Claude, gli Olandesi che non Caravaggio, Reni, Pietro da Cortona oSalvator Rosa. Shaftesbury commentò piuttosto duramente l’arte barocca,definendo Bernini «un apostata <strong>del</strong>la statuaria»; Annibale Carracciun imitatore di imitatori, pittore di «seconda mano» poco «immediato»e «originale»; Caravaggio un divulgatore di «brutte figure»in uno stile «ferino» e «agli antipodi <strong>del</strong>la grazia»; Reni un artista la cuiperizia non andava oltre «le air de tête» 21 . Gli Inglesi avevano la sen-30
sazione, certo non infondata, che l’arte italiana <strong>del</strong> XVIII secolo fossein declino 22 . Sempre Shaftesbury lamentava che fra Napoli e Romanon vi fosse modo di reperire disegnatori bravi ed esperti nell’antico 23 ;e certo un indizio di sfiducia nei confronti degli artisti a lui contemporaneioffre ancora la sua meticolosa Notion of the Historical Draught,che ben poco spazio lascia all’inventiva di De Matteis. Anche Reynolds,in viaggio in Italia per completare il suo tirocinio artistico, rifiutò d’incontrarsia Roma con Pompeo Batoni, convinto di non aver nulla daimparare dal pittore italiano 24 ; e considerava Carlo Maratti privo di«grande vigoria d’intelletto o forte originalità di genio» 25 . A sua volta,Hogarth, come poi anche Constable, in Italia non volle neppure venire;e la quasi totale assenza di nomi italiani nel suo trattato sull’artevale quanto una presenza negativa, ove si tenga conto che vi sonoinvece nominati Rubens, Poussin, Le Brun e altri pittori a lui più omeno contemporanei. Del resto, i pittori nordici che nella secondametà <strong>del</strong> <strong>Settecento</strong> fondarono a Roma il cenacolo riunito al Caffè degliInglesi a Piazza di Spagna – includente fra gli altri James Northcote,George Romney, James Barry, John Brown, Benjamin West e Füssli –vissero notoriamente «in isolamento quasi claustrofobico dall’ambienteartistico circostante»; e «durissimi» erano a volte per loro questo isolamentoe la connessa «lotta per la sopravvivenza» 26 .Aggiungo infine un’ultima osservazione su un punto già sollevatoda altri relatori: intendo il modo rapido, quasi brusco, con cui <strong>Morpurgo</strong>-<strong>Tagliabue</strong>esaurisce l’estetica di Shaftesbury in poche pagine,oltretutto assai poco lusinghiere; circostanza ancora più singolare ovesi consideri che al contrario egli dedica a Addison una trattazione altrettantoestesa, ed elogiativa in termini d’importanza e dovizia teorica,di quelle riservate a Hume e Burke.Il fatto esige qui una spiegazione, che credo possa trovarsi in quell’atteggiamentopolemico nei confronti di Croce cui pure s’è già accennatonel corso di questo incontro. Prima ancora che a Croce, però,occorre risalire a George Saintsbury, un critico letterario che di Shaftesburytracciò un ritratto intellettuale assai impietoso. Dopo avernedrasticamente ridimensionato l’intelligenza letteraria e critica, nella suafortunata History of Criticism <strong>del</strong> 1900-04 Saintsbury rileva che il tonodegli scritti shaftesburiani è quello di chi vuol imporsi non solo comegentiluomo e «persona di qualità», ma anche come «filosofo <strong>del</strong>lamassima profondità (oltre che assoluta eleganza esteriore)» e «scrittoredi consumata originalità e agudeza»; tuttavia, il filosofo-virtuoso nonandrebbe oltre una «pedante volgarità travestita da superciliosità allamoda». Un simile atteggiamento, afferma Saintsbury, ha affascinatomolti, non mancando però d’indurre altri a giudicare Shaftesbury, dalpunto di vista intellettuale, o un ciarlatano o un coxcomb, un «dame-31
- Page 1 and 2: Aesthetica PreprintGuido Morpurgo-T
- Page 4 and 5: Guido Morpurgo-Tagliabuee l’estet
- Page 6 and 7: Un marziano in esteticadi Luigi Rus
- Page 8 and 9: sava candidamente - nel pianificare
- Page 10 and 11: che onora la cultura italiana, si p
- Page 12 and 13: grafia estetica era stato dominato
- Page 14 and 15: sciuto di Morpurgo e che ha avuto f
- Page 16 and 17: Morpurgo-Tagliabuee l’estetica in
- Page 18 and 19: e l’estetica idealista italiana m
- Page 20 and 21: queste due «novità fondamentali»
- Page 22 and 23: 4Pubblicati rispettivamente in “R
- Page 24 and 25: un’estetica piuttosto articolata
- Page 26 and 27: Non desidero limitarmi a rilevare l
- Page 30 and 31: ino»; e la seconda accusa, conclud
- Page 32 and 33: scinanti, perché rappresentano pi
- Page 34 and 35: Morpurgo-Tagliabuee l’estetica de
- Page 36 and 37: pensava soprattutto al fatto che il
- Page 38 and 39: apprende l’armonia della musica.
- Page 40 and 41: dal punto di vista del fruire: […
- Page 42 and 43: Bodmer riportava larghi estratti de
- Page 44 and 45: Morpurgo-Tagliabuee l’estetica it
- Page 46 and 47: de quella stagione determinata, dal
- Page 48 and 49: che «in pratica dal giudicio dell
- Page 50 and 51: che agguaglino la forza degli origi
- Page 52 and 53: Perfetta poesia, e cioè quando Mur
- Page 54 and 55: 28Ibid., p. 63.29G. B. Gravina, De
- Page 56 and 57: è l’incrocio Gravina-Vico operat
- Page 58 and 59: classe nell’individuo, il quale,
- Page 60 and 61: Siano qui sufficienti alcuni cenni:
- Page 62 and 63: Implicazioni del nessotra gusto e g
- Page 64 and 65: gusto abbia statuto catacretico e i
- Page 66 and 67: espresso dall’effetto. Da un lato
- Page 68 and 69: modello del significare segnico in
- Page 70 and 71: ne» 3 . Scrive Morpurgo-Tagliabue
- Page 72 and 73: mento che quest’ultima implica un
- Page 74 and 75: do Morpurgo-Tagliabue gusto e giudi
- Page 76 and 77: conseguenza possiamo identificare u
- Page 78 and 79:
1Guido Morpurgo-Tagliabue, Il conce
- Page 81 and 82:
Guido Morpurgo-Tagliabue:le sublime
- Page 83 and 84:
son assimilation ultime à l’él
- Page 85 and 86:
pective, comparer à celle de Giamb
- Page 87 and 88:
(3) Cet idéal de beauté féminine
- Page 89 and 90:
hors de l’écheveau complexe du v
- Page 91 and 92:
Prendre le parti d’un tableau pr
- Page 93 and 94:
tion» sur laquelle insiste Wittgen
- Page 95 and 96:
Mais le problème est de ne pas se
- Page 97 and 98:
33 Ricercari Nowau. Una forma di or