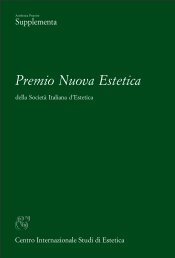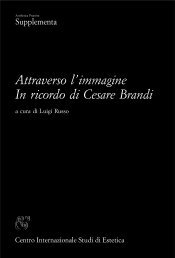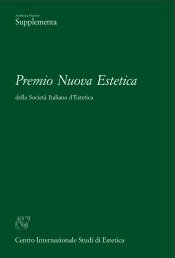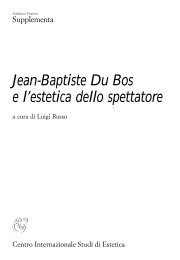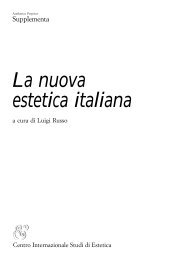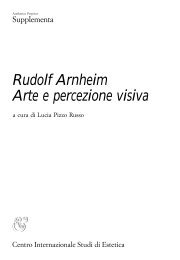Guido Morpurgo-Tagliabue e l'estetica del Settecento - SIE - Società ...
Guido Morpurgo-Tagliabue e l'estetica del Settecento - SIE - Società ...
Guido Morpurgo-Tagliabue e l'estetica del Settecento - SIE - Società ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
dem). La matrice kantiana sopra ricordata non pregiudica la originalità<strong>del</strong> contesto speculativo <strong>del</strong>l’analisi morpurghiana, al cui centro restala questione <strong>del</strong>la predicabilità, e la connessa funzione semantica.Ed è in rapporto a ciò che assume importanza lo scarto tra proposizioniobiettivanti (determinanti) e proposizioni che traducono in presenzagli effetti estetici divenendo esse stesse sviluppo e articolazione <strong>del</strong>l’esperienza,momenti di tali effetti, anziché determinazioni cosali inscrittenella logica <strong>del</strong>la predicazione.5. Nella fenomenologia morpurghiana gusto e giudizio diventanomomenti <strong>del</strong>la relazione di senso sottesa all’esperienza <strong>del</strong>l’arte, essendoil primo indice di Kunstwert e il secondo riconoscimento di un Kunstsein,laddove «vi può essere Kunstwert senza Kunstsein, ma nonKunstsein senza Kunstwert: “senso” senza significato, ma non “significato”senza senso» (ivi, p. 214). Tale individuazione in gusto e giudiziodi momenti complementari <strong>del</strong>la relazione semantica rende comprensibilela loro successione nello sviluppo <strong>del</strong>l’esperienza estetica, equindi rende pertinente anche la stessa classificazione <strong>del</strong>le modalità(determinante/riflettente) <strong>del</strong> giudizio che risalgono a due sorte di nozioni,di cui «le prime sono clausole costitutive e quindi normativesotto le quali l’oggetto va sussunto, le ultime sono constatazioni diprincipi regolativi che si limitano a guidare le scelte dei gusti» (ivi, p.224). Appare chiaro che solo il coinvolgimento <strong>del</strong> gusto – per quantoin sé problematico poiché sottrae determinabilità – garantisce all’esperienzaestetica la sua intrinseca e plurale ricchezza. Esso infatti implicail riconoscimento <strong>del</strong>la priorità <strong>del</strong> senso (o, per <strong>Morpurgo</strong>, <strong>del</strong>valore) e <strong>del</strong>la sua efficacia quale orizzonte che circoscrive la determinazionedei significati («contrariamente alla tendenza invalsa di privilegiareil momento classificatorio e normativo <strong>del</strong> discorso, possiamoparlare di una priorità <strong>del</strong> Kunstwert sul Kunstsein»; ivi, p. 221). Perconverso, la esclusione di un fattore di complessità qual è il gusto rendemeccanico e schematico il processo cui obbediscono i giudizi determinantiin quanto atti di mero riferimento denotativo e di classificazionenormativa.6. La “riflessività” che il giudizio critico acquisisce in conseguenza<strong>del</strong>la sua continuità con il gusto sposta il fuoco <strong>del</strong>la significatività dalcorrelato obiettivo alla correlazione soggettuale-oggettuale, ossia dall’oggettoall’effetto estetico, senza ricadere in forme di soggettivismopsicologista. Il territorio così dischiuso è caratterizzato dalla sospensione<strong>del</strong> riferimento predicativo, senza però che venga meno qualunqueprincipio vincolante di senso. Semmai le dinamiche di senso qui vigentiappaiono basate sulla reciprocità tra dimensione soggettuale e dimensioneoggettuale, e si sedimentano nel singolare strato costitutivo70