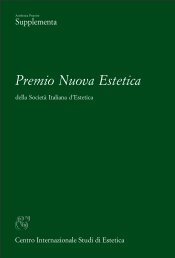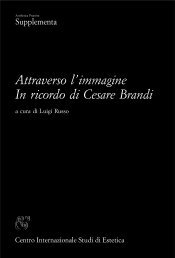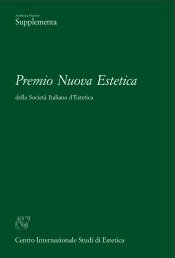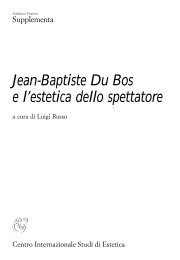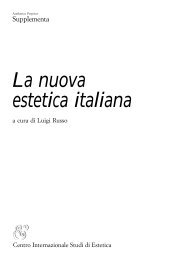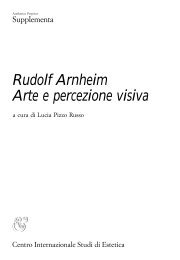Guido Morpurgo-Tagliabue e l'estetica del Settecento - SIE - Società ...
Guido Morpurgo-Tagliabue e l'estetica del Settecento - SIE - Società ...
Guido Morpurgo-Tagliabue e l'estetica del Settecento - SIE - Società ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
che costituisce norma» 27 . A questo punto <strong>Morpurgo</strong> esibisce le condizionidi possibilità <strong>del</strong>l’essere esemplare e, inclusivamente, <strong>del</strong> giudiziosingolare:3 – «l’unico modo per un oggetto singolare di essere criterio autonormativo,in sede di giudizio, è di essere paradigmatico» 28 . Per <strong>Morpurgo</strong>un paradigma è una classe a un solo esemplare: se l’esempio èuna singolarità, e dunque non un universale, non un ente di ragione,ma questa cosa, che può stare per, che vale per i casi di una classe conesso coincidente, il paradigma è la singolarità in quanto si esibisce (simostra qui accanto: paravdeivknumi) come valore, e può mostrarsi comevalore in quanto ha un potere di virtualità, cioè è «matrice potenzialedi possibili esemplari» 29 . Il paradigma svolge, nella teoresi di<strong>Morpurgo</strong>, alcune funzioni connesse: esplicita il carattere di mo<strong>del</strong>lo,quindi unico e obbligante, <strong>del</strong>l’esempio, e approfondisce, articola echiarisce il carattere paradossale <strong>del</strong> giudizio di gusto: il riconoscimento<strong>del</strong> paradigma ne implica la preferibilità, ma tale preferibilità nonesiste come regola, criterio o classe materiale, poiché la classe <strong>del</strong> paradigmaè inestesa («non esiste una struttura che definisca la classedegli oggetti paradigmatici» 30 ). Dunque se da un lato «Non vi è paradigmaprima <strong>del</strong>la scelta» 31 , d’altro lato «il “preferibile”, cioè il “preferitoobbligatorio”» 32 è precisamente il paradigmatico. Ora il giudiziodi gusto, individuale, singolare coglie paradigmi: «Un paradigmainfatti non è che una norma di scelta, messa in atto su un esemplareunico, con il quale coincide, ma che si estende virtualmente a una possibilitàindefinita di esemplari. Un esemplare-mo<strong>del</strong>lo. Come tale lasua proprietà monotetica non è mai dissociabile da un suo contenutoindividuale» 33 .Ora la nozione di paradigma ha lo scopo di non fare assorbire compiutamentela classe nell’individuo; è uno scopo che emerge nel saggio<strong>del</strong> ’67 L’esperienza estetica: «Dobbiamo dire quindi che la rappresentazioneartistica non offre semplicemente l’esemplare di una classe, unafunzione proposizionale, anche se evoca o rappresenta esemplari diclassi estensivamente [...] e nemmeno, al contrario, fa scomparire laclasse nell’individuo, connotativamente: due processi che si incontranonell’esperienza normale. Il primo corrisponde all’uso linguistico deinomi comuni, il secondo dei nomi propri e dei pronomi» 34 . Questosmarcamento dall’individuo, che segue l’identificazione tra senso filosofico<strong>del</strong> nome proprio e <strong>del</strong> pronome 35 , apre forse a una nuova fase<strong>del</strong> pensiero di <strong>Morpurgo</strong> che qui non interessa seguire. Rimanendoinvece vicini al dettato dei saggi dei primi anni sessanta, si potrebbemostrare come sia proprio un approfondimento <strong>del</strong>l’individuo che permettedi cogliere la densità, virtualmente infinita (e distesa, io credo,non solo nel futuro ma in ogni tempo), <strong>del</strong>la nozione di paradigma.63