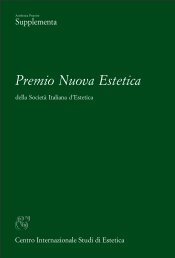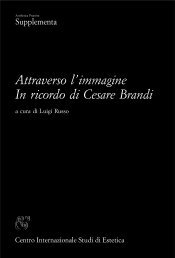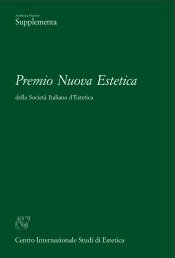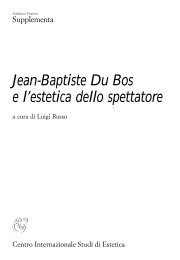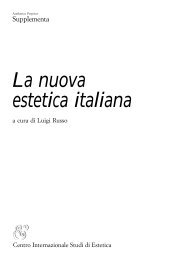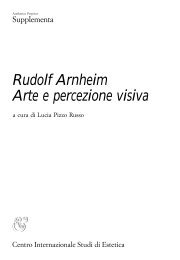Perfetta poesia, e cioè quando Muratori sta formulando la teoria, perlui così decisiva, <strong>del</strong>la minuta osservazione, su cui <strong>Morpurgo</strong>-<strong>Tagliabue</strong>ha tanto richiamato l’attenzione. Muratori si richiama alla dottrina longinianae quintilianea <strong>del</strong>l’evidenza o enargeia, che, ricorda ancora ilMuratori, «acconciamente il nostro Castelvetro chiamò Particolarizzazione»31 . Ebbene, a giudizio di Castelvetro a tal proposito Omero sarebbesenz’altro superiore a Virgilio, che appunto si tiene per lo più«nella loro esposizione universale, e corta»; polemizzando con Castelvetro,Muratori avanza invece l’idea che qui si debba semplicementericonoscere che Virgilio «volle camminar per altro sentiero», attenendosial «proprio Stile».Lo stesso concetto di “maniera particolareggiata” o di “minuta osservazione”permette poi a Muratori un’altra apertura davvero notevole,da cui i suoi lettori tedeschi, da Bodmer e Breitinger sino alla scuoladi Baumgarten e direi a Men<strong>del</strong>ssohn, trarranno conseguenze decisive.Gravina, come abbiamo visto sia pur di sfuggita, si richiamavaesplicitamente al concetto cartesiano di ragione, coordinato al criterio<strong>del</strong>la chiarezza e distinzione. Se vogliamo guardare per un attimo allestrategie generali <strong>del</strong> discorso filosofico, implicite in questa poetica,possiamo allora dire che le nozioni di artificio e di finzione, da unlato, e la teorizzazione <strong>del</strong> <strong>del</strong>irio, dall’altro, erano dunque necessarieper intendere la ragione poetica in una cornice che pur sempre facevariferimento prioritario all’attività <strong>del</strong>l’intelletto: motivo in più perargomentare una continuità, su questo punto decisivo, con l’ispirazionerazionalistica <strong>del</strong>le poetiche <strong>del</strong> Barocco. Muratori, viceversa, nonesita a contrapporsi, oltre che a Tesauro, allo stesso Aristotele (che adogni modo è l’Aristotele di Tesauro), per riferire senz’altro al campo<strong>del</strong>la sensibilità, <strong>del</strong>la fantasia, i prodotti <strong>del</strong>l’attività metaforica. Valela pena di riportare un breve passo <strong>del</strong>l’argomentazione di Muratori:«Le simiglianze, che l’Intelletto osserva tra gli oggetti, e che servonoalla Fantasia per formarne qualche Immagine, o Metafora, debbonoesser tali, che da gli Uditori tosto, o almen senza molta meditazione,e fatica, s’abbiano da poter ravvisare, e intendere» 32 .Potrebbe sembrare, a prima vista, di esser davvero a un passo daquella congiunzione fra sensibilità e conoscenza intuitiva su cui, perfare un solo esempio, Lessing baserà la sua teoria <strong>del</strong>la favola nel1759. Basta poco, tuttavia, per ritrovare anche qui il razionalismo muratorianoe per scoprire anche qui i motivi che separano Muratori dallagrande stagione <strong>del</strong>l’estetica illuministica europea: le somiglianze,per Muratori, devono soltanto essere intese senza molta fatica, ma essevengono comunque conosciute, scoperte, dall’intelletto; per mezzo <strong>del</strong>lafantasia le somiglianze trovano meramente una veste sensibile. Eccocome Muratori descrive il viaggio che la nostra attività conoscitivacompie per formulare un’immagine fantastica: «Scopertasi dall’Intellet-55
to qualche corrispondenza o somiglianza fra due oggetti, se ne formauna Immagine vera Intellettuale […]. Questa Immagine medesima,che come ognun vede è verissima a dirittura, può abbracciarsi posciadalla Fantasia, e divenire Immagine Fantastica» 33 .Ancora una volta, secondo le coordinate indicate in modo insuperatoda <strong>Morpurgo</strong>-<strong>Tagliabue</strong>, l’impianto prescrittivo e la sudditanzanei confronti <strong>del</strong> mo<strong>del</strong>lo barocco impediscono a Muratori di coglieretutta la ricchezza di aperture teoriche che altrove troveranno il terrenopiù fertile per maturare in una rinnovata retorica filosofica.1G. <strong>Morpurgo</strong>-<strong>Tagliabue</strong>, Il Gusto nell’estetica <strong>del</strong> <strong>Settecento</strong>, “Aesthetica Preprint: Supplementa,”11, 2002, p. 11.2Ivi.3Un’ottima “istantanea” sullo stato <strong>del</strong>l’arte a tal proposito si trova nel saggio di E.Bellini, Il vero e il falso dei poeti in Lodovico Antonio Muratori, nell’importante volume di C.Scarpati, E. Bellini, Il vero e il falso dei poeti. Tasso Tesauro Pallavicino Muratori, Milano1990, pp. 191-233; a questo testo si rinvia per gli ulteriori riferimenti bibliografici.4Ibid., specie pp. 216-20.5È questa la tesi che cerco di argomentare nel mio studio sul Barocco italiano, Le sirene<strong>del</strong> Barocco, di prossima pubblicazione (“Aesthetica Preprint”, 68, Agosto 2003).6Si cfr. in questa direzione il cap. I, x, <strong>del</strong>la Perfetta poesia italiana di Muratori.7E. Bellini, Il vero e il falso dei poeti in Lodovico Antonio Muratori, cit., p. 196.8Ivi.9Cfr. in proposito il recente R. Christoph, Imparare godendo, Neuried 2000.10Questione alla quale, ovviamente, si può qui solo accennare; in Italia lo studioso chene ha tratto le implicazioni più significative è notoriamente Emilio Mattioli. Mi permettoinoltre di rinviare, per alcuni sondaggi, ai miei lavori su Breitinger (S. T., Breitinger e l’estetica<strong>del</strong>l’Illuminismo tedesco, “Aesthetica Preprint: Supplementa”, 1, Palermo 1997) e su Baumgarten(S. T., L’estetica di Baumgarten, “Aesthetica Preprint: Supplementa”, 6, Palermo 2000),e al mio studio sul Barocco italiano, cui prima ho fatto riferimento.11G. <strong>Morpurgo</strong>-<strong>Tagliabue</strong>, Anatomia <strong>del</strong> Barocco, cit., p. 84.12G. <strong>Morpurgo</strong>-<strong>Tagliabue</strong>, Il Gusto nell’estetica <strong>del</strong> <strong>Settecento</strong>, cit., p. 38.13Ibid., p. 39.14Chr. Wolff, Psychologia empirica, Franckfurt und Leipzig 1738, ristampa anastaticaHildesheim 1968. Nel seguito cito il paragrafo direttamente nel testo. Questi problemi sonoora ripresi nel lavoro di P. Kobau, La fallacia <strong>del</strong>l’analogon rationis, in “Rivista di estetica”,n. s., 19 (1/2002), XLII, pp. 11-35.15M. Pellegrini, Delle acutezze, nuova edizione Torino 1997, p. 35.16L. A. Muratori, Della perfetta poesia italiana, a cura di A. Ruschioni, Milano, 2 voll.1971-72.17G. <strong>Morpurgo</strong>-<strong>Tagliabue</strong>, Il Gusto nell’estetica <strong>del</strong> <strong>Settecento</strong>, cit., p. 54.18L. A. Muratori, Della perfetta poesia italiana, cit., p. 286.19Cfr. E. Tesauro, Il Cannocchiale aristotelico, Torino 1670, ristampa anastatica Savigliano2000, p. 82.20L. A. Muratori, Della perfetta poesia italiana, cit., p. 322.21Ibid., p. 292.22Ibid., p. 208.23G. <strong>Morpurgo</strong>-<strong>Tagliabue</strong>, Il Gusto nell’estetica <strong>del</strong> <strong>Settecento</strong>, cit., p. 56.24G. B. Gravina, Della ragion poetica libri due, in Idem, Scritti critici e teorici, Bari 1973,p. 199.25Ibid., p. 202.26Ibid., p. 255.27G. <strong>Morpurgo</strong>-<strong>Tagliabue</strong>, Il Gusto nell’estetica <strong>del</strong> <strong>Settecento</strong>, cit., p. 59.56
- Page 1 and 2: Aesthetica PreprintGuido Morpurgo-T
- Page 4 and 5: Guido Morpurgo-Tagliabuee l’estet
- Page 6 and 7: Un marziano in esteticadi Luigi Rus
- Page 8 and 9: sava candidamente - nel pianificare
- Page 10 and 11: che onora la cultura italiana, si p
- Page 12 and 13: grafia estetica era stato dominato
- Page 14 and 15: sciuto di Morpurgo e che ha avuto f
- Page 16 and 17: Morpurgo-Tagliabuee l’estetica in
- Page 18 and 19: e l’estetica idealista italiana m
- Page 20 and 21: queste due «novità fondamentali»
- Page 22 and 23: 4Pubblicati rispettivamente in “R
- Page 24 and 25: un’estetica piuttosto articolata
- Page 26 and 27: Non desidero limitarmi a rilevare l
- Page 28 and 29: imprecisione: le differenze indicat
- Page 30 and 31: ino»; e la seconda accusa, conclud
- Page 32 and 33: scinanti, perché rappresentano pi
- Page 34 and 35: Morpurgo-Tagliabuee l’estetica de
- Page 36 and 37: pensava soprattutto al fatto che il
- Page 38 and 39: apprende l’armonia della musica.
- Page 40 and 41: dal punto di vista del fruire: […
- Page 42 and 43: Bodmer riportava larghi estratti de
- Page 44 and 45: Morpurgo-Tagliabuee l’estetica it
- Page 46 and 47: de quella stagione determinata, dal
- Page 48 and 49: che «in pratica dal giudicio dell
- Page 50 and 51: che agguaglino la forza degli origi
- Page 54 and 55: 28Ibid., p. 63.29G. B. Gravina, De
- Page 56 and 57: è l’incrocio Gravina-Vico operat
- Page 58 and 59: classe nell’individuo, il quale,
- Page 60 and 61: Siano qui sufficienti alcuni cenni:
- Page 62 and 63: Implicazioni del nessotra gusto e g
- Page 64 and 65: gusto abbia statuto catacretico e i
- Page 66 and 67: espresso dall’effetto. Da un lato
- Page 68 and 69: modello del significare segnico in
- Page 70 and 71: ne» 3 . Scrive Morpurgo-Tagliabue
- Page 72 and 73: mento che quest’ultima implica un
- Page 74 and 75: do Morpurgo-Tagliabue gusto e giudi
- Page 76 and 77: conseguenza possiamo identificare u
- Page 78 and 79: 1Guido Morpurgo-Tagliabue, Il conce
- Page 81 and 82: Guido Morpurgo-Tagliabue:le sublime
- Page 83 and 84: son assimilation ultime à l’él
- Page 85 and 86: pective, comparer à celle de Giamb
- Page 87 and 88: (3) Cet idéal de beauté féminine
- Page 89 and 90: hors de l’écheveau complexe du v
- Page 91 and 92: Prendre le parti d’un tableau pr
- Page 93 and 94: tion» sur laquelle insiste Wittgen
- Page 95 and 96: Mais le problème est de ne pas se
- Page 97 and 98: 33 Ricercari Nowau. Una forma di or